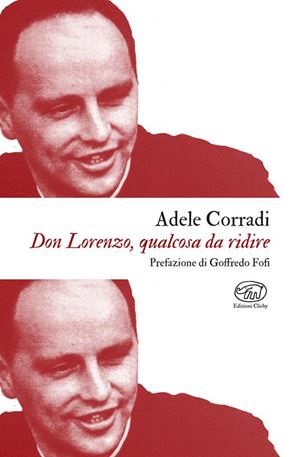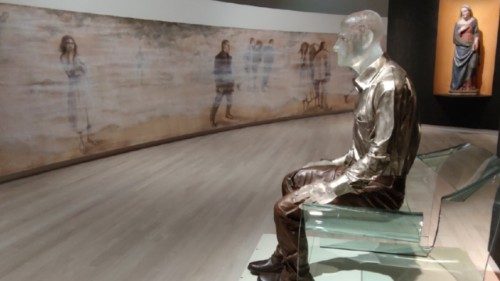Settimana News
Per comprendere davvero la passione, dobbiamo risalire alle sue radici più profonde. Ogni passione, come un torrente che sgorga dall’alto delle montagne, porta con sé la forza di ciò che nasce lontano, nel cuore stesso dell’essere. Più un’esperienza interiore viene da lontano – cioè dalle profondità della persona – più energia racchiude.
La passione nasce dunque dal nucleo più intimo della nostra identità. Ogni creatura è orientata verso ciò che percepisce come bene, perché è fatta per questo: per cercare e realizzare ciò che la compie. Potremmo dire che l’essere, nella sua verità, è strutturalmente rivolto al bene.
Se consideriamo questa realtà nella sua unicità, la chiamiamo “essenza”; se invece la guardiamo nel suo dinamismo, nella sua capacità di agire e tendere al bene, parliamo di “natura”. Queste sono categorie filosofiche utili, ma nella concretezza della vita esse coincidono: siamo ciò che facciamo e agiamo perché siamo.
La natura, in questo senso, è la nostra energia originaria, il motore interiore che ci muove. Questo slancio verso il bene, questa tensione profonda che ci spinge a vivere, amare, costruire, è ciò che possiamo chiamare appetito originario, presente in tutti gli esseri viventi secondo la loro natura.
Quando questa spinta si incarna in una persona concreta, con la sua storia, i suoi limiti e le sue potenzialità, prende la forma di inclinazioni: forze interiori naturali, che variano a seconda del temperamento, della personalità, del vissuto. Le inclinazioni diventano desideri quando si orientano verso oggetti o fini specifici, influenzati dalle circostanze e dalle emozioni del momento.
E la passione? La passione è un desiderio che ha assunto una forma intensa, duratura, profonda. Non è un fuoco passeggero, ma una fiamma che arde nel tempo: un impulso che permane e si ripresenta con forza, anche in modo intermittente, oscillando tra slanci attivi e momenti di quiete affettiva.
Nel cammino della nostra interiorità, la passione si colloca in una zona fluida e mobile, dove si incontrano desiderio, emozione e sentimento. A volte la passione è più simile a un’emozione che travolge, altre volte si accosta al sentimento profondo e stabile, altre ancora prende la forma di un desiderio che cerca di incarnarsi nell’azione. In ogni caso, la passione non è mai neutra: è sempre coinvolgente, totalizzante, e chiede ascolto, discernimento, integrazione.
Per questo, più che un semplice impulso da reprimere o assecondare, la passione può diventare una via spirituale. È un linguaggio dell’anima che, se accolto e purificato, può rivelarci il nostro vero desiderio di bene, di verità, di bellezza. La passione, infatti, è ambivalente: può diventare distruttiva se resta cieca e incontrollata, ma può anche essere trasformata in energia creativa e spirituale, capace di orientare l’intera persona verso la sua piena fioritura.
La passione è uno stato affettivo profondo, che oscilla tra desiderio, emozione e sentimento, e che persiste nel tempo con una forza che può diventare cammino di autenticità e libertà.
La passione come forza interiore totalizzante
La passione è una forma di energia affettiva intensa e persistente, capace di attrarre a sé l’intero mondo interiore della persona. Si impone come un centro gravitazionale dell’anima, capace di oscurare o assorbire ogni altro sentimento, pensiero o desiderio che non sia coerente con il suo oggetto. In questo senso, la passione non è solo un’emozione forte: è una struttura psichica che coinvolge in profondità la mente, il cuore e il corpo.
Essa nasce da un desiderio, si struttura attorno a un’idea dominante, si nutre di attenzione costante e modella i comportamenti, le scelte e perfino l’identità di chi la vive. Ogni passione, infatti, si radica in una conoscenza affettiva, in una forma di consapevolezza profonda che orienta la persona verso un oggetto vissuto come necessario, desiderabile, totalizzante. Come insegna la tradizione spirituale: nulla si può volere, se prima non lo si conosce. È la luce (o l’illusione) di un’idea che rende possibile il fuoco di una passione.
La passione tende a organizzare tutta la vita attorno a sé. Ogni pensiero che la alimenta rafforza il sentimento; ogni atto compiuto in sua funzione conferma la sua centralità; e questa ripetizione rende la passione sempre più radicata. È un circuito affettivo-cognitivo che si autoalimenta: l’idea si incarna, il desiderio si consolida, l’abitudine si struttura. Nel bene o nel male, la passione non lascia nulla indifferente: costruisce o distrugge, trasfigura o consuma.
Per questo, nel cammino umano e spirituale, la passione è un crocevia delicato. È un fuoco, e come ogni fuoco, può scaldare o bruciare. Quando la passione è orientata a un bene autentico, e vissuta con libertà interiore e maturità spirituale, essa può diventare forza creativa, amore oblativo, vocazione incarnata. Ma quando è centrata sull’ego, sull’appropriazione, sulla compensazione del vuoto interiore, allora la passione si trasforma in dipendenza affettiva, idolatria, dominio, chiusura.
La chiave per abitare questo fuoco non è la repressione, ma il discernimento. La persona umana possiede una libertà che può decidere: può accogliere o respingere una passione, nutrirla o disinnescarla, trasformarla o lasciarsene distruggere.
La passione non è destino, ma chiamata al governo di sé. Essa può essere un’energia che apre al dono, oppure una forza che ci ripiega su noi stessi.
Nel profondo, ogni passione chiede di essere redenta e orientata. Solo l’amore per il Bene più grande, solo la relazione viva con Dio, può raccogliere e ordinare tutte le forze interiori senza deformarle. Solo Dio può essere l’oggetto di una passione che non delude, perché solo Dio può abitare tutta la nostra mente, tutta la nostra anima e tutte le nostre forze, senza schiacciarle, ma liberandole. Come dice il Vangelo: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze» (Mc 12,30). Questa è la vera passione spirituale: non la perdita di sé, ma l’unificazione dell’essere nella luce dell’Amore.
Libertà e passioni
Nel percorso umano, le passioni — cioè le emozioni forti, intense, capaci di orientare la nostra vita — non sorgono mai in modo totalmente automatico o cieco. Esse nascono e crescono solo se trovano accoglienza e complicità nella nostra libertà interiore.
Le passioni nascono quando un desiderio, inizialmente spontaneo e fugace, diventa stabile. E questo avviene solo se la nostra mente lo tiene vivo: se lo pensiamo spesso, se lo nutriamo con immagini, fantasie, ricordi, decisioni. In questo senso, l’attenzione è il respiro della passione: ciò su cui posiamo la mente, con continuità, prende vita e forma dentro di noi.
Questa attenzione, però, non è passiva: è frutto di una scelta. Siamo noi a decidere — anche inconsciamente — di prestare attenzione a certi pensieri, a coltivare certi desideri, a dare loro spazio, fino a trasformarli in progetti di vita. Così, ogni passione porta il segno della nostra libertà: anche quando sembra travolgente, è passata per la porta delle nostre scelte, piccole o grandi.
La libertà interiore ha questa forza: può prendere l’inclinazione e orientarla in molte direzioni. Una persona ambiziosa può riversare tale energia nella politica o nella letteratura, nell’impegno sociale o nella brama di successo. Una donna dalla forte vitalità affettiva può vivere con intensa dedizione il dovere, la vanità o l’amore spirituale. Persone ardenti possono diventare santi o dissoluti: la differenza la fa il modo in cui orientano la loro energia.
Le passioni, dunque, non sono solo una reazione all’appetito o all’istinto: sono come fuochi accesi, che prendono direzione a seconda di come noi posizioniamo i binari della nostra libertà. Un desiderio può accendersi come una scintilla, ma solo se lo nutriamo con pensieri e azioni coerenti si trasformerà in una passione vera e propria.
La libertà non è solo coinvolta all’inizio del processo passionale, ma anche nella sua evoluzione e nella sua eventuale fine. Una passione, quando si radica nella mente e nel cuore, può ostacolare la nostra libertà decisionale, ma mai completamente, finché resta viva in noi la coscienza.
La libertà, anche se affaticata, può sempre intervenire: può distogliere l’attenzione dall’oggetto della passione, orientandola altrove; può sospendere le azioni che alimentano quella passione; può infine generare passioni alternative e più nobili, capaci di sostituire quelle distruttive.
Tutto questo richiede fatica, ma è possibile. Richiede pazienza, fedeltà quotidiana, discernimento. La mente può imparare a non ripassare ossessivamente certi pensieri, a non fissarsi sull’idea che alimenta la passione. È come smettere di buttare legna nel fuoco: il fuoco non si spegne subito, ma se non lo alimenti, si esaurisce.
Anche le azioni vanno riorientate. Compiere gesti che seguono la passione la rinforza; al contrario, agire come se si vivesse già liberi da essa può aiutarci a uscirne. Le azioni educano il cuore, anche quando il cuore fatica a crederci.
Infine, una strategia ancora più profonda consiste nel sostituire una passione con un’altra più grande e più luminosa. Non si vince una passione solo reprimendola: si può vincere accendendo un fuoco più vero, più puro, che orienti la vita a un bene più alto.
Le passioni sono forze potenti, capaci di generare bellezza o rovina. Ma non sono invincibili. Possiamo accoglierle, indirizzarle, trasformarle. Possiamo anche lasciarle andare.
Nel cuore di ogni persona esiste una libertà più profonda dei suoi impulsi: una sorgente da cui può sgorgare una vita nuova, anche quando tutto sembra già deciso. Da lì possiamo decidere a quale fuoco dare il nostro ossigeno, e a quale togliere l’aria.
Coltivare questa libertà è un’opera spirituale: richiede consapevolezza, esercizio, grazia. Ma è anche un’opera di verità: perché ci ricorda che non siamo mai prigionieri delle nostre passioni, ma possiamo esserne i maestri — o almeno, gli apprendisti di una libertà sempre più vera.
Due forme di passione: verso l’integrazione o la frammentazione del sé
Ogni essere umano sperimenta passioni, cioè movimenti profondi del cuore e dell’anima che coinvolgono la sfera affettiva, desiderante, motivazionale. Ma non tutte le passioni hanno la stessa qualità: alcune orientano verso la pienezza dell’essere, altre conducono a una frammentazione interiore.
Possiamo distinguere due grandi modalità del vivere le passioni: quelle che armonizzano l’interiorità e conducono all’integrazione personale, e quelle che disgregano l’unità del sé, inseguendo illusioni parziali.
Quando una passione nasce da un desiderio che unifica, che ci avvicina a ciò che siamo realmente chiamati ad essere – cioè a vivere in relazione con la verità, il bene e l’amore – essa è un’energia positiva, un’alleata della crescita spirituale e della maturità affettiva. Al contrario, quando una passione ci spinge a inseguire un piacere immediato, scollegato dal senso globale della nostra esistenza e dalle nostre relazioni profonde, essa può diventare tossica, frammentante, perfino distruttiva.
Il bene più autentico non è mai qualcosa di separato o isolato: è ciò che conduce all’armonia dell’essere, dove ogni parte trova il suo posto dentro un tutto più grande. Quando le nostre passioni ci aiutano a vivere questa armonia – tra corpo e spirito, tra desiderio e responsabilità, tra io e tu – esse sono buone passioni. Esse non reprimono il piacere, ma lo ordinano, lo integrano in un bene più grande.
Al contrario, una passione è disordinata quando rincorre un bene parziale che contraddice il bene più grande dell’interiorità integrata o delle relazioni autentiche. Non è male cercare il piacere, ma è male cercarlo contro ciò che dà senso alla nostra vita. In quel caso, il piacere diventa nemico della felicità.
La maturità spirituale richiede allora discernimento: riconoscere quali passioni ci aiutano ad amare meglio, e quali invece ci chiudono in un egoismo compulsivo. L’essere umano non è chiamato a sopprimere le passioni, ma a purificarle, a orientarle verso ciò che veramente fa bene, verso ciò che costruisce. Per questo la tradizione spirituale cristiana parla di educazione del cuore, di trasfigurazione del desiderio.
Nella nostra crescita, tendiamo naturalmente verso un’immagine ideale di noi stessi: è la visione del nostro sé più pienamente realizzato, il “nome nuovo” che Dio ci ha dato (Ap 2,17), il progetto spirituale iscritto nelle profondità del nostro essere. Questo ideale non è una fantasia irraggiungibile, ma una chiamata interiore: ci orienta verso la verità del nostro essere, e ci fa percepire come alcune passioni ci portino avanti in quel cammino, mentre altre ci deviano.
Quando la passione è buona, essa ci dà energia, motivazione, slancio. Ci fa sentire vivi, liberi, creativi, capaci di amare. È come un vento che spinge le vele dell’anima verso l’orizzonte del bene. Quando invece una passione è falsa – figlia dell’illusione, della compensazione affettiva, del narcisismo o del vuoto – essa ci consuma, ci rende inquieti, insoddisfatti, dipendenti. È una contraffazione dell’ideale, una finzione che pretende di essere pienezza, ma si rivela presto vuota.
Le passioni non sono da temere: sono fuoco, e il fuoco può bruciare o illuminare. Il lavoro spirituale consiste nell’apprendere l’arte del fuoco interiore: riconoscere, orientare, integrare. Le passioni buone ci avvicinano all’ideale di umanità che Dio ha posto in noi; quelle cattive ci allontanano, perché ci seducono con simulacri di bene che divorano invece di nutrire.
Un cuore pacificato, allenato al discernimento, è il luogo dove la verità si fa carne, dove la gioia non è evasione ma radicamento profondo.
La passione malvagia
La passione malvagia si manifesta essenzialmente quando il piacere diventa il fine ultimo della vita, la bussola che orienta ogni scelta e decisione. In altre parole, si riduce l’esistenza a una ricerca compulsiva del piacere immediato, ignorando la profondità della nostra natura umana e i legami essenziali che ci tengono integrati.
Quando riduciamo la ragione e la libertà a schiave degli impulsi istintivi, smarriamo la nostra identità più profonda. È come voler essere un “centauro”, metà uomo e metà bestia: un essere diviso, che vive nella finzione di un’esistenza dimezzata. Il piacere legato solo all’istinto, privo di consapevolezza e responsabilità, non può costituire la legge della vita umana.
Nel regno animale, l’istinto guida alla conservazione e alla crescita; nell’essere umano, invece, il solo inseguire il piacere istintivo senza orientamento superiore provoca disgregazione, sofferenza e perdita di sé.
Il piacere, per quanto intenso, è sempre parziale, mai completo, perché l’essere umano è una sintesi complessa di corpo, mente e spirito, che anela a un bene totale e duraturo. Il piacere soddisfa un bisogno limitato, ma non può colmare il desiderio infinito di felicità e senso che abita il cuore umano.
Più ci si sforza di inseguire questo piacere illusorio, più esso sfugge, lasciando dietro di sé un vuoto doloroso e una frustrazione profonda. La tensione crescente tra il sogno di felicità e la realtà dolorosa della sua mancata realizzazione è la misura del nostro dolore esistenziale.
Tentare di vivere secondo questa finzione è come sforzarsi di mettere insieme pezzi di una macchina che non funzionano più: la nostra psiche si disgrega, le nostre energie si sprecano in un lavoro inutile e dannoso. Le parti di noi che dovrebbero collaborare armonicamente entrano in conflitto, aumentano l’ansia, la stanchezza, la sofferenza.
In questo sforzo vano, il bisogno di felicità si esaspera, mentre la capacità di gioire si affievolisce. È come se la fame crescesse e il cibo sparisse, lasciando un abisso tra ciò che desideriamo e ciò che riusciamo a vivere. Questa consapevolezza dell’abisso interno diventa fonte di dolore e malessere profondo.
La responsabilità è nostra: invece di inseguire illusioni destinate a fallire, siamo chiamati a volgere lo sguardo verso l’ideale, quel bene autentico che integra e armonizza la nostra umanità. Solo seguendo questo ideale possiamo sperimentare una passione che nobilita, rigenera e ci conduce alla vera gioia.
La passione autentica
La passione diventa sana e vitale quando si orienta verso ciò che è bene autentico, anche a costo di rinunciare a gratificazioni immediate o superficiali. Più alto è il bene verso cui tende, più profonda e armoniosa sarà la trasformazione interiore che ne scaturisce. Questo bene non è un concetto astratto, ma una realtà viva, integrata nel nostro essere, che ci armonizza e ci fa crescere in autenticità e pienezza.
L’ideale è proprio quella meta di perfezione verso cui la nostra esistenza, se sana e in sviluppo, si dirige spontaneamente. È la bussola che indica una direzione che risuona con le nostre radici più profonde e con il progetto unico che ogni persona è chiamata a vivere. Anche quando non ne siamo pienamente consapevoli, la passione buona ci spinge verso l’ideale; ma quando lo scegliamo e lo abbracciamo consapevolmente, la nostra vita si illumina di un’energia nuova e potente.
L’ideale, infatti, è la sintesi del vero, del bello, del bene: è ciò che amiamo con tutta l’anima, il faro che ci guida nella notte. Non è un traguardo da raggiungere definitivamente, ma un orizzonte verso cui tendere con ardore e dedizione, come un navigatore che guida la propria barca seguendo la stella luminosa lontana.
Questa passione per l’ideale è una forza straordinaria e un dono prezioso. La passione per l’ideale non è un semplice pensiero o un’emozione passeggera. Nasce dall’intreccio di esperienze profonde, riflessioni intense, emozioni nobili e una volontà energica. In un momento di quiete interiore, un’idea si fa luce dentro di noi, abbracciando e unificando tante altre scintille di senso e desiderio. Questa luce diventa centro di gravità, condensando e rafforzando la nostra volontà in un’unica, grande spinta verso il bene scelto. D
Dentro la nostra coscienza quando un ideale si radica attira e integra tutte le idee, i valori e le emozioni che gli sono affini, lasciando svanire o indebolire tutto ciò che è dissonante o frammentato. Nel tempo, questo processo consolida la nostra identità profonda e rafforza il nostro impegno.
Questa dinamica spiega perché un proposito forte, quando è legato a un ideale autentico, non si disperde facilmente, ma anzi cresce e si radica nella vita quotidiana, trasformandola. Molti di noi hanno sperimentato questa crescita: ciò che sembrava un semplice proposito diventa una passione che dà senso, coraggio e gioia, anche di fronte alle difficoltà.
La passione per l’ideale agisce come una potente lente che focalizza tutta la nostra attenzione e le nostre energie. Come un’ipnosi consapevole, essa ci permette di vedere, sentire e vivere solo ciò che contribuisce alla nostra meta, filtrando tutto il resto. Questo non è un cieco abbandono, ma una scelta lucida e libera, che crea coerenza e profondità nella nostra esperienza.
In questo stato, siamo così immersi nell’amore per l’ideale che ogni impulso, ogni pensiero, ogni emozione si accorda con esso. Il nostro cuore si apre e si fortifica insieme alla nostra mente, e la volontà si fa azione concreta. Il cammino verso l’ideale diventa una danza armoniosa tra desiderio e ragione, coraggio e pazienza, forza e umiltà.
La passione buona è la scintilla divina che trasforma la nostra vita in un’opera d’arte spirituale. È il motore che ci conduce verso la migliore versione di noi stessi, verso quella verità ultima che illumina ogni passo e dona senso profondo al nostro essere.
L’ideale: forza vitale e trasformazione profonda dell’essere
L’ideale non è soltanto la forza più autentica che anima la vita interiore, ma rappresenta anche il suo dono più prezioso. Esso è la luce che dissolve le ombre dei nostri limiti e difetti, orientandoci verso la fioritura piena del nostro potenziale.
Quando l’ideale emerge in un’anima, porta con sé un cambiamento radicale, un vero e proprio capovolgimento dell’orizzonte interiore. Questo processo spesso si manifesta come una profonda frattura interiore, che può essere tanto più intensa quanto più è radicale il nuovo orientamento. È un momento in cui la coscienza si dilata e si riorganizza attorno a una nuova visione di senso.
Questo fenomeno si manifesta in modo eclatante nei grandi passaggi di vita, come nell’esperienza di Paolo sulla via di Damasco: la sua trasformazione da persecutore a apostolo è paradigmatica di come la grazia di un ideale possa demolire e ricostruire l’identità profonda. Nelle vite di molti, e non solo in ambito religioso, si può osservare questo passaggio: l’ideale che irrompe, che “illumina” e conquista la coscienza, dissolvendo antiche passioni, pregiudizi, abitudini radicate.
Questa trasformazione può essere paragonata a una “ricostruzione della sintesi interiore”: la struttura mentale precedente crolla perché incapace di contenere la nuova consapevolezza espansa. L’ideale diventa così il nuovo centro, la nuova matrice che organizza e orienta tutte le energie interiori. Le vecchie abitudini, radicate e spesso quasi inconsapevoli, vengono spazzate via con la forza di un’azione volitiva intensa, che agisce sull’organismo psichico e anche somatico, generando un nuovo equilibrio.
È importante sottolineare che questo tipo di trasformazione radicale è raro e richiede un’intensità emotiva e una dedizione totale di sé. Più spesso, il cambiamento è graduale, ma non meno reale: l’ideale entra nell’anima e inizia a sottrarre lentamente energie e attenzioni agli istinti opposti, a quelli che prima alimentavano i nostri difetti.
Il dominio dell’ideale rappresenta quindi una forma di “autogoverno” psico-spirituale, un esercizio continuo di volontà che mantiene il nostro “capo sollevato”. Questo non significa ignorare o reprimere gli istinti, ma farli servire allo scopo di una vita armoniosa e consapevole, non lasciarsi dominare da essi.
Nel percorso umano, la presenza costante dell’ideale crea armonia, coerenza, e annienta i “difetti”, intesi come disarmonie e mancanze di integrazione tra le parti del nostro essere. Questi difetti sopravvivono solo laddove l’ideale non è ancora pienamente presente o esercita poca influenza.
La vita mediocre spesso si caratterizza per due grandi sfide interiori: la debolezza della volontà, segnata dall’esitazione e dall’indecisione, e la dispersione delle energie, quando i nostri atti volitivi sono contraddittori e incoerenti.
L’ideale agisce su entrambe queste dimensioni, infondendo un desiderio unico, ardente e persistente che elimina l’indecisione e unifica gli sforzi verso una meta chiara. Come una bussola interiore, esso orienta la volontà e le energie, moltiplicandone l’efficacia e la capacità di produrre frutti.
Un individuo dotato di un ideale profondo, chiaro e stabile, si distingue per la sua capacità di concentrare e valorizzare tutte le proprie risorse interiori. Questa concentrazione genera un entusiasmo autentico e una vita più piena, che non spreca energie in “lavori nocivi” o distrazioni.
Come affermava Roosevelt, e come confermano le riflessioni psicospirituali contemporanee, «un individuo non ha valore se non è animato da una profonda devozione verso un ideale». Solo l’ideale può essere il motore che ci salva dalla dispersione e dalla mediocrità, permettendoci di usare la nostra vita in modo autentico e fruttuoso.
L’ideale agisce come forza motrice che espande le nostre energie interiori, affinando la volontà e integrando le diverse tendenze dell’anima in un’unità coerente e armoniosa.
L’ideale, infatti, non è solo un obiettivo da raggiungere, ma rappresenta anche la sorgente di una gioia squisita e profonda. Come Aristotele osservava, la gioia accompagna l’atto perfetto: quando una nostra capacità si esprime al meglio, essa si manifesta non solo come soddisfazione, ma come un’esperienza di pienezza esistenziale. In questo senso, l’azione armonica e ordinata — che risponde adeguatamente alle circostanze e ai bisogni della realtà — è la manifestazione di un “essere” in evoluzione verso la sua più autentica verità, bellezza e bontà.
La ricerca appassionata della verità diventa allora un’esperienza altamente gioiosa, poiché sollecita e realizza il perfezionamento dell’essere.
Questo spiega il paradosso di molte esperienze spirituali e umane: i santi, attraverso la rinuncia e il sacrificio, si aprono a una gioia espansiva e duratura, mentre molte persone immerse nella ricerca del piacere sensoriale vivono una tristezza profonda, a volte tale da portarli all’autodistruzione. La vera gioia dei santi e degli innamorati di un ideale nobile non è il piacere superficiale che attraversa i sensi e svanisce senza raggiungere il cuore profondo dell’anima. È piuttosto una condizione di armonia interiore — una serenità che non stanca, ma rigenera; che non consuma, ma amplia; che si prolunga come un’estate senza fine dentro di noi.
La gioia autentica scaturisce da una fonte profonda dentro l’anima, una sorgente calma e inesauribile che irrora anche i sensi, rendendoli partecipi senza mai esaurirsi. I sensi, infatti, possono solo ricevere il fascino di questa gioia; se cercassimo di forzarla attraverso eccitazioni o stimoli nervosi, la fonte si esaurirebbe rapidamente.
Per coltivare questa gioia occorrono quindi luce e volontà: la consapevolezza interiore (riflessione) e l’intensificazione del desiderio autentico (volontà ardente). Non si tratta di semplici reazioni emotive o di spasmi nervosi, ma di una vera e profonda donazione di sé, che si costruisce lentamente con l’esercizio paziente e l’azione consapevole. I giovani spesso si illudono che l’emozione intensa basti a sostenere l’amore per l’ideale, ma l’esperienza insegna che senza la gradualità e la maturazione psicologica, questo slancio si trasforma in agitazione sterile e perdita di armonia interiore.
Molti attraversano queste fasi di eccesso e disarmonia, per poi correggersi e giungere, attraverso il cammino spesso lungo e faticoso della vita, a una gioia matura e stabile. Questa gioia è come una fragranza preziosa che permea ogni aspetto dell’esistenza e permette di accogliere anche la morte con serenità, come il passaggio a una vita più piena.
Non tutti, naturalmente, raggiungono questi livelli di passione e pienezza, ma anche un amore più moderato e costante verso l’ideale può ordinare e dirigere la vita, generando armonia interiore e una gioia profonda, che è il naturale complemento della crescita personale.
Indipendentemente dai risultati immediati, l’ideale offre anche un metodo efficace e dolce per affrontare la necessità universale di espandere la propria coscienza e combattere le tendenze autodistruttive o disarmoniche dentro di noi. Le energie inferiori, lasciate a sé stesse, tendono infatti a frammentare l’essere, creando conflitti interni e difetti. La vita stessa è un processo di subordinazione e integrazione di queste energie, che può realizzarsi solo attraverso uno sforzo consapevole.
Invece di combattere i difetti con durezza o repressione, è più salutare e piacevole permettere alla nostra “vita interiore” di espandersi liberamente e salutare, lasciando che le nostre forze migliori prendano il sopravvento e si esprimano pienamente, proprio come un albero che si sviluppa verso la luce del sole, che fa circolare la linfa e porta fiori e frutti.
Questa espansione è la vera vittoria sulle nostre debolezze: non tanto una lotta costante e debilitante, quanto una crescita armoniosa e progressiva. È una gioia sottile e persistente, un sentimento di pienezza e di appartenenza a qualcosa di più grande, che sostiene ogni nostro passo.
In fondo, la gioia di vivere nasce da un amore profondo e costante, un amore che nessuna difficoltà potrà mai spezzare. Amare la vita, vedere in essa il riflesso dell’ideale più alto, permette di accogliere con serenità e speranza ogni momento, anche quelli più duri.
Per i giovani, come per gli adulti, avere un ideale chiaro e seducente è fondamentale: è ciò che rende la vita degna di essere vissuta, ciò che dà energia e slancio al quotidiano, anche quando richiede sacrificio. Coltivare un ideale significa avere una ragione profonda di vivere, una fonte inesauribile di forza e la gioia autentica di un’esistenza piena.
Allinearsi con il proprio essere profondo
Innanzitutto, l’ideale che scegliamo deve risuonare con il nostro destino e le nostre attitudini naturali. Se non lo fa, allora non stiamo inseguendo una verità autentica, ma una sua distorsione. Quando l’ideale contrasta con il nostro destino, rischiamo di inseguire solo piaceri illusori e passeggeri, che alla lunga possono diventare sofferenza e malessere. Il mondo è pieno di esempi di persone che hanno tentato di forzare sé stesse verso mete incompatibili con la loro natura e ne hanno pagato il prezzo.
Se l’ideale va contro le nostre inclinazioni più profonde, significa che stiamo tradendo noi stessi, negando la nostra personalità, indebolendo la nostra autenticità. Questo è un principio fondamentale: le nostre qualità autentiche sono come la linfa che nutre un fiore. Per crescere in verità, dobbiamo attingere a ciò che è già vivo dentro di noi. Tentare di essere ciò che non siamo, anche se attraente dall’esterno, ci allontana dalla nostra fioritura autentica.
Non basta però che l’ideale non contrasti con noi: deve essere anche la verità-limite del nostro essere, cioè la luce guida che abbraccia e sostiene tutta la nostra vita, dando senso e direzione.
Un ideale autentico non è solo una semplice idea o un concetto astratto: è un orientamento vitale, che corrisponde all’essenza del nostro essere e alla nostra missione nel mondo. Deve essere vasto e chiaro, semplice nella sua formula, ma capace di integrare ogni aspetto della nostra vita, ogni sfumatura delle nostre relazioni e delle nostre attività.
L’ideale dovrebbe sintetizzare e valorizzare la qualità dominante in noi, quella dote unica che possiamo far fiorire fino alla sua massima espressione. Non possiamo essere eccellenti in tutto, e non è necessario: quando seguiamo la nostra “via maestra”, il resto segue in armonia.
Inoltre, l’ideale deve non solo essere vero e giusto, ma anche bello e attrattivo. Solo ciò che ci affascina profondamente può sostenerci nei momenti difficili, quando il dovere e il sacrificio si fanno sentire. Amare l’ideale significa anche saper vedere la bellezza nascosta nella fatica, nel limite, nella crescita personale.
Dopo aver scelto l’ideale, il vero lavoro è farlo diventare parte di noi, introdurlo nella nostra mente e nel nostro cuore con attenzione e amore costanti.
Questo non è sempre facile: richiede tempo, pazienza, e soprattutto una sincera volontà di cambiamento. Le passioni intense e improvvise spesso svaniscono; invece, l’amore per l’ideale si costruisce con calma, attraverso riflessioni profonde e pratica quotidiana.
È importante creare una connessione viva e duratura con l’ideale, che orienti la nostra coscienza e guidi le nostre scelte. Quando l’ideale risplende dentro di noi come una luce chiara e potente, comincia a trasformare tutta la nostra vita.
Un ideale ben scelto e amato diventa la fonte della nostra verità più autentica, della nostra bellezza più profonda e del bene che possiamo portare nel mondo. Ci permette di espanderci, di diventare sempre più noi stessi, di vivere con pienezza ogni aspetto della nostra esistenza.
Bibliografia essenziale
Chimiri, Giovanni, Etica delle passioni, Dehoniane, Bologna 1996.
Vito, La vita autentica, RaffaelloCortina Editore, Milano 2021
Nussbaum, Martha C., L’intelligenza delle emozioni. Il Mulino, 2004.
Rohr, Richard. Falling Upward: A Spirituality for the Two Halves of Life, Jossey-Bass, Hoboken, NJ, (Stati Uniti) 2023.
Rolheiser, Ronald, Il cuore inquieto. Alla ricerca di una casa spirituale in un tempo di solitudine, Queriniana, Brescia 2008.
Solomon, Robert C., The Passions: Emotions and the Meaning of Life, Hachette Publishing Company, Indianapolis/Cambridge 1993.