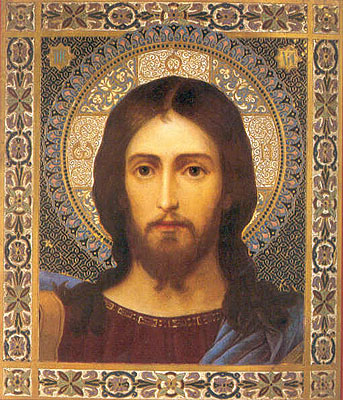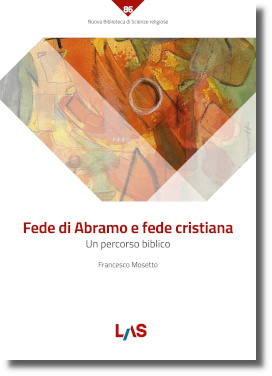settimananews.it
Ogni volta che si parla di sinodalità, non posso fare a meno di ripensare al cammino degli anni Ottanta e Novanta con le famiglie contadine del Maranhão, al tempo del protagonismo laico delle Comunità di Base e alla lotta per la conquista della terra e della dignità, quando i poveri affrontavano la violenza secolare del latifondo e i poteri nemici dello Stato.
Abbiamo vissuto la sinodalità ed esperienze concrete dell’esercizio collegiale di animazione-coordinamento delle comunità, delle parrocchie e della pastorale, in un processo di valorizzazione del protagonismo laicale, del Popolo di Dio, del sacerdozio di tutti i battezzati, in una Chiesa povera, samaritana, martiriale.
Sinodalità esistenziale
L’esperienza delle comunità di base è, infatti, la profezia esistenziale della sinodalità: una Chiesa povera, non costruita su criteri gerarchici, testimone del Regno, martire. Una Chiesa che nasce e cresce fuori dal Tempio, nelle case, attorno a una tavola, sotto un tetto di paglia, condividendo la Vita e la Pasqua di Gesù. Una Chiesa che sposava la Parola di Dio alla vita, una Chiesa che pregava e cantava, e che aveva come missione la lotta amorosa per la giustizia del Regno.
È stata un’esperienza comunitaria, che ha ridefinito il ruolo dei preti in termini di servizio fraterno nei percorsi di formazione biblica e sociopolitica. Un prete formatore, che assumeva lo stile pedagogico suggerito da Paulo Freire. Un prete assolutamente non clericale, che non abbandonava l’altare, ma non si limitava alla liturgia e all’amministrazione dei sacramenti. Un prete itinerante, non identificato con la centralità della chiesa parrocchiale.
Una Chiesa che poteva ancora innestarsi in un tessuto comunitario erede di ascendenze indigene e africane, sedotte dal Vangelo di Gesù. Si tratta di una dimensione comunitaria che è stata attaccata mortalmente dai processi di modernizzazione capitalista. Una dimensione che ancora resiste nella lotta dei popoli originari e tradizionali, ma che è quasi del tutto dimenticata nell’odierno cattolicesimo popolare.
Ed è per questo che mi sento in dovere di parlare della sinodalità come di qualcosa che appartiene al passato. Di recente, però, papa Francesco ci ha sorpreso con la proposta di un Sinodo, che sta cercando di coinvolgere, dal 2021, l’intera Chiesa cattolica nella ricerca della partecipazione e del contributo delle comunità dei cinque continenti in vista di un cammino comune. Una proposta che si rivela complicata e piena di difficoltà, in una Chiesa oggi abbastanza divisa tra chi va a destra, chi va a sinistra e chi preferisce rimanere neutrale.
Le prassi che mancano
Ci sono anche altri ostacoli. In effetti, ciò che dovrebbe preoccuparci di più è la distanza tra parole e pratiche, tra documenti e conversioni pastorali effettive, una «sindrome» che caratterizza i processi di questi ultimi cinquant’anni di storia della Chiesa a partire dallo stesso Concilio Ecumenico Vaticano II.
Assumiamo e ripetiamo le parole chiave − si pensi, ad esempio, ai «discepoli missionari» di Aparecida o a un altro motto, molto popolare e presto dimenticato: «Chiesa in uscita», ma pare non sia possibile andare oltre il discorso ortodosso e vuoto. Questo si ripete con il tema della sinodalità, tema che è oggetto di studi, riflessioni, commenti, orientamenti, incontri parrocchiali, diocesani e regionali, il più delle volte ripetitivi e slegati da decisioni ed eventi che possono tradurlo.
Insomma, date queste considerazioni, avremmo due momenti storici ben distinti. Nel primo caso, stiamo facendo memoria di eventi in cui i poveri erano protagonisti e la sinodalità e la collegialità erano vissute concretamente, frutto della sorprendente irruzione dello Spirito nella nostra storia, sino a che i processi si sono affievoliti, ridimensionati da imprevedibili cambiamenti economici e sociopolitici, e da pressioni gerarchiche e persecuzioni durante due lunghi pontificati. Al contrario, nel secondo caso, non si tratta di esperienze concrete, ma di discorsi, che, a volte, appaiono inutilmente ripetuti e inflazionati.
Tutto inizia con la decisione pastorale di papa Francesco, che propone un dibattito sinodale sulla sinodalità, invitando i cattolici di tutto il mondo a convertirsi alla fraternità evangelica e a partecipare a un dialogo permanente sulle nuove sfide che il mondo di oggi ci presenta e sulle strategie per annunciare il Vangelo. Un progetto che si accompagna a frequenti critiche al clericalismo, che mi sembra un atteggiamento sottilmente e prudentemente antigerarchico.
Ultimamente, però, riflettendo sulle tensioni tra tendenze egualitarie e gerarchiche, sono stato costretto a guardare alla storia occidentale con altri occhi e altre lenti e ho concluso che abbiamo a che fare con l’impossibilità ontologica di risolvere politicamente questa opposizione e ostilità.
Il rapporto con il diritto
Ereditiamo un’aporia filosofica, che ci viene dalle spiegazioni che Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, sul rapporto tra gli esseri umani e lo Stato. In tutti e tre, la figura del contratto sociale comporta l’esistenza del potere statale: il Leviatano assoluto e incontestabile in Hobbes, la monarchia parlamentare in Locke, la democrazia diretta in Rousseau. Forse, solo quest’ultimo si dimostra ottimisticamente antigerarchico.
Va ricordato che l’opposizione al potere è presente come motivazione teologica fondamentale nella Riforma luterana. Lo spirito antiromano, antiautoritario, antigerarchico, tuttavia, non ha generato alternative organizzative per le comunità. Lutero si sbarazzò del diritto canonico, ma rimase fedele al diritto civile, delegando ai principi il compito di amministrare la Chiesa, quasi fossero vescovi d’emergenza, sottomettendosi così al controllo dello Stato e rinunciando al compito di costruire e pensare l’uguaglianza fraterna nello spazio della convivenza politica.
L’unico che riuscì ad andare oltre la semplice riforma della Chiesa fu Thomas Müntzer, che guidò la guerra dei contadini. Si considerava un profeta inviato per realizzare il Regno di Dio, attraverso una rivoluzione che chiedeva l’abolizione della servitù della gleba nelle campagne e la divisione comunitaria della terra, l’eliminazione di ogni privilegio, di ogni disuguaglianza, di ogni oppressione. Ovviamente, la nobiltà cattolica e luterana non poteva rimandare lo scontro con i contadini ribelli e li sconfisse sterminandoli nella battaglia di Frankenhausen (1525).
Molto prima di Lutero, c’è stato il tentativo rivoluzionario di Francesco e Chiara, che hanno affrontato il diritto canonico con una strategia amorevole ed estremamente creativa: non lo hanno attaccato frontalmente né hanno pensato di bruciarlo, come più tardi farà Lutero, ma hanno semplicemente vissuto la vita comunitaria come se il diritto canonico non esistesse, guidati semplicemente dal Vangelo letto e obbedito «sine glossa».
Il dibattito sulla necessità di una regola pose fine al movimento francescano e lo stesso Francesco, ancora in vita, fu rispettosamente sconfitto ed emarginato. E dopo la sua morte, naturalmente, fu santificato e, per secoli fino ad oggi, ammirato e contemplato, ma senza l’invito, la vocazione chiara e incontestabile, ad imitarlo.
Questa tensione, inoltre, si è rivelata tragica quando l’uguaglianza e la fraternità, che hanno ispirato i movimenti rivoluzionari, vengono successivamente e sempre rinnegate e tradite da regimi dittatoriali.
Fede e politica
Nuovi movimenti, evangelici, carismatici, rivoluzionari, amorevoli, fraterni, comunitari, antigiuridici e anarchici, alleati della verità, della pace e della giustizia, appaiono insistentemente nella storia dell’Occidente e del cristianesimo e sono invariabilmente sconfitti dai leviatani degli Stati e delle istituzioni. Ma se vincessero lo scontro, si sistemerebbero in un processo di inevitabile tradimento di valori e speranze.
Il confronto con le istituzioni deve essere permanente, non solo per salvaguardare la nostra fedeltà, ma per costruire un processo di autonomia e di autogestione e per insistere su una versione dello stato e delle istituzioni come potere obbediente alla Vita. L’insistenza e la perseveranza nella Speranza, contro ogni negazione, nonostante le sconfitte, in opposizione radicale al cinismo del realismo politico, deve essere la caratteristica fondamentale di chi si oppone al capitale e allo stato.
In primo piano sta la questione dello Stato, affrontato nella sua identità costitutiva: occidentale, violenta, colonialista, fedele al sistema capitalista. Approccio basato sul diritto delle culture indigene, la profezia zapatista del Chiapas, Davi Kopenawa Yanomami, Nego Bispo. Senza trascurare il pensiero di grandi e indispensabili occidentali, resi spesso invisibili, come Fëdor Dostoievski, Enrique Dussel, Emmanuel Lévinas, René Girard, Jacques Ellul e, soprattutto, Simone Weil, la profezia di Francesco e Chiara attualizzata nel nostro tempo.
Sarebbe qui opportuno anche riflettere sul secolare rapporto tra la Chiesa cattolica e lo Stato. Lo Stato, come «cameriera del mercato capitalista» (subcomandante Marcos dell’EZLN), si presenta di nuovo come un nemico mortale della Vita e dei piccoli. Gestito dalla destra o dalla cosiddetta sinistra, ha radicalizzato la sua essenza violenta in modo tale che ripetere le metodologie ecclesiastiche tradizionali, attraverso il diritto, il concordato, l’advocacy, è una scommessa sbagliata e sterile.
Si tratta, insomma, di provocare un dibattito più ampio della mera ripetizione del tema Fede e politica, che sembra semplicemente optare per la riduzione della politica a questioni partitiche ed elettorali.