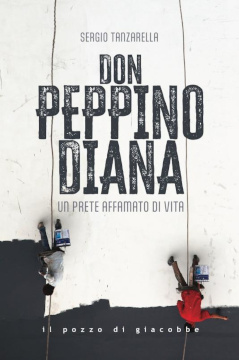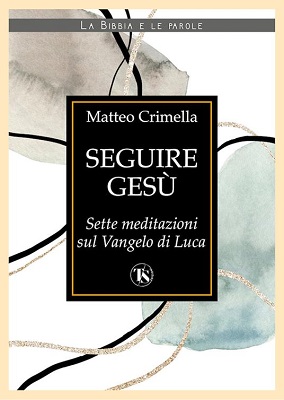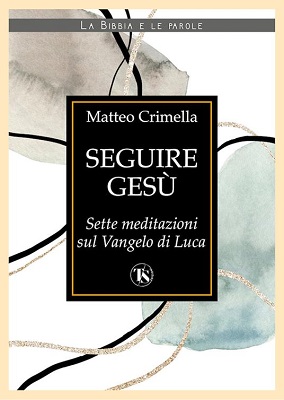
Matteo Crimella è presbitero ambrosiano, dottore in Scienze Bibliche e insegna Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano), al Seminario Teologico del PIME (Monza) e al Collegio Alberoni (Piacenza).
In questo libro egli mette a frutto il lavoro compiuto nella tesi dottorale, imperniato sul «triangolo drammatico».
Nel Vangelo di Luca egli ritrova vari racconti imperniati apparentemente su due personaggi, ma che, in verità, si rivelano essere un triangolo di interpreti che ritrovano in una persona una posizione superiore, decisiva nel rivelare la verità del racconto stesso e di ciò a cui rimanda, il regno di Dio.
Sette meditazioni
Crimella analizza con sinteticità esemplare per chiarezza e profondità di suggerimenti sette brani del Vangelo di Luca. Seguendo il metodo della lectio divina, egli propone dapprima il testo in traduzione personale, quindi la lectio che intende scoprire cosa dice il testo, quale tratto del mistero di Dio intenda rivelare. È il significato del testo.
Segue la meditatio che si domanda cosa il testo voglia dire oggi alla Chiesa, alla comunità e al lettore credente.
L’ultimo passo è l’oratio, rappresentato per lo più da una preghiera di santi e di uomini di Dio vissuti nei due millenni di cristianesimo.
Lc 7,36-50: Il fariseo e la peccatrice
Lc 7,36-50 riporta la scena del fariseo, la peccatrice e Gesù. Crimella esamina a livello narrativo/narratologico i vari personaggi, le loro azioni, parole, sentimenti, giudizi ecc. Il fariseo mostra giudizio, disprezzo verso la donna e anche scarsa accoglienza della persona di Gesù, invitato forse solo per acquistare ulteriore fama. Il personaggio che emerge nel triangolo drammatico è Gesù, che si rivela non solo come profeta (realtà messa in dubbio dal fariseo), ma anche come colui che perdona i peccati, colui che salva.
A causa della parabola inserita nel racconto – con una sua logica –, gli autori si domandano se sia l’amore a causare il perdono, o non piuttosto l’inverso. Non occorre scegliere. Dio e Gesù avvolgono le persone col perdono preveniente e sanante, attirano le persone alla salvezza per il loro essere accoglienti e suscitano ulteriore amore. Alla fine, viene lodata la fede della donna come elemento che porta alla salvezza.
L’oratio è rappresentata da un testo di santa Teresina, che traccia un itinerario per vivere e morire d’amore.
Lc 10,25-37: Il Buon Samaritano
La famosa parabola del Buon Samaritano (Lc 10,25-37) mette in campo un sacerdote e un levita, il Samaritano e il ferito. Crimella ripercorre la lettura allegorica che ha imperato per secoli, per poi passare a un’interpretazione basata su una lettura di tipo narrativo/narratologico. I primi due personaggi si rispecchiano l’un l’altro nel loro disinteresse per il malcapitato, mentre lo scomunicato samaritano soccorre il ferito con tutto sé stesso.
Crimella sottolinea, però, come la parabola sia raccontata dal punto di vista del ferito. Essa interroga sull’identità del prossimo non più a partire dal donatore, ma da quello del beneficiario, senza nome e senza identità, un membro dell’umanità. C’è un capovolgimento di prospettiva. Quando sono posto in una condizione di indigenza, qualunque sia la mia identità, aspetto che un altro si riconosca prossimo per me.
L’oratio riporta un brano della lettera pastorale Farsi prossimo del card. Martini.
Lc 10,38-42: Marta e Maria
Nel triangolo drammatico rappresentato da Marta, Maria e Gesù nell’intimità di una scena domestica di ospitalità (Lc 10,38-42), Crimella sottolinea il fatto che non si intende opporre vita attiva e vita contemplativa, ma proporre un itinerario che recupera positivamente Marta in vista di un cammino di discepolato senza eccessive «dis-trazioni». La ripetizione del nome «Marta, Marta» è tipica dei racconti di vocazione.
La cosa buona che non verrà tolta a Maria è ascoltare Gesù come discepola. A questo è invitata anche Marta, descritta come «occupata» e «confusa». Ella non è giudicata negativamente per il suo servizio ma ammonita per l’eccessiva preoccupazione, dispersione e inquietudine che le impediscono l’ascolto della parola di Dio.
L’accoglienza di Marta e l’ascolto di Maria sono – secondo Crimella – le tappe di un itinerario che passa dall’ospitalità all’attitudine discepolare, scartando invece l’occupazione distratta. Un detto dei padri del deserto ammonisce sulla necessità sia del lavoro che della preghiera.
Un brano di Origene a commento della Lettera ai Romani esalta la fatica e le continue veglie di coloro che scrutano in profondità le Scritture.
Lc 15,11-32: Il padre e i due figli
Molto ricca di spunti è anche la lettura della famosa parabola del padre e dei due figli (Lc 15,11-32). Nella lectio lo studioso rammenta tre interpretazioni tradizionali del racconto: la penitenziale, quella morale e quella etnica.
Quello che si instaura è un triangolo drammatico, che rivela la personalità dei vari personaggi, per porre in primo piano la figura del padre. Egli accondiscende al cammino libertario del figlio cadetto. (Crimella ricorda che la pratica della donatio inter vivos fosse in auge, quindi il figlio minore non «uccide il padre» domandandogli la propria parte di eredità in anticipo).
Il figlio minore torna a casa per fame. Il figlio maggiore vive in casa da schiavo, vittima della logica della giustizia retributiva, senza aver compreso mai il cuore del padre.
Nell’accoglienza di chi ritorna e nella premura per far partecipare anche il maggiore alla festa, Gesù rivela tramite il personaggio del padre l’identità di Dio Padre e la novità della logica del regno di Dio, in cui vige l’accoglienza, la fraternità, il perdono.
La parabola infatti è raccontata a giustificazione del comportamento di Gesù che accoglieva i peccatori, rivelando in tal modo la logica del Padre e del regno (Lc 15,1-3). Se il Samaritano era narratologicamente una figura “piatta”, il padre della parabola assume invece uno spessore di notevole rilievo e si avvicina a quella di Gesù che risolve la contestazione di Marta nei confronti di Maria.
Il padre della parabola risolve le contestazioni rivelando un punto di vista inedito, con una sorpresa che però è soprattutto rivelativa, ossia teologica. Le parabole che precedono il racconto, quelle della pecora perduta e della dramma smarrita, presentano dei personaggi che si oppongono al resto. Entrambe sono ritrovate, come entrambi i figli sono ritrovati dal padre buono e dalla sua grazia: si attende solo la risposta della libertà (i figli non sono pecore o monete…).
Una preghiera del rito maronita per la quarta domenica di Quaresima ricorda Gesù che rivela l’amore del padre misericordioso.
Lc 16,19-31: Il ricco epulone e Lazzaro
Nell’ambito contestuale costituito dal tema della ricchezza, la parabola di Lazzaro, il ricco e Abramo (Lc 16,19-31) oppone le figure del povero Lazzaro che, alla sua morte, è accolto nel seno di Abramo e quella dell’anonimo ricco epulone talmente ingolfato nella sua vita di ingozzamento nella ricchezza più sfrenata da non accorgersi del povero – di cui conosce il nome! –) che giace alla sua porta.
L’opposizione dei personaggi, il ribaltamento di sorte che accade dopo la loro morte rivelano la grazia che abbraccia Lazzaro – di cui non si dice che fosse buono e impeccabile – e la squallida sepoltura che attende il ricco. Egli chiede imperiosamente ad Abramo che Lazzaro gli dia da bere (pensa ancora di comandare…) e poi si preoccupa della conversione e della salvezza dei suoi cinque fratelli.
Abramo, però, gli rivela il punto di vista superiore nel triangolo drammatico. La colpa del ricco è esplicitamente collegata al tema generale della ricchezza che rende senza volto e ignari dei fratelli bisognosi. Neppure una risurrezione miracolosa ed estemporanea di qualche morto può convertire il cuore dei fratelli del ricco epulone. Hanno la legge di Mosè, le Scritture. Sono sufficienti. In esse è rivelata la volontà di Dio sul rapporto ricchezza-povertà.
Nella parabola è decisiva la pressante richiesta di conversione. È evidente che per un discepolo di Gesù la sua risurrezione e la sua parola sono fattori estremamente importanti, che aiutano enormemente a fare la differenza e a rivelare il disegno di Dio e la logica del Regno da vivere fin d’ora sulla terra.
Aelredo di Rievaulx, uomo docile e misericordioso, ricorda al Signore Gesù tutta la sua debolezza e povertà. «Signore Gesù, io sono povero, e anche tu lo sei; sono debole e anche tu lo sei; sono uomo, ma anche tu lo sei. Ogni mia grandezza viene dalla tua piccolezza; ogni mia forza viene dalla tua debolezza… Io ti seguirò, Signore Gesù».
Lc 18,9-14: Il fariseo e il pubblicano
La parabola del fariseo, il pubblicano e Dio (Lc 18,9-14) sembra avere come tema dominante quello della preghiera fatta correttamente. Quella quel fariseo è in realtà un monologo verso sé stesso e un giudizio sprezzante sul pubblicano. Quella del pubblicano è ben fatta e ben rivolta a Dio con sincerità.
Crimella invita a sfuggire a due trappole: la tipizzazione dei due personaggi (pensando che tutti i farisei siano così…) e che il racconto fittizio riguardi la preghiera e il modo di pregare.
Per capire la parabola occorre, invece, distinguere tra il quadro del racconto (vv. 10-13) e la sua cornice (va. 9 e 14).
La cornice fornisce il significato ultimo della parabola. Essa è raccontata per/rivolta a/contro alcuni (farisei, astanti?) che confidano fiduciosamente su sé stessi per la loro vita spirituale, mentre disprezzano gli altri.
Nella cornice del quadro viene affermato che il pubblicano torna a casa giustificato, innalzato perché si è umiliato.
Il triangolo drammatico è costituito dalle due figure opposte, specchio per tutti, e il giudizio superiore espresso da Gesù/Dio è contenuto nella logica del regno di Dio. Le parole di Gesù (e quelle iniziali di Gesù/Luca) dirimono la questione del triangolo drammatico, imperniato non tanto sulla preghiera (tema del contesto invero), quanto sulla falsa presunzione di innocenza e di superiorità espressa da chi pensa di essere a posto grazie alla pura osservanza della Legge, adempiuta addirittura con surplus di radicalità.
In questa parabola si vede chiaramente il vantaggio del lettore. Egli, a differenza dei personaggi, è messo a parte della risposta divina. Tira dunque le conseguenze: le opere buone del fariseo (opere che rimangono buone) sono vanificate dal giudizio spietato nei confronti del pubblicano. Come nella parabola del padre e dei due figli, il riconoscimento della paternità di Dio chiede pure la fraternità, condizione necessaria per intendere la paternità.
L’oratio riporta una strofa di una preghiera composta dal katholikos della Chiesa armena Nersēs Šnorhali (1103-1173), tutta percorsa dalla coscienza del peccato e dalla meraviglia per la misericordia di Dio.
Lc 23,39-43: I due ladroni
L’analisi del racconto dei due “ladroni” crocifissi con Gesù (Lc 23,39-43) chiude il volume di Crimella.
I due malviventi/terroristi hanno reazioni opposte di fronte a Gesù crocifisso e sofferente come loro. Uno lo insulta e chiede con tono sprezzante la salvezza, l’altro riconosce la propria colpa, l’innocenza di Gesù e chiede di ricordarsi di lui quando entrerà nel suo Regno.
Il confronto drammatico fra le due figure è risolto dalla posizione superiore e risolutiva di Gesù che, con autorevolezza, assicura al «buon ladrone» che il giorno stesso sarà con lui, cioè nel paradiso. L’ironia drammatica di Luca è suprema: mentre Gesù è schernito, in realtà sta salvando l’umanità proprio condividendo l’impotenza, la debolezza, l’iniquità. Nell’ultima cena egli aveva interpretato il significato profondo della sua morte come il compimento del versetto di Is 53,12 (cf. Lc 22,37) sull’essere annoverato fra gli empi.
Il «buon ladrone» intuisce che «l’impotenza di Gesù a salvarsi da sé non contraddice la sua messianicità ma, misteriosamente, ne dispiega la forma più propria e nuova. L’innocente è il Messia che dispone di sé e la cui potenza va oltre la morte in quanto invoca perdono per i suoi stessi uccisori. Gesù ha inaugurato il suo Regno e la venuta potente di quello stesso Regno inizia a manifestarsi appieno nella croce. Il legno dell’infamia diventa trono di misericordia. “Padre, perdona loro, infatti non sanno quello che fanno!” (23,34)» (pp. 119-120).
Il buon ladrone è l’unico nel Vangelo a chiamare Gesù con il suo solo semplice nome, e lo fa con continuità (il verbo che contiene la richiesta è all’imperfetto). «La fede di quest’uomo è domandare salvezza a un condannato che non salva nemmeno sé stesso», annota Crimella (p. 121).
Egli ragiona così: «Sì, Gesù: se tu invochi il Padre per i tuoi nemici, allora, posso invocarti anch’io, malfattore concrocifisso con te! Proprio perché perdoni loro, allora puoi salvare anche noi!» (ivi). La relazione personale con Gesù si precisa come un luogo paradisiaco, e l’«oggi» non è semplicemente temporale, ma momento escatologico di salvezza. La salvezza è offerta gratuitamente.
Secondo Crimella, Luca non rappresenta solo due personaggi contrapposti, ma li mostra come «un’unica figura complessa, che consente di costruire un cammino di fede completo, attraverso due diverse reazioni all’incontro con Cristo crocifisso: prima imprecando nella ribellione, ma infine invocandolo nella conversione» (p. 123).
I due concrocifissi con Gesù non sono due malfattori contrapposti, ma rappresentano un itinerario dalla ribellione impenitente che urla con blasphemia la propria rabbia al presunto Messia che suscita repulsione e disprezzo (cf. Is 52,2b-3) a uno sguardo che cambia e in quelle sofferenze intravede una misteriosa causa di salvezza (cf. Is 53,4-5). Dal sarcasmo si passa all’affidamento.
In questo momento Gesù raggiunge la più profonda comunione coi peccatori, con la distanza da Dio. Gesù si è fatto peccato. Il punto più basso dell’incarnazione è insieme il punto più alto dell’amore. Gesù ha assunto nella sua carne il peccato, è entrato in comunione col rifiuto di Dio, con la seconda morte.
«Solo la coscienza di essere peccatori bisognosi di misericordia apre le porte del paradiso, nella beatitudine perfetta in comunione con Dio. La coscienza di essere perdonati ben al di là del nostro merito ci permette di vivere già qui la gioia delle beatitudini» (p. 126).
Il volume di Crimella è un prezioso aiuto per la lectio su alcune pagine decisive del Vangelo di Luca, Vangelo che rivela pienamente il volto del Dio di Gesù, un Dio di misericordia che risolve positivamente le situazioni complesse dell’uomo confrontato non solo con un’altra realtà che gli sta di fronte, ma coinvolto in realtà in un triangolo drammatico di salvezza.
settimanananews.it