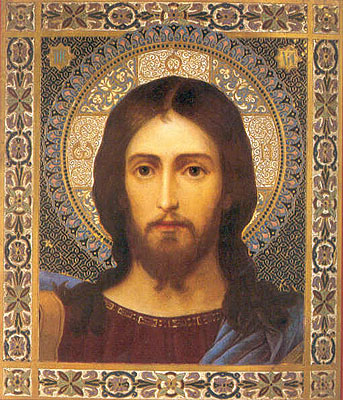Libro. La lettura della Bibbia rende presente il Signore Gesù
- Frédéric Manns, Sinfonia della Parola. Leggere, capire e meditare la Bibbia (La Bibbia e le parole), Edizioni Terra Santa, Milano 2023, pp. 288, ISBN 9791254712122 (qui).
Frédéric Manns è stato un grande esperto adorante della parola di Dio, spiegandola a livello accademico nello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e in molti altri contesti: conferenze, ritiri, articoli divulgativi… Molti di questi sono comparsi anche sull’Osservatore Romano.
Lo studioso si caratterizzava per la sua profonda conoscenza dello sfondo ebraico del Nuovo Testamento e della tradizione rabbinica in genere. Il suo volume intende aiutare a gustare la parola di Dio nella lectio divina: cosa dice il testo in sé, cosa dice a me, come rispondo al mio Dio, come agire per metterla in pratica? Attenzione, intelligenza, giudizio, decisione. Quattro tappe per far diventare la parola di Dio vita della propria vita.
L’intelligenza delle Scritture
Nell’introduzione dedicata all’intelligenza delle Scritture (pp. 13-24) Manns ricorda che la lettura della Bibbia rende presente il Signore Gesù e il suo Spirito la rende attuale e viva per la Chiesa.
La Commissione Biblica ha illustrato vari metodi e approcci al testo biblico, ma quello storico-critico resta fondamentale. Nessuna interpretazione può essere totalmente individuale, ma la Parola va letta nello Spirito che l’ha composta e in comunione con la Tradizione ecclesiale. L’interpretazione cristiana dipende in larga parte dalla Sinagoga, ma la sua peculiarità è l’interpretazione cristologica.
Gesù è il compimento delle Scritture ed esse vanno lette alla luce di Gesù, della sua parola e della sua vita, a partire dalla sua morte e risurrezione. «La Bibbia è la traccia di una storia che Dio cerca di santificare lungo i secoli. Senza la scienza del cuore, essa rimane un libro ermetico, impenetrabile […] Il cristianesimo non è una religione del Libro e la parola di Dio non sussiste al di fuori di una comunità credente. La parola di Dio non vive se non è incarnata e condivisa, giacché essa è introduzione al sacramento» (pp. 15-16).
Le parole della Bibbia compongono una sinfonia, di cui è necessario gustare la varietà dei significati. È quindi necessario conoscere e unire l’interpretazione ebraica a quella cristiana. Il popolo che ha dato Gesù al mondo e il cristianesimo che cerca di vivere il suo messaggio hanno suscitato un vasto dibattito interpretativo, come dimostra il Dialogo con Trifone ebreo di Giustino e il trattato I princìpi di Origene. Un dibattito che va approfondito. Entrambe le tradizioni danno testimonianza a Dio.
La parola di Dio ha una ricchezza inesauribile ed è risorsa essa stessa a esprimere il suo significato mediante dei simboli, perché essa supera i limiti del linguaggio razionale. In essa infatti è contenuto un mistero nascosto da secoli in Dio (cf. Col 1,26). Il simbolismo è a servizio dell’attualizzazione, ma presuppone sempre una base storica e si costruisce sempre a partire da essa.
Per comprendere il Nuovo Testamento è necessario conoscere l’Antico. È vivendo la tradizione totale del Cristo in questa ricapitolazione che si entra in un processo di spiritualizzazione. «La Scrittura ha una triplice dimensione e contiene un dinamismo verticale e orizzontale. Essa possiede un senso letterale, antropologico e pneumatico, in quanto conduce all’ascesa dell’uomo verso Dio. È, infine, una storia in atto, bisogna dunque leggerla storicamente. In conclusione, il lettore che interroga la Scrittura è interrogato, a sua volta, dalla Parola» (p. 17).
Lo studio della Parola e il suo annuncio non si contraddicono, perché è già la Bibbia ad avviare la reinterpretazione e l’attualizzazione dell’esperienza della salvezza. Sul Sinai Dio ha rivelato la sua Parola, recepita come Torah da Mosè. Dio si è fatto conoscere come l’Unico e parlando agisce, perché la sua parola ha una potenza che compie quello che dice. Nell’economia della salvezza la parola dà un senso a tutta la storia, tanto da essere personificata. La parola rivela l’azione di Dio nel mondo.
I profeti approfondirono il messaggio dell’Esodo e vi videro un modello della futura liberazione. I salmisti vi scoprirono il dramma della vita interiore che si rinnova in ciascuno. Dopo l’esilio, Esra inculcò l’obbedienza alla Torah, nel quadro dell’alleanza, per la sopravvivenza del popolo. Insegnò l’obbedienza del Sabato, che distingueva Israele dagli altri popoli. Gli scribi precisarono con minuzia ciò che era permesso e proibito di fare in quel giorno.
Nel giudaismo esistevano varie tradizioni interpretative. A differenza dei farisei, i sadducei non accettavano la Torah orale; gli esseni seguivano il metodo del pesher; il mite Hillel – che con il rigorista Shammai costituiva i più grandi interpreti della Torah – dettò sette regole ermeneutiche, rabbi Ismaël ne formulò tredici. Gesù faceva appello all’autorità di Mosè, dei profeti o di Davide, ma era libero rispetto alle tradizioni aggiunte alla Torah concernenti il Sabato e la purezza rituale. «Ritornare all’intento originario del comandamento e sforzarsi di mettere in evidenza il perché del comandamento: questo il suo disegno – sottolinea Manns –. Il duplice comandamento dell’amore era la sintesi della Torah e dei profeti. Poggiandosi sulla Scrittura, Gesù rivelava il senso della sua missione e si sforzava di mettere in luce il cuore della volontà di Dio» (p. 19).
La comunità cristiana scruta le Scritture per dimostrare che Gesù era il Messia annunciato dai profeti e il kerygma è ricco di citazioni dell’AT. Is 53 e il Sal 22 saranno importanti per comprendere la Passione di Gesù. Gesù è considerato il compimento delle Scritture.
Paolo compie spesso un’interpretazione teologica, vedendo in molti personaggi ed eventi dell’AT dei «tipi» della nuova alleanza o della persona del Cristo (cf. Adamo, l’esodo, Sara e Agar ecc.).
L’allegoria si discosta di più dal senso storico che dalla tipologia. Questa permette di vedere in un evento o un personaggio una lezione nascosta, svela un senso «spirituale» accanto al senso letterale.
La Lettera agli Ebrei istituisce un parallelismo tra antica e nuova alleanza e Melchisedek appare come figura di Cristo. Giovanni, specialmente nel racconto della Passione, mette un accento particolare sul compimento della Scrittura. «Il compimento consiste nel portare la Scrittura al suo senso pieno e alla sua realizzazione. Non poteva realizzarsi che nella persona stessa del Verbo che è il Rivelatore» (p. 20).
Il giudaismo aveva ammesso un doppio livello di lettura, il Peshât e il Derash. La tradizione cristiana conosce a partire dal III sec. una scuola di interpretazione allegorica, il cui centro era ad Alessandria, mentre ad Antiochia si praticava un’interpretazione storica.
Ad Alessandria, Origene, il suo principale rappresentante, distinguerà tre livelli di interpretazione: l’interpretazione storica o letterale, l’interpretazione morale e l’interpretazione spirituale o allegorica, che cerca il significato profondo dietro il senso letterale.
I racconti della Bibbia dovevano avere in ogni caso un profondo significato spirituale nascosto. Il senso letterale rimaneva quello preminente e i passaggi oscuri vanno chiariti alla luce dei brani dal senso più chiaro. Inoltre, il credente deve far conto sullo Spirito Santo che ha ispirato gli autori sacri e illumina i lettori che si accostano al testo con umiltà.
Unico è il Dio che ha donato entrambi i Testamenti. Una è anche la fede. Abramo desiderava vedere il giorno del Signore, lo vide e se ne rallegrò. Nei due Testamenti c’è un unico disegno di Dio che si compie. Mosè ed Elia danno testimonianza a Gesù sul monte della Trasfigurazione. Nel NT la Parola è affidata agli apostoli, che predicano Gesù risorto secondo le Scritture. La Parola cresce continuamente. La Chiesa è generata dalla Parola.
Il percorso del testo. «Il percorso che qui presentiamo è semplice – afferma Manns –: cominceremo dalla rapida evocazione dei grandi simboli biblici che permettono di comprendere meglio le Scritture; esamineremo, in un secondo momento, alcuni princìpi ermeneutici ebraici e cristiani, per poi giungere, infine, a una conclusione sulla continuità e la discontinuità di queste letture, ebraica e cristiana» (p. 22).
Alcuni simboli biblici
Nel c. 2 del volume Manns illustra vari simboli biblici della parola di Dio (pp. 25-137).
Dopo aver riflettuto sulla Parola nel suo rapporto col silenzio, egli analizza la Scrittura come il cuore di Dio. La manna è simbolo della parola di Dio, come i quattro fiumi del paradiso sono simboli della Scrittura. Essa è come l’argento, è dolce come il miele, è un pozzo d’acqua viva da scavare, una spada a doppio taglio, un medicamento, il carro di Ezechiele. La Scrittura è una luce, un tesoro, una pianta, uno specchio. L’autore studia la Scrittura, arca di Noè e arca dell’alleanza. Essa è una tromba e la Torah ha un profumo tutto suo.
Verso una teologia della parola di Dio
Il c. 3 dell’opera ha per titolo Verso una teologia della parola di Dio (pp. 138-164).
Manns elabora un percorso in vista del delineamento di una teologia della Parola.
Lo studioso esamina il brano genesiaco dove si ripete il ritornello «Dio disse», con una parola presentata come potenza creatrice performativa, che realizza ciò che dice. Dio annunzia a Giacobbe la sua parola e «la Torah del Signore è perfetta».
Peshât è il senso letterale o storico della parola e richiede critica testuale e letteraria. Il Derash indaga il significato più profondo e nascosto. «Togliti i sandali», comanda YHWH a Mosè al roveto ardente prima di rivelare il suo nome. Rapida corre la parola, un dialogo d’amore tra Dio e l’uomo.
Il Midrash è la ricerca del senso spirituale. La tradizione giudaica avverte che un testo può avere settanta significati e scava come in un pozzo. La tradizione cristiana intravede il senso spirituale della Scrittura nella ricerca tipologica e cristologica. Già l’AT rilegge e approfondisce i temi fondamentali: esodo e nuovo esodo, torre di Babele e caduta di Babilonia, giardino del paradiso e Gerusalemme futura. I profeti si servono di testi già raccolti per annunciare una religione più interiorizzata. Il Cantico dei Cantici e il Sal 40 approfondiscono il tema di Osea e di Ezechiele circa l’unione di YHWH col suo popolo. Il genere midrashico si sviluppa a partire dall’esilio.
Il NT continua l’approfondimento aggiungendovi il senso cristologico. La visione della scala di Giacobbe alludeva per i giudei a coloro che osservano la Torah rivelata al Sinai. Per i cristiani allude alla venuta storica del Verbo tra gli uomini e alla croce di Cristo. Tutto nell’AT diventa “tipo” delle realtà del NT. Il colpo di lancia del centurione al costato di Gesù compie ciò che il bastone di Mosè aveva prefigurato nel percuotere la roccia. La Scrittura è pane e diventa alimento vivificante dopo che è stata consacrata da Gesù. Gesù prese il pane della Parola e la porta a compimento sulla croce. Nella Chiesa parola e sacramento sono strettamente uniti.
I due Testamenti sono uno, e l’artefice della loro unità è Gesù Cristo. L’AT dice che cosa è il Messia, il NT dice chi è. Con la sua morte Gesù cambia l’acqua in vino, portando a compimento l’acqua amara resa dolce dal legno buttatovi dentro da Mosè su ordine di Dio. Eliseo tramuta le acque sterili di Gerico in acque vivificanti. I Padri sottolineano che questo annuncia il cambiamento che il NT compie rispetto all’AT. I due Testamenti sono le labbra della sposa che rivelano il medesimo segreto e donano lo stesso bacio.
Is 45,15-19 ricordano che «Sei un Dio misterioso, Dio di Israele, salvatore». Dio si manifesta e si nasconde allo stesso tempo. Occorre umiltà per arrivare a gustare la parola, figlia uscita dal silenzio. La Bibbia rivela un Dio che entra in alleanza con l’uomo parlando in parole umane. Per l’ebreo Heschel, il senso di questa comunione è triplice: Dio si manifesta ad Abramo come un fuoco e una presenza; il fuoco si trasforma in luce che illumina il cammino; la presenza diventa richiesta esigente quando Dio si rivela a Mosè sul Sinai. I comandamenti accettati incoronano il popolo come lo erano i re e i sacerdoti. La Torah fu data nel deserto in 70 lingue perché nessuno potesse accaparrarsela e ognuno potesse capirla nella sua lingua.
Il Midrash Esodo Rabbah narra che Dio tiene la Torah con due mani e quindi occorre il suo apporto per poter comprenderla e viverla a fondo.
Il terzo della Torah tenuto da Dio simboleggia la sua parte segreta; il terzo tenuto da Mosè evoca il senso letterale accessibile al lettore, il terzo intermedio tra le due parti rappresenta il Derash, la Torah orale trasmessa dalla tradizione.
La rivelazione del Sinai trasmette la memoria di un impegno. Essa dura un istante ma impegna per tutta la vita. «Ogni credente diventa capace di associarsi esistenzialmente in una comunanza di destino con il popolo di cui la Bibbia racconta la storia. Nella coscienza ebraica esiste un legame vitale tra l’avvenimento originale, il testo che lo riporta per iscritto, la comunità che lo riceve e la fede con la quale questa comunità vi aderisce» – scrive Manns (p. 154).
La lettura ebraica fornisce un atteggiamento sapienziale di accostamento alla Bibbia, di cui la Chiesa è erede. La lettura critica si era allontanata dalla fede. Ora si è nuovamente avvicinata, aiutata anche dal faro dell’interpretazione ebraica.
La parola di verità
Il penultimo paragrafo del capitolo medita su La parola di verità.
La verità nella Bibbia non è un concetto intellettuale, per cui ci si domanda se la Bibbia dice il vero o il falso. «La verità nella Bibbia si fonda sull’esperienza religiosa dell’incontro con Dio. Essa traduce la qualità di ciò che è stato provato e manifesta YHWH come il Dio fedele. La sua parola è verità» (p. 155). Il Sal 119 che celebra le meraviglie dalla Torah lo ripete varie volte.
«La Bibbia dice la verità quando insegna il vero volto di Dio e il senso del destino dell’uomo. Ma lo fa con il suo linguaggio orientale. Lo Spirito Santo ha accettato di passare attraverso la mediazione della cultura ebraica e degli autori sacri» (ivi). «Urge situare il testo dell’Antico Testamento nel suo contesto, nella sua cultura e nella sua epoca – continua Manns –, se si vuol trovare la verità della Bibbia» (ivi).
La Bibbia contiene inesattezze storiche e scientifiche, ma è importante ricordare che la Bibbia è una storia santa, una rilettura e una meditazione della storia di Israele. «La verità che essa propone è quella della storia dell’alleanza, e non quella della storia degli uomini. Un popolo ha visto nella propria storia l’intervento del Dio Salvatore e ne dà testimonianza; non pretende di fornire una ricostruzione storica dei fatti in base ai nostri criteri moderni» (p. 156).
«La Bibbia dice la verità: questa verità è dell’ordine della fede ed essa si inscrive nel cuore di un’avventura dei credenti che si è svolta nella storia. Tutta la Scrittura è un Vangelo, una Buona novella, una parola di Dio che trasforma il cuore. Pascal aveva compreso che vi sono tre ordini di verità, ciascuno con la propria. La verità scientifica deve ammettere l’esistenza di una verità filosofica; infine, l’ordine della carità sorpassa i primi due ordini» – conclude Manns (p. 157).
La Bibbia nella storia
La Bibbia nella storia costituisce l’ultimo paragrafo del capitolo. Esso ripercorre la storia dell’esegesi cristiana. Essa diede grande importanza al senso spirituale, specificato nel Medioevo con la teoria dei quattro sensi della Scrittura.
Col XVII secolo prevalse la lettura critica, che di fatto mise in disparte la lettura spirituale e allegorica. La Bibbia ha una dimensione storica e letteraria, che vanno conosciute. Essa possiede però anche una portata religiosa. La Chiesa ha sostenuto questo quando respingeva le letture riduttive della Bibbia, ricorda Manns.
Nelle Università del XIX secolo trionfava il razionalismo e la pretesa normativa della Bibbia faceva problema. Inoltre, essa conteneva troppi elementi irrazionali. Si pose il problema dell’assoluto della rivelazione biblica. Fu introdotta la teoria documentaria, che pareva distruggere il valore religioso della Bibbia, e fu constatata la dipendenza della Torah dai profeti e non viceversa.
La scoperta delle grandi civiltà fece vedere la Bibbia come una loro piccola ramificazione. I testi biblici furono ridotti a miti, come quelli babilonesi. Si decifrarono i geroglifici e si decifrò la scrittura cuneiforme. Si spogliò la Bibbia della sua sacra aura. Gunkel iniziò lo studio delle forme letterarie. Le scoperte archeologiche accentuarono lo spirito critico degli esegeti. Si notò la grande influenza della cultura babilonese (debitrice di quella antecedente dei sumeri).
Manns ripercorre le principali tappe della ricerca archeologica. Si scoprirono le tavolette fenicie a Biblos, quelle di Ugarit, gli archivi del re amorrita a Mari. Le scoperte di Qumran nel 1947 fecero guadagnare un millennio rispetto ai manoscritti conosciuti allora (cf. il rotolo completo di Isaia). Si scoprì che Gerico era già distrutta ai tempi di Giosuè e che, a quel tempo, probabilmente Ai era disabita.
Come leggere i testi di Giudici e di Giosuè? Gli archivi di Tell Mardick in Siria rivelarono la lingua amorrita. Manns ricorda la scoperta della stele di Dan con la menzione della casa di Davide. Importanti gli scavi a Sepphoris, a Banias, a Meghiddo, alla piscina di Siloe e a Betania oltre il Giordano. Le pietre continuano a farsi sentire, commenta Manns.
Principi ermeneutici ebraici e cristiani
Il c. 4 del volume ha per titolo Princìpi ermeneutici ebraici e cristiani (pp. 165-235).
L’autore sottolinea, innanzitutto, come occorre vivere la Scrittura per meglio comprenderla. Ricorda la traduzione dei testi in lingua greca, le interpretazioni dei sacerdoti e dei farisei. Il trattato Abot della Mishnah ricorda che occorre vivere la Parola per meglio comprenderla.
Nei secoli successivi maturerà in Israele la coscienza di essere un popolo di sacerdoti la cui missione è proclamare le meraviglie di Dio.
Hillel detta sette regole ermeneutiche, poi ampliate e messe in pratica nei Midrashim, che testimoniano come la Scrittura non sopporta un’unica interpretazione. Come il martello spacca la roccia in mille schegge, così un passo della Scrittura dà luogo a molteplici interpretazioni.
L’ermeneutica ebraica
I principali orientamenti dell’interpretazione ebraica sono due. Il Midrash halaka fissa le norme giuridiche e vede nella Scrittura la fonte dell’agire umano, mentre il Midrash aggada predilige un’interpretazione di impronta omiletica e religiosa.
Un unico principio soggiace ai due orientamenti: la Scrittura dev’essere vissuta nell’oggi. «Proprio perché dev’essere vissuta occorre precisare le norme giuridiche che la legge impone (halaka) e le motivazioni teologiche che rendono la Scrittura attraente (aggada)» (p. 168).
La Bibbia rivela sé stessa a chi la vive e interpreta, a sua volta, la vita del lettore. I moderni attualizzeranno questo principio dell’interpretazione esistenziale. Anche gli esegeti giudeo-cristiani riprenderanno questo principio. La Bibbia va letta, interpretata, proclamata, inculturata e testimoniata.
Manns illustra i princìpi insegnati da rabbi Aqiba e Rabbia Ismaele. Non basta la memorizzazione: «Solo chi accetta di lasciarsi interpellare dalla presenza che abita il testo sacro può scoprirvi una voce che parla al suo cuore» (p. 169). Bisogna studiare la Torah per viverla, per «farla», si ricorda nel commento midrashico a Lv 26,5. C’è una prassi che precede lo studio, e quest’ultimo è approfondito dall’agire. L’agire è elevato a principio ermeneutico.
La Torah è vita. Occorre insieme studiare, custodire e vivere. Nella Bibbia c’è una presenza che sollecita il lettore a una verifica delle sue affermazioni nella concretezza della vita. Chi rifiuta di agire va incontro alla morte. La Torah è acqua di vita. Davanti alla Scrittura, non è possibile la pura obiettività, ma occorre l’umiltà. Dio si è promesso al suo popolo al Sinai perché esso aveva risposto: «eseguiremo e ascolteremo». Il fidanzamento diventa un simbolo dell’alleanza di Dio col suo popolo, dell’intimità e della conoscenza reciproca.
Manns riporta testi midrashici che ripetono che la conoscenza deriva dall’azione e dall’obbedienza a Dio. L’obbedienza è possibile perché a questa disponibilità Dio risponde con il liberare il cuore dall’inclinazione al male. Diventa un cuore che ascolta.
Si afferma che la parola di Dio è strumento della creazione ed è ispirata dallo Spirito Santo. L’espressione «la Scrittura di Dio disse» spesso equivale a «lo Spirito Santo disse». Lo Spirito presente nel testo ispirerà il lettore che si impegna a vivere la Parola. «Vivere il testo diventa dunque una categoria ermeneutica, in ragione dell’essenza stessa della Parola, il vaso servito alla creazione e ispirato dallo Spirito» (p. 173).
Per comprendere la Torah occorre viverla, ma occorre anche una seconda esigenza ermeneutica: la categoria “Amore”. Si potrebbe schematizzare il cerchio ermeneutico proposto dall’autore di Sifrè Dt 41: «Occorre mettere alla base dell’agire e dello studio della Torah l’Amore; questo Amore permetterà l’osservanza dei comandamenti e lo studio della Torah, e questo studio condurrà alla Vita» (cit. a pp. 173-174).
Rabbi Aqiba morirà per decapitazione animato dalla gioia perché solo allora percepisce che mentre «dà l’anima» sta vivendo il testo dello Shema recitato tutti i giorni che richiede di amare Dio «con tutta l’anima».
L’ermeneutica giudeo-cristiana
Molti ebrei che credettero in Gesù proseguirono i criteri ermeneutici imparati nella Sinagoga. I primi cristiani rileggeranno la vita di Gesù alla luce delle profezie dell’Antico Testamento.
Manns riporta alcuni aspetti dell’ermeneutica dei Vangeli di Matteo e di Giovanni che hanno ripreso molte tradizioni giudaiche e impiegato tecniche midrashiche.
Matteo, probabilmente un rabbino convertito, sottolinea la necessità del vissuto per una profonda comprensione. L’agire deve precedere l’insegnamento ed è decisivo nel giudizio finale. Gesù è presentato come il nuovo Mosè, ma la Torah, e i Profeti mantengono il loro valore.
La comprensione dell’AT deve essere guidata dal principio dell’amore di Dio (cf. Mt 22,34-40). L’amore per Dio e per il prossimo riassumono la Torah e i profeti e ne sono i criteri interpretativi. Nel discorso della montagna Gesù segue il criterio dell’amore e radicalizza l’interpretazione giudaica delle Scritture. Occorre osservare tutta la Torah ma anche portarla al suo vero scopo.
«L’ermeneutica di Giovanni assegna ugualmente un ruolo privilegiato all’agire e al comandamento dell’Amore».
Secondo Manns, tutto il Vangelo di Giovanni è una rilettura cristologica della Genesi e dell’Esodo. Anche questa rilettura è guidata dall’importanza delle opere e dell’Amore (cf. Gv 5,39-42). Se, per i rabbini, la Scrittura è la vita, le parole di Gesù sono spirito e vita. Le opere sono importanti (cf. Gv 3,19-20). Gesù è il grande esegeta che dà il senso compiuto ai miracoli dell’Esodo. Gesù conosce il Padre, osserva la sua parola e le sue opere gli danno testimonianza.
La comprensione del testo è possibile solo a chi è guidato dal comandamento dell’Amore che riassume la Torah e i Profeti. «Il Vangelo di Giovanni aggiunge un altro principio ermeneutico: è lo Spirito che guida i credenti alla verità tutta intera (Gv 16,13)» (p. 179). Per conoscere Gesù, occorre seguire i suoi comandamenti (1Gv 2,3).
Su questo si basa il metodo della lettura esistenziale dei testi.
Principi di una lettura esistenziale
Manns esamina i principi di una lettura esistenziale dei testi (pp. 180-195), elencandone i vari elementi: Pregare il testo; I sensi spirituali; Servitore della Parola; L’al di là del testo; Attualità e attualizzazione della Parola; Assimilare il testo; In Spirito e verità.
Il Concilio Vaticano II ha confermato la lettura patristica dei testi: la Bibbia ha una profondità spirituale enorme e va letta nello Spirito che l’ha ispirata. La spiegazione storica e critica delle parole non è ancora l’interpretazione. La parola di Dio va arricchita col linguaggio umano e viceversa. «Gregorio Magno diceva che “le parole di Dio crescono con chi le legge” (In Ez. 1, 7)» (p. 194).
La lettura storico-critica è complementare alla lettura spirituale, a patto di sapere a quale registro di intelligenza dei testi essi appartengono.
Ulteriori principi ermeneutici ebraici e cristiani
Manns espone altri criteri ermeneutici che derivano dal fecondo dialogo tra l’interpretazione giudaica e quella cristiana che l’approfondisce incentrandola sulla figura di Gesù Cristo.
Lo Shema Israel è la chiave di lettura della Scrittura. Nei Vangeli si ha una rilettura dello Shema, in modo particolare nel Vangelo di Giovanni. Manns ricorda il metodo ebraico della collana (Haraz) che «infila» citazioni della Scrittura aventi in comune lo stesso tema. I testi erano legati tra loro come le perle di una collana.
L’autore affronta, quindi, il tema della Rivelazione come espressione della condiscendenza divina, studiandola nella traduzione ebraica e nella rilettura cristiana. Emergono i temi di Dio servitore del suo popolo, quello della discesa di Dio sulla terra e, infine, quello del Verbo abbreviato.
La condiscendenza divina
La condiscendenza di Dio che si fa servo culmina con l’incarnazione del Verbo. Dio si adegua alla debolezza dell’uomo. Dio educa il suo popolo con pazienza, mentre vive fra altri popoli e culture e compie pienamente il suo abbassamento in Gesù servo per liberare l’uomo. Il Verbo assume la condizione di schiavo, per ricreare l’uomo.
Giovanni Crisostomo è il «dottore della condiscendenza». Nelle omelie sulla Genesi, ricorda spesso che Dio si adatta agli uomini. «In Gregorio di Nazianzo compare un’idea nuova – scrive Manns –: la pedagogia divina è progressiva. A perfezionamenti successivi corrispondono eliminazioni graduali» (p. 228). Se l’Antico Testamento è caratterizzato da cambiamenti che nascono dalle eliminazioni, il Nuovo Testamento sarà l’era del perfezionamento grazie alle aggiunte.
All’origine della condiscendenza divina si trova la filantropia di Dio. La direzione definitiva della condiscendenza era l’incarnazione. Questo richiedeva una lunga preparazione. Il Dio compassionevole che nell’AT aveva parlato tramite i profeti, nel NT parla attraverso il Figlio. La condiscendenza trova l’apice nel fatto che Dio in Gesù ricrea gli uomini e ogni cosa. Il Verbo riconduce tutti dalla corruzione del peccato all’immortalità. La parola di Dio è l’esodo di Dio verso l’uomo per farlo uscire dal suo mondo. «Verbum abbreviatum fecit Dominus in terra, diceva san Francesco» (cit. a p. 233).
La parola di Dio è parola di alleanza che riporta l’uomo all’amicizia con Dio e alla pace. Dio persegue fino all’ultimo il suo progetto di comunione e la Chiesa getta la parola nel campo del mondo perché diventi albero fecondo e porti libertà a tutti coloro che la accolgono.
Continuità e rottura tra ebrei e cristiani nella lettura della Bibbia
Il c. 5 del volume ha per titolo Continuità e rottura tra ebrei e cristiani nella lettura della Bibbia (pp. 235-256).
Ebrei e cristiani hanno letto e commentato la Bibbia per secoli. Per vario tempo la Chiesa preferì il testo greco della LXX ma, quando seguì il testo ebraico, formulò dei commenti che assomigliavano a quelli della tradizione ebraica. La Chiesa aveva assimilato dalla Sinagoga vari elementi che risalivano alla tradizione orale. Manns illustra i contatti tra l’ermeneutica ebraica e l’esegesi cristiana mediante due esempi, uno tratto dalla Torah scritta e l’altro dalla Torah orale.
«E vide che era una cosa buona». Il problema del secondo giorno e gli angeli
Il primo esempio riguarda l’omissione del ritornello «e vide che era una cosa buona» riferita in Genesi all’opera di Dio del secondo giorno.
Le spiegazioni vanno dalla creazione della Geenna, alla divisione come causa di confusione, al fatto che la creazione delle acque fu compiuta di fatto al terzo giorno.
Girolamo pensa che il numero pari sia impuro perché introduce una divisione e quello dispari sia puro.
Le tradizioni sapienziali e apocalittiche ebraiche del I secolo speculano sulla creazione degli spiriti il secondo giorno.
Vari commentari midrashici pongono al secondo giorno la creazione degli angeli, per conservare il monopolio divino della creazione ed evitare qualsiasi forma di dualismo. «Il Targum Jonathan Gn 1,26 riflette questa idea – annota Manns –: ‘Elohim dice agli angeli che servono alla sua presenza, i quali erano stati creati il secondo giorno della creazione del mondo: Facciamo Adamo a nostra immagine. In questa versione la presenza degli angeli si spiega con la difficoltà di dar conto del plurale: “Facciamo”. Gli angeli vengono introdotti per eliminare ogni minimo sospetto di pluralità in Dio» (pp. 241-242).
«Curiosamente anche un autore medievale, celebre per la sua conoscenza dell’ebraismo, Petrus Comestor, ribadisce questa tradizione» – annota Manns (p. 242). «Le fonti cristiane e le fonti ebraiche confermano la tradizione ebraica della creazione di uno spirito o di più angeli il secondo giorno, e ciò per mantenere il monopolio divino della creazione contro gli gnostici e i movimenti dualisti. È così che le tradizioni ebraica e cristiana hanno spiegato l’assenza del refrain “E Dio vide che era cosa buona” il secondo giorno» – conclude l’autore (p. 243).
Si discute se Origene e Girolamo siano venuti a conoscenza delle tradizioni ebraiche attraverso gli ebrei o i giudeo-cristiani. Vari ambienti ebraici coltivavano un’angelologia complessa. I farisei credevano agli angeli, gli esseni si impegnavano a tenere segreti i loro nomi, Filone attribuisce a loro un grande ruolo nella creazione e nella conservazione dell’universo. Col 2,16-18 testimonia l’esistenza di un culto degli angeli in ambienti giudaizzanti.
Nel suo discorso contro i giudei, in At 7,42 Stefano ricorda che Dio si è allontanato dal suo popolo dopo il peccato del vitello d’oro, abbandonandolo al culto dell’armata celeste, cioè gli angeli maligni identificati con gli dèi pagani. Questo testo fu la base di vari testi che accusano ebrei e cristiani di adorare gli angeli.
Per i Padri, la venuta di Cristo ha segnato la fine del regno degli angeli sulle nazioni di cui parla il libro di Daniele. Così Origene e Giovanni Crisostomo, che parla di angeli custodi dei fedeli che hanno rimpiazzato quelli delle nazioni. I Padri riconoscono la presenza degli angeli nella Chiesa, in particolare nella celebrazione dei sacramenti. Nel Vangelo di Luca gli angeli salutano l’inizio e la fine della vita di Gesù.
Nell’ebraismo ogni elemento della creazione aveva il suo angelo. Gli angeli erano protettori del cosmo ed erano messaggeri di Dio presso gli uomini. Ogni nazione aveva il suo angelo e Michele era il principe di Israele, come mostra il libro di Daniele.
È in questo contesto culturale che i padri della Chiesa rilessero i Vangeli dell’infanzia. Gli angeli delle nazioni accolgono con gioia Cristo che viene a salvare i popoli. Il loro compito di protezione è terminato con successo. Alla gioia degli angeli delle nazioni e degli elementi si unirono tutte le creature celesti. Origene si rifiuta di adorare e venerare gli angeli.
La grande Chiesa reagì negativamente al culto degli angeli, ma gli ambienti giudeo-cristiani hanno mantenuto questo culto trasmettendolo ad alcune cerchie del Medioevo. Secondo lo PseudoDionigi, gli angeli hanno il compito di guidare a Dio i popoli pagani. È la prova che la teologia di Origene non fu seguita ovunque. «Molti degli elementi dell’angelologia cristiana furono mutuati dal giudaismo che, dal periodo persiano in poi, sottolineava la necessità di intermediari tra Dio e gli uomini», scrive Manns (p. 247). L’esempio del libro della Genesi illustrato dimostra secondo lui che l’esegesi cristiana deve confrontarsi con quella ebraica, sua antenata.
Il Merito dei Padri. Monti e colline
Il secondo esempio è tratto dalla Torah orale. Riporteremo come prove ampi stralci del testo di Manns, ricco di citazioni.
«La Chiesa ha […] ereditato la Bibbia interpretata dalla tradizione orale – ricorda lo studioso –. Talvolta essa ha accolto questa tradizione orale, ma più spesso ha rinunciato a integrare questo commento orale» (p. 247).
Manns illustra questo atteggiamento con un esempio tratto da Origene. Il dialogo tra ebrei ed ebrei messianici risale alle origini della fede cristiana. Un punto di dialogo riguarda il Merito dei Padri e delle Madri di Israele che rappresentano le colonne su cui poggia la fede del popolo. Ci si chiede se questo patronato sia incondizionato.
Manns ricorda che, per scorgere la portata del dialogo, non basta la conoscenza della Bibbia, ma anche quella della tradizione interpretativa orale da parte della Sinagoga, che accompagnava il commento alla Bibbia contenuto nel Targum. Il commento orale è importante per conoscere il retroterra del NT.
La tradizione sinagogale riprende più volte l’immagine dei Patriarchi paragonati alle montagne e quella delle Madri simili alle colline. «Da dove nasce questo paragone?», si chiede Manns, che cita molti testi.
«Il testo del Midrash Es R 15,26 contiene un elemento di soluzione. Si fa menzione in questo passaggio dei Patriarchi che pregano per il popolo e fanno la pace tra Dio e loro, come è scritto in Sal 72,3: “Montagne portate e voi colline la pace al popolo”. Le montagne sono i Patriarchi, come è scritto in Mic 6,1-2: “I colli ascoltino la tua voce! Ascoltate, o monti, il processo di Yhwh”. Le due citazioni possono essere servite da base al paragone che diventerà comune in tutta la letteratura rabbinica» (p. 250).
Un testo che proviene dai rotoli del Mar Morto – 11 Q Melchisedek 2, 17 (11 Q 13) –, «interpreta Is 52,7: “Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace e che dice a Sion: ‘Regna il tuo Dio’: I monti sono i profeti e il messaggero è l’Unto dello Spirito, di cui parla Daniele 9,25”.
Indirettamente questo testo permette di datare il terminus a quo della tradizione. P. Sacchi ha evidenziato l’importanza di questo testo per seguire lo sviluppo del messianismo» – sottolinea Manns (pp. 251-252).
«Nel Nuovo Testamento – prosegue l’autore –, Lc 3,4 introduce la predicazione di Giovanni Battista con una citazione di Is 40,3-5 (che non è oggetto di commento specifico nel Targum): “Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato”. Il messaggio di Giovanni Battista che segue critica coloro che sono ricorsi al merito di Abramo: “Non cominciate a dire in voi stessi: Abbiamo Abramo per padre! Perché io vi dico che Dio può far nascere figli (banim) ad Abramo anche da queste pietre (abanim)”. Più avanti, Luca 23,30 dà una diversa interpretazione dei simboli citando Am 10,8: “Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci”. Si tratta del giudizio escatologico cui partecipa il cosmo intero» (p. 252).
Manns prosegue con gli esempi. «Gv 8,39 ricorda agli ebrei che hanno creduto in Gesù che, per essere figli di Abramo, è necessario compiere le opere di Abramo e Gv 8,56 mette in relazione Abramo e il Cristo, perché Abramo esultò nella speranza di vedere il giorno del Messia, tradizione che rinvia al libro dei Giubilei. Luca 1,37 aveva presentato Maria di Nazaret come la novella Sara e l’autore della prima lettera di Pietro 3,5-6 vedeva in Sara il modello delle sante donne che riponevano la speranza in Dio. Il Protovangelo di Giacomo, un apocrifo giudeo-cristiano, non esiterà a presentare Maria come la nuova Rebecca e la nuova Rachele» (pp. 252-253).
«I Padri della Chiesa danno interpretazioni diverse al simbolo della montagna. Origene, nella sua dodicesima Omelia su Geremia, distingue i monti luminosi dai monti tenebrosi. Tra i monti luminosi, menziona i santi angeli di Dio, i profeti, Mosè e gli apostoli di Gesù Cristo» (p. 253). In altri scritti, i monti rappresentano i profeti, le colline i giusti; la montagna è applicata a Gesù mentre altrove lo è ai profeti o al popolo di Israele. Eusebio di Cesarea applica il simbolo della montagna agli apostoli.
«Dinnanzi a questa interpretazione cristiana che rifiuta di applicare il simbolo della Montagna ai Patriarchi per riservarlo al Cristo, alcuni rabbini reagiranno», annota Manns (ivi). Vale a dire che «la polemica si è impadronita dell’interpretazione del simbolo dei monti e dei colli. L’interpretazione ebraica fu criticata dalla tradizione cristiana che, a sua volta, sarà respinta dalla Sinagoga» (pp. 253-254).
Continuità e rottura. L’adempimento
Siamo di fronte al dialogo e alla rottura fra ebrei e cristiani circa l’interpretazione della Bibbia. Manns traccia un bilancio.
I due esempi riportati sopra di dialogo/polemica «mettono in luce l’atteggiamento a volte positivo, a volte polemico della Chiesa di fronte all’esegesi ebraica – prosegue lo studioso –. Troppo spesso la polemica la domina, ma sovente la ripulsa dell’esegesi ebraica implica la conoscenza della posizione della Sinagoga. La lettura cristologica della Scrittura ridimensionerà di frequente l’esegesi ebraica. In altri termini, è il Cristo che, allo stesso tempo, unisce e divide l’esegesi ebraica e quella cristiana» (p. 254).
Secondo lo studioso la differenza tra la Bibbia cristiana e quella ebraica «si rivela a partire da una giusta comprensione della categoria di adempimento. La teologia dell’ebraismo del Vaticano II – e i documenti successivi, aggiungiamo noi – aiuta a comprendere il rapporto dialettico tra i due Testamenti. Ebraismo e cristianesimo sono segnati dalla rottura e dalla continuità. È chiaro che le promesse del popolo di Dio trovano il loro compimento nella nuova alleanza. Allo stesso tempo, la Chiesa non si sostituisce a Israele. Occorre, dunque, definire la nozione di adempimento in un senso non totalizzante.
Se il Nuovo Testamento è l’adempimento dell’Antico, ciò non significa – prosegue Manns – che quest’ultimo sia privo di senso al di fuori della sua attuazione. In caso contrario, bisognerebbe spiegare il vitalismo dell’ebraismo post-cristiano. E se tutta la Rivelazione dell’Antico Testamento la ritroviamo nel Nuovo, bisogna chiedersi perché i cristiani continuino a leggere l’Antico Testamento come parola di Dio nella liturgia. In realtà, adempimento non significa abolizione. La novità del Vangelo è una rottura che introduce un senso che non abolisce la Torah né i Profeti. “Typus partem indicat”, diceva Girolamo» (pp. 254-255).
«Il confronto di Israele con la Chiesa – conclude Manns – aiuta a percepire meglio l’originalità del cristianesimo come un’alterità che non abolisce ma, al contrario, apre un rapporto con l’altro riconoscendogli una propria legittimità. Paolo, si sa, ha rotto con l’interpretazione farisaica della Torah mosaica, ma non ha per questo rotto con il racconto biblico e la memoria di Israele» (p. 255).
Manns conclude il capitolo citando il capitello della basilica di Vézelay, il mulino mistico, un vero trattato di ermeneutica. Mosè porta al mulino un sacco di grano. Un altro personaggio, che rappresenta il NT, raccoglie la farina in un altro grande sacco aperto. «Questo capitello sintetizza il rapporto dell’Antico con il Nuovo Testamento – conclude l’autore –. Esso è il grano mutato in farina che permette all’umanità di nutrirsi, non essendo il mulino mistico altro che Cristo stesso» (p. 255).
Conclusione: leggere la Parola con la Chiesa
Avviandosi alla fine della sua fatica, Manns propone una riflessione su Maria che serbava tutte queste cose nel suo cuore. Ella è l’immagine del prototipo della lettura orante della parola, custodita e confrontata con la vita, per poi essere messa in pratica con umiltà e obbedienza della fede.
Nella conclusione, egli si sofferma a riflettere sulla fame della parola, sulla necessità di leggere la Scrittura nella Chiesa e il legame che unisce strettamente Parola e sacramento.
Una bella sintesi del libro può essere espressa con le espressioni di pp. 15-16: «La Bibbia è la traccia di una storia che Dio cerca di santificare lungo i secoli. Senza la scienza del cuore, essa rimane impenetrabile. Il cristianesimo non è una religione del Libro e la parola di Dio non sussiste al di fuori di una comunità credente. La parola di Dio non vive se non è incarnata e condivisa».
Un prezioso glossario (pp. 277-279) conclude questo ricco volume sul tema della parola di Dio accostato con l’apporto della ricchezza ermeneutica contenuta nella tradizione ebraica, di cui Manns era uno dei massimi esperti in campo cattolico. Un libro ricco, impegnativo, ma suggestivo negli accostamenti e nei “voli” interpretativi tracciati tra il campo ebraico e quello cristiano, con una rottura che non elimina una continuità.