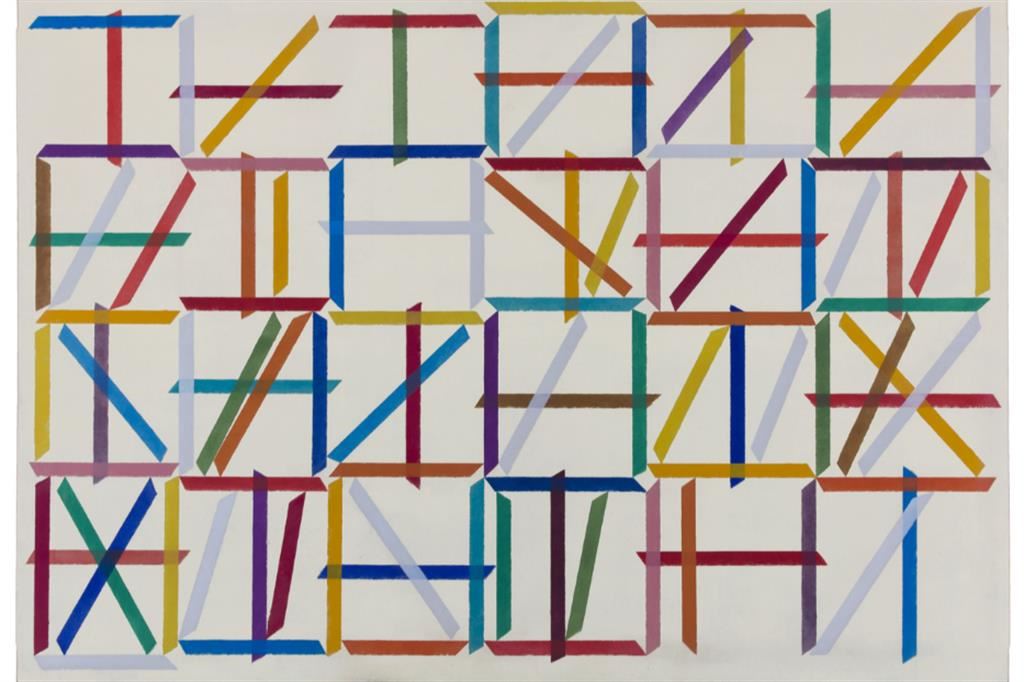Reggio Emilia. Nelle marionette l’uomo di oggi ritrova il gioco. Ma anche la gnosi

L’ingresso di Palazzo Magnani a Reggio Emilia / – Foto di Alessandro Meloni
avvenire.it
Otello Sarzi aveva una faccia da burattinaio buono, un vecchio signore dalla lunga barba bianca, ma che nella sua storia fece entrare anche la militanza antifascista. Reggio gli aveva reso omaggio nel 2022 per in centenario della nascita, ma ora ha allestito una rassegna che incorona l’arte di Sarzi con le opere dei maggiori artisti del Novecento che si sono misurati con la marionetta. Era il burattinaio che muoveva le storie per bambini e per adulti di un teatro popolare del quale, come scrisse mezzo secolo fa Gianni Rodari nel suo libro più ricco di idee, Grammatica della fantasia, Sarzi resisteva a tener desta la tradizione. Anzi, Rodari chiedeva: «Chi, a parte Otello Sarzi e pochi intimi?».
Un’arte rara e, secondo alcuni, desueta quella delle marionette, a cui Palazzo Magnani, fino al 17 marzo, dedica una rassegna che lega il mondo dell’infanzia e le avanguardie. In realtà, i burattini sono una volgarizzazione di una delle più straordinarie creazioni nate dalla predisposizione umana al simulacro. S’intrecciano e, anzi, in qualche modo hanno un loro sviluppo nelle figure della Commedia dell’arte, ma la loro storia comincia molto prima e si dirama molto dopo, nelle diverse invenzioni della scienza moderna, tant’è che James Bradburne già direttore del Museo di Brera, si spinge fino alle recentissime discussioni che mettono in gioco l’etica davanti all’Intelligenza Artificiale e «ci costringono a riconsiderare la misura nella quale anche noi possiamo essere considerati delle marionette mosse da fili, poteri o programmi invisibili».
La mostra offre molti materiali tipici della storia che burattini e marionette hanno scritto in rapporto alla nostra umanità. Da Pulcinella a Pinocchio, “il” burattino italiano per eccellenza, il teatro degli attori e quello dei simulacri si sono scambiati le parti: ancora Bradburne nota che gli inizi del Novecento segnano una trasformazione del concetto di “infanzia” sul piano del diritto e della cultura. Ed è vero, ma gli studi sulla condizione del bambino in questo passaggio della modernità, la nuova centralità dell’infanzia nella costruzione sociale, parallela all’emancipazione delle donne, non deve far dimenticare che alla fine dell’Ottocento e ai primi del Novecento il bambino è ancora un oggetto perturbante a cui vengono addossate colpe che relativizzano quelle dell’adulto. Questo sfondo che conserva una sua opacità, s’impregna di quei valori perturbanti di cui è portatore il bambino (a suo modo, una marionetta in carne e ossa, che l’adulto può manipolare perché «altamente influenzabile»). Ma, è sempre Bradburne che scrive, «il gioco creativo stesso dei bambini era una fonte estetica d’ispirazione per gli artisti che piuttosto che liquidare le marionette e i burattini come semplici giochi infantili, compresero il potenziale delle figure per immaginare un mondo migliore»: così forse lo vedeva Picasso nelle scenografie per il balletto Parade dove i costumi di scena e i personaggi raffigurati – nel contrasto fra il sipario dominato da Pegaso e il costume di scena del Cavallo –, hanno una chiara derivazione dalle fantasie infantili che diventano il fluido vitale di un’estetica cubistizzante e quasi fiabesca, ma sono anche un modo di abitare lo spazio; così si può dire per il Pupazzo bianco di Depero, la Scimmia e il Selvaggio Rosso, ovvero gli allestimenti per Strawinsky, e così via con i topi bianchi e i gatti neri, la gallina o il serpente.
Enrico Prampolini, ‘Dieci burattini futuristi’ (1922)
Enrico Prampolini, “Dieci burattini futuristi” (1922) – .
Ma ecco che l’avanguardia e l’immaginazione satirica ispirano il pezzo più bello della mostra, i Dieci burattini futuristi, riuniti su una piattaforma circolare che ruota, con le figure di diversa altezza con le caricature di Vittorio Emanuele III, Giolitti e Mussolini, Gabriele d’Annunzio e Saverio Nitti e don Sturzo, ma anche personificazioni del fascismo, del Mondo di allora, del Diavolo (forse il comunismo), cui s’aggiunge un’attrice all’epoca di grande nome, Dina Galli – l’opera, che in origine doveva avere dodici personaggi, prese forma nella collaborazione di Prampolini col Cabaret del Diavolo di Gino Gori, un ritrovo romano che veniva pubblicizzato come fantastico, geniale, intellettuale, aristocratico, mondano nei primi decenni del secolo. Fino a un paio d’anni fa questo teatrino figurava anonimo e portava la data 1922, ma grazie a una fotografia che mostra Gori e questi fantocci, Nicoletta Boschiero ha potuto attribuirne definitivamente la paternità a Enrico Prampolini. In quest’opera avanguardia e teatro di figura convivono sotto una duplice valenza artistica e politica, come fu anche per le marionette d’artista russe, quando Lenin intuì che potevano servire all’alfabetizzazione dei futuri uomini sovietici.
Sul versante astratto ed esoterico che rivive nelle esperienze del Cabaret Voltaire, di Sophie Täuber-Arp e Paul Klee al Bauhaus, e, in particolare, col geniale allievo di Oskar Schlemmer – l’autore del Balletto Triadico e riscopritore del classico di Kleist sul Teatro delle marionette – ossia Andor Weininger, il quale realizzò forme astratte colorate che stavano sulla scena sostituendo gli attori in carne e ossa, il Mechanische Buhnen-Revue che rifiutava ogni elemento naturalistico (il nuovo orizzonte del Teatro di marionette è infatti inseparabile dall’esperienza della Grande Guerra dove i giovani europei tornavano alle loro case, molti di loro feriti o mutilati. Il burattino con i suoi arti slegati e mossi da fili era anche l’immagine di un uomo a cui avessero reciso i tendini, in cui tanti forse si rispecchiavano: così potè sembrare il manichino di Carrà e De Chirico).
La persistenza del teatro di marionette giavanesi e le ricerche simboliche e orientaleggianti del burattinaio viennese Richard Teschner, che si formò all’accademia d’arte di Praga, ricreano il dualismo insito nella figura del burattino, in un legame che dal XII secolo arriva fino all’età moderna e contemporanea aprendo lo sguardo a due “prototipi” che, peraltro, trovano poco spazio nella mostra reggiana: il precedente degli automi arabi del XII secolo, di cui ci sono giunte varie documentazioni e che legano il tema della meraviglia alla scienza grazie agli “ingegnosi meccanismi” semoventi che anticipano di secoli la gnosi sepolta negli automi moderni degli inventori settecenteschi; e l’altro tema, quasi ignorato dalla mostra, del Golem che collega il burattinaio di marionette all’uomo che, nell’antica leggenda ebraica, sfida Dio, plasma un uomo artificiale dal fango ma cade sotto le more divine che puniscono l’hybris umana.