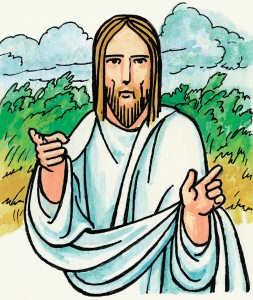ROMA, lunedì, 26 luglio 2010 (ZENIT.org).- Imparare a donare ciò che si è ricevuto è l’unico modo per sfuggire alla solitudine e all’ansia di possesso che caratterizzano l’avarizia.
E’ questo in breve l’insegnamento al cuore dell’articolo a firma di padre Giovanni Cucci, S.I., docente incaricato di Filosofia e Psicologia presso la Pontificia Università Gregoriana, dal titolo “L’avarizia, il tentativo illusorio di possedere la vita”, apparso sulla rivista “La Civiltà Cattolica” del 3 luglio scorso.
Nel saggio il gesuita mette a nudo gli aspetti essenzialmente spirituali di questo vizio, che porta a caricare il denaro e le cose in genere di “un valore simbolico spropositato” trasformandole così in “un sinonimo di stima, pace, sicurezza, potere”.
L’avarizia si identifica quindi con “la brama e l’avidità di possesso che indurisce il cuore e conduce alla presunzione di autosufficienza, di bastare a se stessi e di non aver bisogno di nulla”.
Da qui l’aspetto religioso dell’avarizia, sottolinea padre Cucci, “perché il denaro fornisce l’illusione di essere onnipotenti: il denaro per sua natura consente un’autosufficienza che nessun altro oggetto potrebbe fornire. Per Péguy esso è l’unica alternativa veramente atea a Dio, perché dà l’illusione di poter ottenere tutto, poiché ogni realtà può essere trasformata in denaro, che a sua volta consente di entrare in possesso di ogni cosa”.
Anche Marx, analizzando la mentalità capitalista, ne aveva sottolineato “il carattere di consacrazione di tutto il proprio essere a una realtà considerata come assoluta, superiore a ogni altra”.
“L’avarizia – spiega lo scrittore de ‘La Civiltà Cattolica’ –, poiché non riguarda un bisogno del corpo, né tende a un piacere ad esso proprio, ricerca una soddisfazione di tipo affettivo ma insieme impalpabile, legata all’immaginazione”.
In questo modo si configura “come una forma mondana di consacrazione a un idolo, qualcosa cui si è disposti a offrire tutta la propria vita, sacrificando per esso anzitutto la propria libertà e dignità”.
Infatti, il denaro ben lungi dal rassicurare, quando diventa fine a se stesso genera sempre nuove paure, ansie e insicurezze: “quella di perdere ciò che si è guadagnato, la paura che un rivale si aggiudichi quell’affare bramato, che si venga superati nella scala sociale, rendendo vana la fatica di una vita”.
Un altro sentimento tipico dell’avaro è la tristezza, legata alla delusione di non poter mai trovare pienamente quello che brama, ma di sentirsi sempre indigente. Da qui lo “strano masochismo” che caratterizza questo vizio, “in quanto ciò che si ritiene essere l’unica fonte di felicità, rende in realtà angosciati, fino a rovinarsi la vita”.
Inoltre c’è un legame stretto anche tra avarizia e solitudine: “l’avaro si trova a suo agio soltanto in compagnia delle cose, l’unica realtà di cui può fidarsi”, anzi l’avaro se ne è fatto plasmare a tal punto da assumerne “la medesima fissità impersonale”.
Ecco allora che la migliore cura per il vizio dell’avarizia diventa la pratica di usare “ciò che si è ricevuto perché altri possano vivere bene”.
“Tale predisposizione – spiega padre Cucci – fa infatti scattare qualcosa nel cuore di chi lo attua, il desiderio di spendere bene la propria vita, e rende la persona capace di sacrifici anche notevoli, perché il cuore è diventato sensibile alle sofferenze e ai bisogni altrui”.
Paradossalmente, scrive padre Cucci, forse “al fondo dell’avarizia c’è questo sforzo sovrumano di volersi guadagnare l’esistenza, meritarsi di vivere, una forma malata di stima di sé”.
Al contrario, però, “è nell’incontro con l’altro, nella relazione, che l’uomo ritrova la verità di se stesso”.
“Senza la gratuità – afferma il gesuita – nulla sarebbe possibile, e a maggior ragione non sarebbe possibile alcun guadagno, alcuna ricchezza; d’altra parte nessuno potrà mai pareggiare i conti, ma deve piuttosto spendersi per impegnare a sua volta ciò che ha ricevuto gratuitamente”.
“La vera ricchezza, che realmente ci appartiene, è quella che si riceve offrendo il meglio che si ha, divenendo partecipi della generosità sovrabbondante di Dio – conclude poi –. Soltanto donando è possibile uscire dalla solitudine infernale in cui si è rinchiuso l’avaro”.