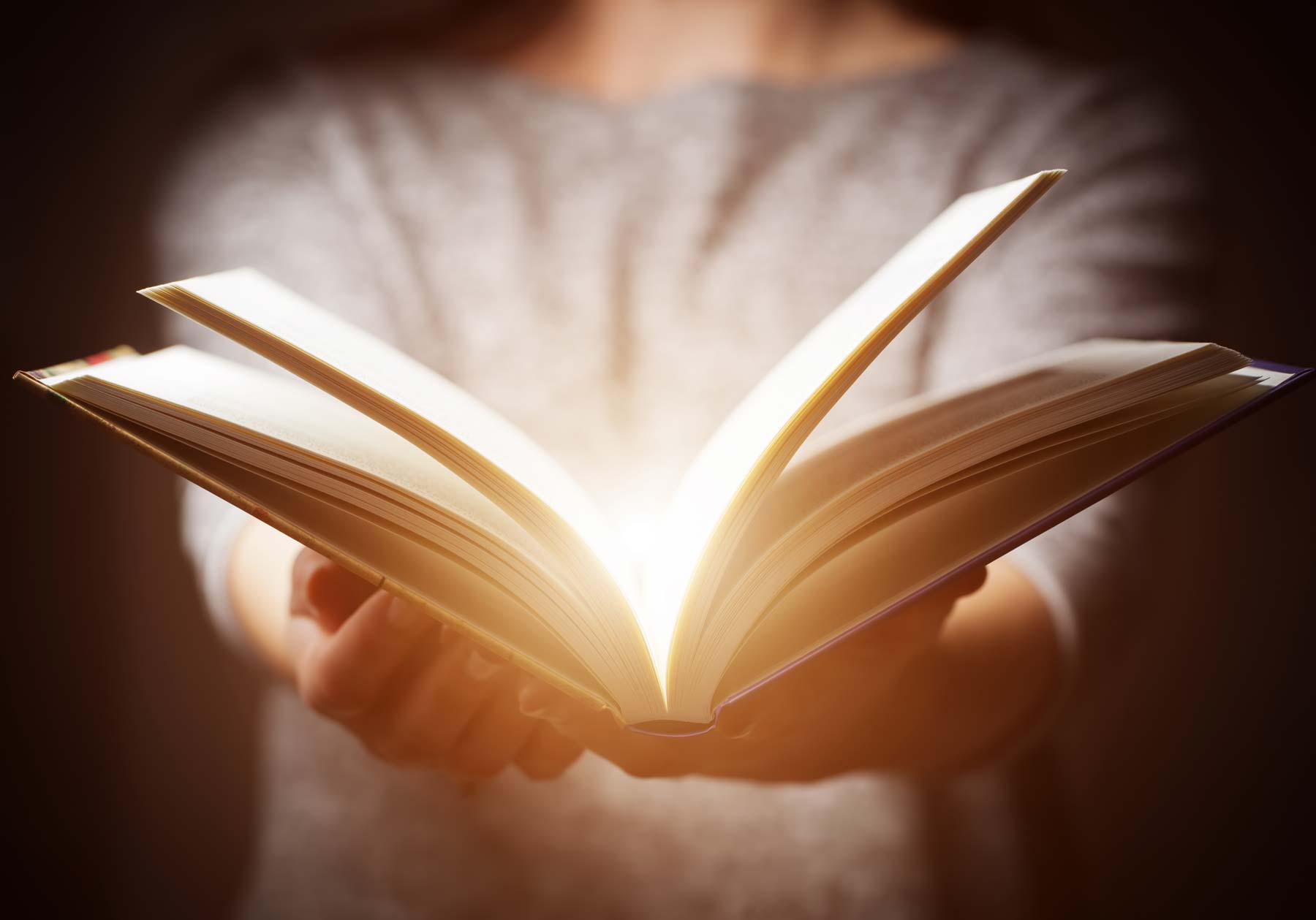di: Mariangela Maraviglia settimananews.it

Brunetto Salvarani, Senza Chiesa e senza Dio. Presente e futuro dell’Occidente post-cristiano, collana «Tempi Nuovi», Laterza, Roma-Bari 2023, pp. 248, € 20,00.
Lo storico Michele Ranchetti ricorda in un suo scritto che padre Balducci o padre Turoldo affermavano «Noi siamo gli ultimi preti». Fin dall’ultimo scorcio del Novecento era viva nei cristiani più accorti la consapevolezza di appartenere a un mondo religioso in rapida trasformazione, che non sopportava più di essere interpretato e vissuto con categorie tradizionali e chiedeva nuove forme di comunicazione e di intervento.
Nei pochi decenni trascorsi dalla loro scomparsa, entrambi nel 1992, la trasformazione ha subito un’accelerazione sorprendente, tanto che possiamo oggi constatare non solo la crisi ma la fine di quel mondo di cui entrambi si sentivano pienamente partecipi, sia pure con il fiero spirito critico che contrassegnava le loro esistenze.
Su questa crisi da anni si susseguono indagini sociologiche e storiche, letture teologiche, documenti pastorali tesi a comprendere, denunciare, sanare. Titoli eloquenti avvertono che la Chiesa «brucia», che si sta allevando «la prima generazione incredula», che «piccoli atei crescono», che le donne abbandonano la pratica religiosa rifuggendo secolari fedeltà.
Ma, oltre ai testi scritti, l’esperienza di ognuno si fa riscontro esplicito di un cambio d’epoca che sorprende e spesso sgomenta, nello scorgere il tramonto non solo di forme tradizionali di credenza ma anche di quelle esperienze ecclesiali che si sono proposte un rinnovamento radicale della fede cristiana, nello spirito del Concilio Vaticano II.
Il volume di Salvarani
Brunetto Salvarani in Senza Chiesa e senza Dio. Presente e futuro dell’Occidente post-cristiano (Laterza 2023) affronta questo cambio d’epoca, a cui si può ben dare il nome di crisi, facendo tesoro di un’ampia ricognizione di studi e documenti e senza concedere spazio alcuno a rimpianti o lamentazioni. Suggerendo, anzi, di attraversarlo come un tempo di opportunità, un chronos da vivere con la sapienza di volgerlo in un kairòs. Con le parole della scrittrice Christiane Singer ne raccomanda un «buon uso» perché «in mancanza di maestri, nella società in cui viviamo, sono le crisi i grandi maestri che hanno qualcosa da insegnarci, che possono aiutarci a entrare […] nella profondità che dà senso alla vita» (p. 4).
brunetto1
Ma perché diventi occasione, questa crisi occorre interrogarla, assumerla senza reticenze, coglierne la portata epocale sulla scorta delle tante voci che l’hanno affrontata e analizzata.
Sì – afferma Salvarani – siamo alla dissoluzione del regime di cristianità, quel microcosmo compatto e apparentemente inscalfibile che, sviluppatosi dall’età costantiniana, ha imposto per secoli, su vasti territori, concezioni etiche e sociali e idee di Dio e del dopo-vita.
Mutua dalla sociologa Danièle Hervieu-Léger i concetti di «implosione» e di «esculturazione» del cattolicesimo, a esprimere la fine della trama culturale a lungo dominante sulla scena religiosa e sociale dell’intero Occidente. Un tracollo reso più evidente dal disarmante analfabetismo biblico che ogni inchiesta certifica: la Bibbia – scrive Salvarani con espressione felice e incontestabile – è il «libro assente» dalla cultura trasmessa e condivisa: nonostante sia il «grande codice» della cultura occidentale, secondo la nota definizione del critico letterario Northop Frye; nonostante non vi sia aspetto della vita culturale e artistica delle nostre latitudini che sia leggibile senza la conoscenza del suo universo di contenuti, storie, personaggi, come ribadiva Umberto Eco.
Il «trasloco di Dio»
Un quadro dirompente, che non si risolve tuttavia nell’irrevocabile tramonto di ogni esperienza religiosa, secondo le convinte premonizioni di «eclissi del sacro» che hanno segnato la seconda metà del Novecento.
La religione dell’Occidente non scompare – ricorda Salvarani –, piuttosto subisce quella che il sociologo Luigi Berzano chiama «quarta secolarizzazione» e, da istituzione che organizza la vita pubblica, si trasforma sempre più in patrimonio di singoli individui che si ritagliano una variegata «autonomia degli stili» del credere.
Scompare la figura del praticante regolare e della civiltà parrocchiale, si afferma la figura del «pellegrino», icona di un paesaggio religioso in movimento, di «dinamiche del fai da te», in un contesto diffuso e condiviso che avverte con identica legittimità i percorsi spirituali più diversi, l’appartenenza condizionata, l’autogestione o anche l’abbandono della pratica religiosa.
Se quanto detto vale per la gran parte dei vissuti religiosi italiani, europei, nordamericani, non rappresenta la realtà di altre aree del mondo, soprattutto dell’Africa e dell’America Latina, dove si assiste a un autentico «trasloco di Dio».
Con questa formula accattivante e con molte cifre alla mano, Salvarani rappresenta realtà religiose in piena fioritura in quei continenti, vitalità inesauribili di gruppi, per lo più carismatici ed estranei alle confessioni tradizionali, che realisticamente rappresentano tanto presente e forse gran parte del futuro del cristianesimo. Gruppi di cui non cela le criticità nell’approccio emozionale e conservatore sui versanti della fede, della dottrina e della morale, oppure nel concentrarsi in una «teologia della prosperità» che riduce la fede a una individualistica richiesta di immediata salute, felicità, ricchezza.
Abitare con sapienza la crisi
Di fronte a un quadro tanto complesso e confuso, a un pluralismo aperto a inedite possibilità ma non certo acquietante, Salvarani non cede a impostazioni autodifensive o a logiche di conflitto, né a salvaguardare qualche «rottame della cristianità» (citazione da Giuseppe Dossetti). Crede, piuttosto, che occorra imparare ad abitare la crisi esercitando il coraggio di «un pensiero dotato di immaginazione e fantasia», la pazienza «di educarci al dialogo all’interno e all’esterno», senza pretendere di possedere facili quanto illusorie soluzioni.
La via della formazione gli appare la risorsa necessaria per «seminare futuro», ripartendo dalla centralità della Bibbia e dalla persona di Gesù Cristo, ma senza timore di percorrere itinerari di dialogo o di inaugurare esperienze di inedito «meticciato», parola chiave della sua proposta, tra religioni e culture.
Ripartire dalla Bibbia, da rilanciare con le dovute metodologie, nelle chiese, nelle scuole e ovunque si faccia educazione: «Le nuove generazioni, per vivere consapevolmente in una società multireligiosa, hanno bisogno di conoscere e di capire la realtà e la complessità del fenomeno religioso: conoscere e capire è, a un tempo, la condizione di una fruttuosa convivenza e di una matura consapevolezza della propria identità. Della quale la Scrittura, piaccia o no, almeno in Occidente, fa parte da tempo immemorabile» (p. 145).
Ripartire da una fede in Gesù Cristo che tenga insieme atteggiamento dialogico e annuncio profetico, che riconosca «i raggi di verità divina che si trovano all’interno delle religioni del mondo» e insieme annunci «senza esitazioni, fedelmente […] il nome, la visione e la Signoria di Gesù Cristo» (p. 123). Alla scuola di tanti maestri, tra i quali spiccano, sullo sfondo del Concilio Vaticano II, papa Francesco, Raimon Panikkar, Bruno Hussar.
Maestri e profeti per questo tempo
Papa Francesco con il suo ecumenismo del «poliedro», la sua proposta di una unità tra cristiani in cui ogni parte, diversa dall’altra, conserva la sua peculiarità e il suo carisma (p. 73); con il riconoscimento – in documenti come quello firmato ad Abu Dhabi sulla fratellanza umana (2019) e l’enciclica Fratelli tutti (2020) – di una Chiesa che «come non integra e non prende il posto di Israele, allo stesso modo non integra e non sostituisce la parte di verità religiosa di cui un’altra religione può essere portatrice» (p. 79).
Bruno Hussar, domenicano ebreo vicino agli arabi, fondatore del villaggio della pace di Neve Shalom/Wahat as-Salam, è convinto che «Gesù è ebreo e lo è per sempre», e che, a partire dalla sua umanità storicamente ebraica, occorra «camminare in una vita personale e comunitaria, il più possibile umana e umanizzata» (p. 178).
Raimon Panikkar, il teologo indo-spagnolo che nella sua originale dichiarazione di fede («Sono partito cristiano, mi sono scoperto hindu e son ritornato buddhista senza mai smettere di essere cristiano») incarna il «bisogno vitale del cristianesimo di inculturarsi coraggiosamente nelle più frastagliate tradizioni» (p. 147).
Tutti maestri che interpretano nelle loro diverse realtà lo stile di Gesù: stile del dono, della relazione, dell’ospitalità che Salvarani indica al presente e al futuro dei cristiani.
Grande cultore di letteratura raffinata e popolare, di canzoni e di cinema, l’autore regala ai suoi lettori citazioni e passaggi tra i più toccanti che si possano leggere e ammirare nella produzione contemporanea. Come l’autobiografico Servabo di Luigi Pintor (1991): «Non c’è in un’intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi». Come la fiaba del film Il pranzo di Babette (1987), grande parabola di «carità ospitale» e del miracolo di ritrovata armonia che può sorgere dal dono amoroso di un’arte e di una vita.
Operando nel contesto di un paesaggio sempre più secolarizzato, e insieme affollato di proposte spirituali, teologiche, etiche variegate, per le Chiese cristiane c’è davvero da «rimboccarsi il pensiero», come raccomanda Salvarani. Che dona un contributo doppiamente “necessario”: perché ricco di voci e sollecitazioni per riflettere su un presente ineludibile; perché animato dallo sguardo fiducioso di un confronto possibile e di una partita aperta, da giocare come cattolici nel cammino del Sinodo, occasione e scommessa di nuove possibili narrazioni, anche nel nostro tempo, di una buona Novella.