
Non sono né un teologo, né un prete, né un monaco, né un insegnante di religione. Solo un credente che – come direbbe Erri De Luca in Ora prima, Edizioni Qiqajon 1997, pag. 7 – «in obbedienza al participio presente del verbo» credere cerca di rinnovare «il suo credo continuamente». Di tanto in tanto e mai con approcci meramente intellettualistici privi di una reale rispondenza con la vita di fede, frequento anche testi di teologia cristiana.
Quando, nei giorni scorsi, ho visto in libreria Evviva la teologia – La scienza divina (Edizioni San Paolo, 2020), l’ho acquistato a occhi chiusi, avendone letto in caratteri cubitali il nome dell’autore: Armando Matteo.
Docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana, Matteo è davvero – come scrive Brunetto Salvarani in Dopo – Le religioni e l’aldilà, Editori Laterza 2020, pag. XXIII – «un teologo capace di parresìa». Per averci negli anni regalato saggi particolarmente incisivi nell’analizzare la complessità delle attuali condizioni del credere e nel tradurre i contenuti della fede cristiana nel linguaggio e nella sensibilità degli uomini e delle donne della post-modernità, mi sembra che lo si possa a ragione inserire tra i teologi italiani che non si accontentano «di una teologia da tavolino» (Francesco, Evangelii gaudium n. 133).
Obiettivo di “Evviva la teologia”
Convinto che la teologia cristiana nella versione cattolica non sia «solo una cosa da preti e di chi decide di farsi prete» (pag. 8), Matteo, con questo suo ultimo volume – decisamente godibile per stile di scrittura e semplicità di linguaggio – si pone l’obiettivo non di fornire un’ennesima storia della teologia, ma di compiere, con il lettore, un viaggio per mettere a fuoco «uno stile teologico capace di stare al passo delle generazioni di uomini e di donne che ora abitano questo mondo e dunque in grado di riuscire a suscitare, esattamente nei loro cuori, un libero e vivo desiderio di porsi all’ascolto della singolare parola di Gesù circa il mistero più grande di ogni mistero: il mistero di Dio» (pag. 15).
Mistero «la cui vastità e inesauribilità richiede sempre nuovi sforzi di comprensione e di attenzione» (pag. 23). Sì, perché di Dio e del suo mistero è possibile dire qualcosa, avendo Dio detto qualcosa di sé attraverso Gesù di Nazareth.
Gesù di Nazareth: luogo generativo della teologia cristiana
Il «luogo generativo» della teologia (discorso/logos su Dio/theos) cristiana è proprio Gesù: in lui «Dio si dà in persona» (pag. 42).
È da Gesù che la teologia, ogni volta, parte e riparte. «Si aggrappa alle sue parole, ai suoi gesti, alla sua vicenda, per afferrare sempre meglio e sempre più ampiamente la novità che quelle parole, quei gesti, quella vicenda hanno immesso nello spazio del sapere umano circa il mistero di Dio, la sorte dell’uomo e la consistenza del mondo, a quel mistero profondamente intrecciate» (pag. 11).
«Senza un vigoroso corpo a corpo» con Gesù di Nazareth, «senza un confronto senza sconti con le sue parole, con i suoi gesti, con l’interezza della sua vicenda», così come i Vangeli ci narrano, «per il cristianesimo, non si dà teologia e dunque non si dà un discorso su Dio» (pagg. 36-37).
L’avvincente viaggio che il prof. Matteo compie con il lettore non può, dunque, che prendere avvio proprio da quegli scritti particolari che si chiamano Vangeli (pagg. 51-66).
Incarnare la fede nella vita, cioè mediare tra fede e culture
Ma per dire agli uomini e alle donne del nostro tempo la novità di Gesù – cioè di «quel giovane ebreo che, oltre duemila anni or sono, ha avanzato la pretesa di portare, o meglio di essere, una parola decisiva a proposito del mistero di ogni mistero: a proposito di Dio» (pag. 33) –, la teologia, in quanto strumento di mediazione tra la fede e le culture, deve essere non «disquisizione cattedratica sulla vita, ma incarnazione della fede nella vita», dal momento che – e sono parole usate da papa Francesco, incontrando il 29 novembre 2019 i membri della Commissione teologica internazionale – «solo una teologia bella, che abbia il respiro del Vangelo e non si accontenti di essere soltanto funzionale, attira» (pag. 14).
Per il docente della Pontificia Università Urbaniana chi pratica la teologia non può non avvertire il bisogno impellente di intrattenere «rapporti viscerali con le dinamiche profonde della cultura al cui interno essa si realizza» (pag. 12).
A tal fine, il teologo disponibile – sono ancora parole di Francesco – a diffondere con dolcezza e rispetto «il gusto buono del Vangelo ai fratelli e alle sorelle del proprio tempo» non si risparmierà alcuna fatica. «E così, soprattutto nel tempo che ci è dato vivere, egli leggerà e studierà e approfondirà ogni romanzo e ogni saggio filosofico-sociologico-psicologico e ogni film e ogni programma televisivo e ogni canzone e ogni opera d’arte ma anche ogni nuovo capo di abbigliamento e ogni nuova applicazione per il cellulare e ogni nuovo cambiamento di slang e ogni nuovo taglio di capelli e altro ancora che sembra promettergli un aiuto per gettare uno sguardo sul cuore dei suoi contemporanei e verificare quanto e quale possa esservi per una parola su Gesù, per una parola di Gesù» (pagg. 173-174).
 Mediare tra fede e cultura, tra fede e modi con i quali gli umani si rapportano con il mondo è proprio il compito della teologia. Spetta ad essa trovare, in mezzo al «fiume di culture che si succedono l’una all’altra, le parole, i gesti e i modi più pertinenti per dire la verità, l’unicità, la bontà e la bellezza di Gesù e per dire tutto ciò in modo che (…) in ogni stagione storica chiunque possa intendere quanto la propria personale storia possa beneficiare dell’intrecciarsi con quella di Gesù» (pag. 75).
Mediare tra fede e cultura, tra fede e modi con i quali gli umani si rapportano con il mondo è proprio il compito della teologia. Spetta ad essa trovare, in mezzo al «fiume di culture che si succedono l’una all’altra, le parole, i gesti e i modi più pertinenti per dire la verità, l’unicità, la bontà e la bellezza di Gesù e per dire tutto ciò in modo che (…) in ogni stagione storica chiunque possa intendere quanto la propria personale storia possa beneficiare dell’intrecciarsi con quella di Gesù» (pag. 75).
Sostanzialmente la teologia serve a costruire ponti tra Gesù e il cuore della gente che si avvicenda lungo i secoli. «Un compito affascinante, sublime. Un compito faticoso, disperante» (pag. 75). Perché è indubbiamente laborioso individuare i modi efficaci per far sì che la proposta di Gesù raggiunga e scaldi il cuore degli uomini e delle donne del tempo in cui vivono.
Insomma, «finché c’è storia umana, la teologia non può andare in ferie» (pag. 76), perché «la teologia non si dà mai una volta per tutte» (pag. 12).
L’epoca dei mistagoghi e delle mistagoghe
Ben quattro capitoli del saggio sono dedicati ad indagare come i teologi, in duemila anni di storia della cristianità, si sono esercitati nel compito di mediazione tra Gesù e il suo Evangelo e «la continua opera di creazione culturale che ogni generazione che viene al mondo compie» (pag. 76).
Dai Padri della Chiesa (pagg. 81-97) ai Dottori della Chiesa (pagg. 99-117), dall’epoca degli Apologisti (pagg. 119-236) alla nostra epoca dei Mistagoghi (pagg. 137-153).
Mi voglio brevemente soffermare sull’ultima tappa del viaggio proposto da Matteo: quella del nostro tempo, che si è soliti indicare come tempo della postmodernità. Tempo nel quale la fede non si trasmette più semplicemente per tradizione, familiare o sociale, come se la si dovesse continuare a considerare come qualcosa di ovvio per tutti, ma è sempre più oggetto di scelta consapevole e criticamente avvertita, in presenza di un pluralismo crescente di credenze e di non credenze.
Quella della postmodernità è l’epoca dei mistagoghi, l’epoca di una sorta di «agenti segreti di Dio», che hanno il compito di risvegliare, nei «cuori dormienti» (pag. 80) degli umani il desiderio di Dio, accompagnandoli in percorsi specifici e strutturati che li aiutino a irrobustirsi nella vita di fede e attivando potenzialità creatrici analoghe in qualche modo a quelle messe in opera nell’epoca neotestamentaria.
A tal fine, i tempi che viviamo necessitano di un discorso teologico in grado «non solo di trovare i modi per strappare all’estraneità diffusa Gesù e il suo Vangelo e farli riverberare come interessanti alle menti e ai cuori degli uomini e delle donne postmoderne, ma anche di indicare, a questi ultimi, giardini fioriti dove poter coltivare quel seme di interesse cristiano con tanta fatica spuntato nel loro cuore» (pag. 166).
Ma, purtroppo, al momento è abbastanza facile constatare che «le attuali strutture ecclesiali quasi per nulla assomigliano a giardini fioriti, nei quali abbondante scorre l’acqua fresca della lettura dei Vangeli e sopra ogni ombra splende il sole nutriente della preghiera» (pag. 166).
La Chiesa di oggi, le nostre comunità, le nostre associazioni, i nostri movimenti, noi cristiani di oggi, io credente che, in obbedienza al participio presente del verbo credere, cerco di rinnovare continuamente il mio credo… tutti abbiamo più che mai bisogno di mistagoghi e mistagoghe con le caratteristiche delineate da Armando Matteo in questo suo bel saggio: persone che hanno la passione «di creare ponti tra il Vangelo di Gesù e l’incessante variazione dei contesti culturali lungo il succedersi delle generazioni umane» (pag. 101), persone capaci di scaldare i cuori parlando «di Gesù e a partire da Gesù» (pag. 174), persone che sanno trovare e usare le parole adatte per comunicarci che il Vangelo di Gesù «sempre permette a chiunque di essere all’altezza della parte migliore di se stesso» (pag. 181).
E anche persone – come ha scritto Francesco nella lettera indirizzata il 3 marzo 2015 al Gran Cancelliere della Pontificia Università Cattolica Argentina – che «odorano di popolo e di strada» e che, con la loro riflessione, sanno «versare olio e vino sulle ferite» degli uomini e delle donne del nostro tempo.
Un piccola testimonianza personale
Chi, dopo avere letto con grande piacere e interesse il saggio di Armando Matteo, ha steso queste note partecipa e contribuisce ad animare una piccola associazione («La Tenda dell’Incontro Giovanni Giorgis»), nata trent’anni fa per diffondere la conoscenza della Bibbia a livello popolare su iniziativa di Giovanni Giorgis, presbitero della diocesi di Mondovì (CN) e docente per 35 anni di sacra Scrittura nel seminario monregalese e alla Facoltà teologica di Torino.
Poco prima della sua morte, avvenuta cinque anni fa all’età di 90 anni, don Giorgis ci chiese di continuare l’esperienza associativa con le nostre forze e le nostre capacità.
Lo stiamo facendo, grazie alla disponibilità di amici teologi e amiche teologhe – tutti e tutte semplicemente eccellenti – che, su nostra richiesta immediatamente accolta, con grande competenza e bravura ci stanno facendo da guida nella realizzazione dei nostri programmi, offrendoci un aiuto straordinariamente efficace per irrobustirci nella nostra vita di fede e facendoci gustare la bellezza della novità di Gesù. Tutte persone che – mi sembra di poter dire con certezza – concepiscono e forniscono il loro servizio a livello teologico esattamente secondo quanto indicato in modo magistrale da Armando Matteo.
Dunque, evviva la teologia! Quando sa adoperare «ogni risorsa di intelligenza e di sentimento per ridurre, assottigliare, fin quasi far scomparire la linea di demarcazione» tra «coloro che pensano che le parole, i gesti e la vicenda di Gesù, consegnati ai Vangeli, siano affidabili e coloro che pensano che quelle stesse parole, questi gesti e quella vicenda siano inaffidabili; tra coloro, dunque, che pensano che la storia di Gesù abbia a che fare con la storia della loro felicità e coloro che pensano che la storia della loro felicità non abbia a che fare con la storia di Gesù» (pag. 173).
Settimana News
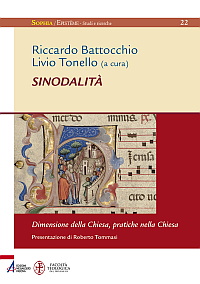





 Mediare tra fede e cultura, tra fede e modi con i quali gli umani si rapportano con il mondo è proprio il compito della teologia. Spetta ad essa trovare, in mezzo al «fiume di culture che si succedono l’una all’altra, le parole, i gesti e i modi più pertinenti per dire la verità, l’unicità, la bontà e la bellezza di Gesù e per dire tutto ciò in modo che (…) in ogni stagione storica chiunque possa intendere quanto la propria personale storia possa beneficiare dell’intrecciarsi con quella di Gesù» (pag. 75).
Mediare tra fede e cultura, tra fede e modi con i quali gli umani si rapportano con il mondo è proprio il compito della teologia. Spetta ad essa trovare, in mezzo al «fiume di culture che si succedono l’una all’altra, le parole, i gesti e i modi più pertinenti per dire la verità, l’unicità, la bontà e la bellezza di Gesù e per dire tutto ciò in modo che (…) in ogni stagione storica chiunque possa intendere quanto la propria personale storia possa beneficiare dell’intrecciarsi con quella di Gesù» (pag. 75).

