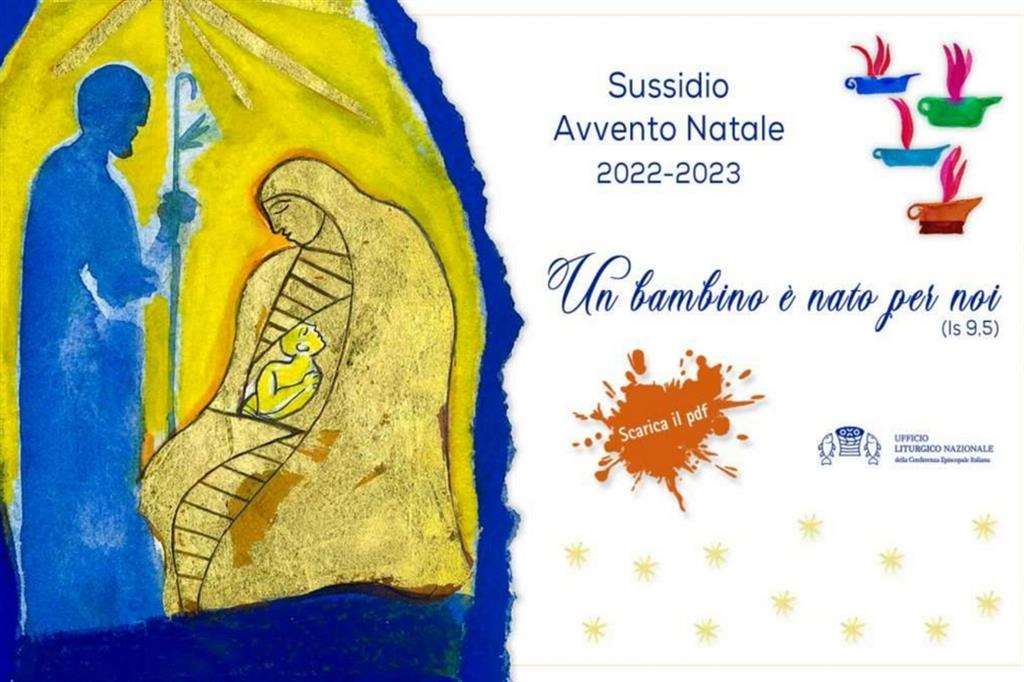Circa tre ore di domande e risposte tra Francesco e i vescovi italiani, riuniti in Aula Nuova del Sinodo per la 77.ma Assemblea generale. Tra i temi, come riferito da alcuni vescovi a margine dell’incontro: la pace, le finanze, l’ambiente, le ideologie, il ministero di vescovi e sacerdoti, la carità verso poveri e rifugiati. Al termine del colloquio, il Pontefice ha fatto dono ai presuli del libro “Fratellino” che riporta i drammi di un giovane migrante fuggito dall’Africa
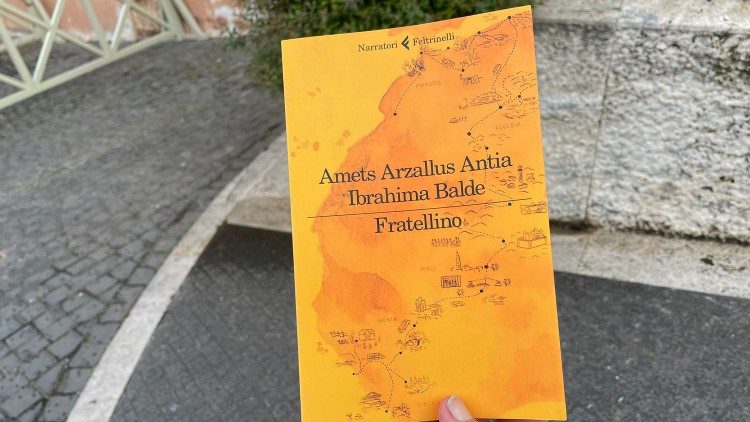
Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano
Giovani e vocazioni, finanze ed ideologie, ministero dei sacerdoti e seminari, pace, ambiente e attenzione per la carità. Caratteristica, quest’ultima, della Chiesa italiana verso la quale ha manifestato grande stima. È stato un dialogo franco e sereno quello di oggi pomeriggio, 22 maggio, tra Papa Francesco e gli oltre 200 vescovi della Conferenza Episcopale italiana, riuniti per la 77.ma Assemblea generale in Vaticano. Il Papa ha aperto i lavori dell’appuntamento primaverile dei vescovi, al via oggi fino al 25 maggio in Aula Nuova del Sinodo, sul tema “In ascolto di ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Passi verso il discernimento”.
Domande e risposte
Circa tre ore il colloquio del Papa con i presuli di tutte le regioni del Nord, Sud e Centro Italia, iniziato in anticipo con un momento di preghiera comune e con il saluto del Pontefice ai vescovi delle zone colpite dal nubifragio in Emilia-Romagna. L’intero incontro, a porte chiuse, è stato poi intervallato – come consuetudine in queste occasioni – da domande (una quindicina oggi pomeriggio) e risposte. Tra gli argomenti principali, come riferito da alcuni vescovi a margine dell’incontro, il calo di vocazioni, i seminari e i loro possibili accorpamenti. Un tema, quest’ultimo, affrontato dal Papa anche nell’udienza di fine marzo scorso con i vescovi della Conferenza episcopale calabra. Focus anche sul ministero dei sacerdoti, ai quali, come sempre, il Pontefice ha chiesto ai vescovi di mostrare vicinanza.
Incoraggiamento alla carità
Non è mancato un riferimento alla pace, in Ucraina e nel mondo, urgenza che riguarda tutti, poi alle ideologie del nostro tempo, quindi i diversi problemi culturali e la questione delle finanze, che spesso rappresentano una difficoltà per la Chiesa. Al centro anche le problematiche ambientali per le quali è necessario un cambio di mentalità. Uno “stile nuovo” è anche quello richiesto dal percorso sinodale che coinvolge la Chiesa dei cinque continenti: la tematica è stata al centro di alcune domande. Insieme a questo anche l’invito ad avere attenzione alle povertà, vecchie e nuove, e soprattutto a non far mancare mai la carità. In particolare sull’aspetto caritativo, il Papa ha espresso la sua stima verso la Conferenza episcopale italiana, impegnata da anni nell’accoglienza di migranti e rifugiati.
In dono il libro “Fratellino”
E proprio in tema di migranti, Papa Francesco, al termine dell’incontro, ha fatto dono ad ognuno dei vescovi della CEI del libro “Fratellino”, volume che racconta in modo lucido e a tratti crudo la vita del migrante Ibrahima Balde, trascritta dal poeta Amets Arzallus Antia. Si tratta della storia di un giovane della Guinea che ha lasciato il proprio Paese per ricercare il fratello piccolo, partito a sua volta per raggiungere l’Europa. Destinazione mai raggiunta. L’autore riporta i drammi vissuti in prima persona: la traversata del deserto, il traffico di esseri umani, la prigionia, le torture, il viaggio in mare, la morte. Papa Francesco ha citato in più occasioni il volume, edito in Italia da Feltrinelli, sia in alcune conferenze stampa in aereo di ritorno dai viaggi apostolici, sia in alcune udienze. L’ultima, quella con i rifugiati giunti in Europa attraverso l’iniziativa comune di Sant’Egidio, Chiese evangeliche, Tavola valdese e Chiesa italiana, ricevuti in Vaticano il 18 marzo. Un “libretto”, lo ha definito il Papa, che tratteggia in tutta la sua drammaticità “la Via Crucis” di tanti fratelli e sorelle nel mondo.
Il saluto ai vescovi dell’Emilia-Romagna colpita dalle alluvioni
A margine dell’Assemblea il Papa ha salutato i vescovi dell’Emilia-Romagna, colpita in questi giorni da incessanti e devastanti alluvioni. Dopo aver ascoltato il racconto del dramma che stanno vivendo le persone e appreso dei tanti gesti di solidarietà messi in campo, Francesco ha chiesto di portare la sua partecipazione alle comunità assicurando la personale preghiera. Era stato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, a raccontare all’inizio dell’incontro quanto accaduto con il nubifragio, le varie situazioni di difficoltà vissute dalla gente e i tanti gesti di solidarietà e di aiuto. Poi al termine, Zuppi insieme al vicepresidente della Ceer, monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia, a monsignor Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola, monsignor Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, e a monsignor Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, hanno avuto modo di salutare personalmente il Papa ed esprimergli gratitudine “per il suo messaggio di solidarietà dei giorni scorsi”. In una nota, i presuli sottolineano di aver “accolto” lo stimolo del Pontefice “per un’ulteriore riflessione sul rispetto del Creato e la custodia della casa comune”. “Gli abbiamo ricordato – dicono – che i romagnoli sono tenaci ma le prove si stanno ripetendo troppo spesso e che abbiamo bisogno della sua preghiera e vicinanza”.
Baturi: dal Papa l’invito a un nuovo slancio di evangelizzazione
Quanto al dialogo a porte chiuse del Papa con i vescovi, ha riferito dettagli pure il segretario generale della Conferenza episcopale, monsignor Giuseppe Baturi, che a Tv2000 ha parlato di “un incontro importante perché a contatto con i problemi del Paese e della Chiesa”. “Il Papa – ha spiegato il vescovo – ha sottolineato l’urgenza di un nuovo slancio di evangelizzazione che passa attraverso una testimonianza credibile… I vescovi sono chiamati ad avere compassione dell’uomo, ad averne cura soprattutto nelle situazioni di difficoltà e bisogno. È stato un incontro che ci ha incoraggiati a proseguire su questa strada che trova nel cammino sinodale un alveo privilegiato di confronto e lavoro”.
vaticannews



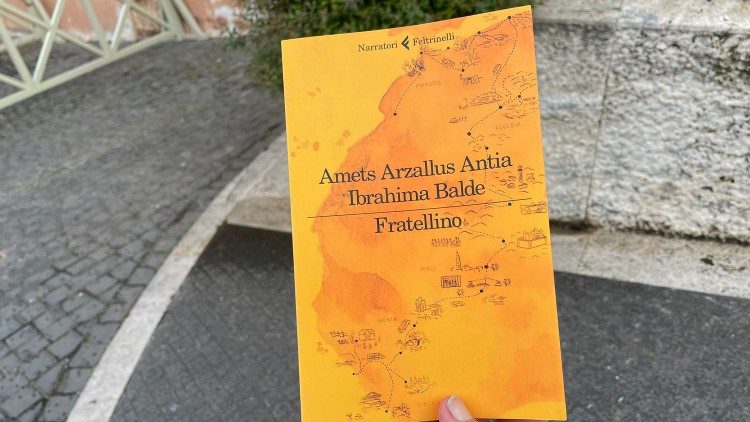





.jpg?width=1024)