Commento al Vangelo: siamo tutti mendicanti di luce. Come Pietro. II Domenica di Quaresima Anno A
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui (…) La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci spiazza subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, al monte della trasfigurazione; dall’arsura gialla, ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita intera mostra la sua verità profonda, che un poeta esprime così: «Tu sei per me ciò ch’è la primavera per i fiori» (G. Centore). «Verità è la fioritura dell’essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il percorso della realtà è come quello dello spirito: un crescere della vita.Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in alto, là dove la terra s’innalza nella luce, dove l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, dove nascono le acque che fecondano la terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito se non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso l’esterno, cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore. L’entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello»
gridato a pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere l’icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor.Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e non illumini l’uomo, «non ci interessa un divino che non faccia fiorire l’umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura dell’umano, il rigoglio della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire davvero alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per nascere del tutto.Viene una nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio.
Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme di luce. La via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi.
(Letture: Genesi 12, 1-4; Salmo 32; 2 Timoteo 1,8-10; Matteo 17, 1-9)

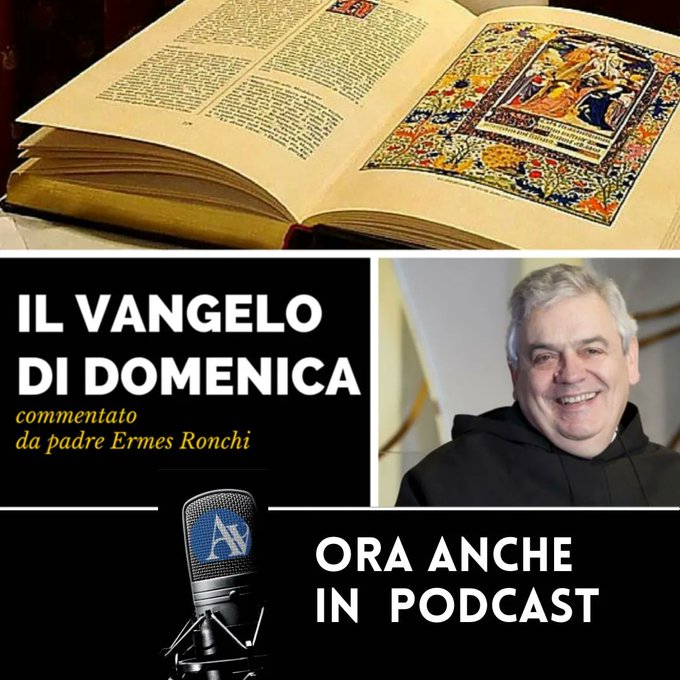

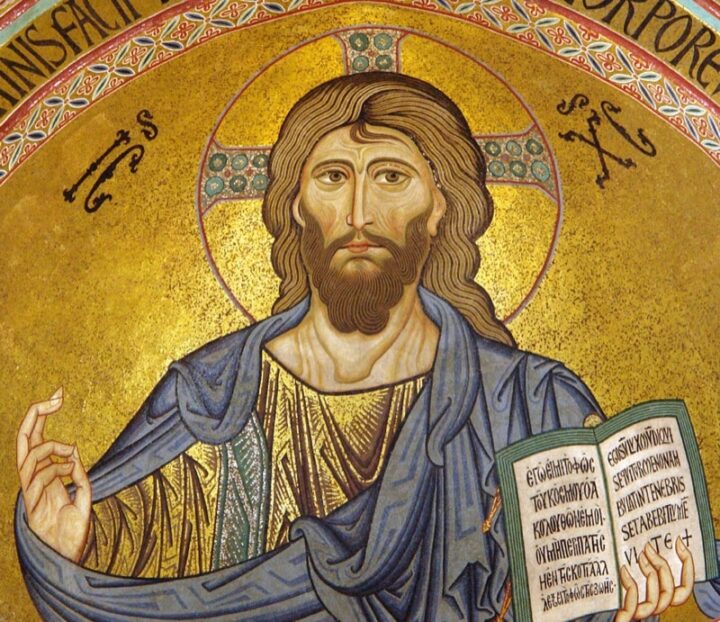
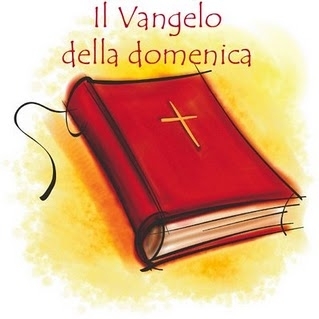
.jpg?width=1024)
.png?width=1024)
