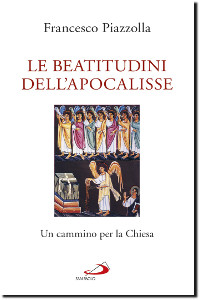“Gaudete et exsultate”: ripensare la santità
Parlare oggi di santità è rischioso. Vi è la reale possibilità che nessuno ti stia veramente ad ascoltare. Nella comprensione di ciò che, per lo più, la santità rappresenta sembra permanere una certa dose di ambiguità. Nel comune sentire il relativo concetto si direbbe attraversato da stereotipi e pregiudizi che impediscono di vederne la vera profondità teologica. Per lo più la santità viene identificata con fenomeni straordinari, con vite di persone eccezionali non imitabili, con eventi miracolosi, con agiografie edulcorate, con canonizzazioni frettolose, con la negazione del corpo, del mondo e della storia.
Eppure papa Francesco, trascorsi cinque anni esatti dall’inizio del suo pontificato,[1] ha voluto regalarci una terza esortazione apostolica dedicata alla «chiamata alla santità nel mondo contemporaneo». Il titolo – Gaudete et exsultate – richiama l’invito alla gioia e alla felicità già presente nelle prime due esortazioni (Evangelii gaudium e Amoris laetitia).
Il documento, che si compone di cinque capitoli di facile lettura, non vuol essere un «trattato sulla santità, con tante definizioni e distinzioni che potrebbero arricchire questo importante tema» (n. 2). L’«umile obiettivo» di Francesco è quello di «far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità» (n. 2). Sua speranza è che le pagine della Gaudete et exsultate «siano utili perché tutta la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della santità» (n. 177).
Universale vocazione alla santità
Oggetto di riflessione dell’esortazione è il legame tra vita cristiana e universale chiamata alla santità (n. 10) contenuto al paragrafo n. 11 della Lumen gentium: «tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a quella perfezione di santità di cui è perfetto il Padre celeste».[2]
Quella di Gaudete et exsultate è la «santità della porta accanto», cioè di coloro «che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio» (n. 7); è la santità vivibile, sperimentabile e percepibile da ogni credente che non si accontenti «di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente» (n. 1).
La santità non è riservata a coloro che «hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova» (n. 14).
Conseguentemente, tutti dobbiamo lasciarci stimolare dai segni di santità presenti nei più umili membri di quel popolo che – come insegna Lumen gentium n. 12 – «partecipa pure dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità» (n. 8).
Peraltro «non tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo, non tutto quello che fa è autentico e perfetto. Ciò che bisogna contemplare è l’insieme della sua vita, il suo intero cammino di santificazione, quella figura che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che emerge quando si riesce a comporre il senso della totalità della sua persona» (n. 22).
Per dire che cosa sia la santità disponiamo di molte teorie e di abbondanti spiegazioni e distinzioni (n. 63). Sostanzialmente, però, la santità non è altro che la carità pienamente vissuta. La sua misura è data dalla statura che Cristo raggiunge in ogni persona battezzata, e da come ogni credente modella, con la forza dello Spirito Santo, tutta la sua vita sulla vita di Cristo (n. 21).
La santità, che non è l’imitazione di modelli astratti o ideali, è vivere in unione con Cristo i misteri della sua vita e implica «di riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù» come «la vita nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo donarsi per amore» (n. 20).
Nella prospettiva cristiana la santità mostra una straordinaria forza umanizzatrice e una robusta offerta di senso e di speranza. Essa non toglie né forze, né vita, né gioia. Al contrario, «ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la dignità» nostra e altrui (n. 32). «Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa più fecondo per il mondo» (n. 33). La santità non ci rende meno umani, perché essa è l’incontro della nostra debolezza con la forza della grazia (n. 34).
La santità è il volto più bello della Chiesa cattolica. Ma lo Spirito soffia anche fuori di essa: ad esempio, suscitando nell’esperienza umana universale segni della sua presenza in grado di aiutare gli stessi discepoli di Cristo a comprendere più profondamente il messaggio di cui sono portatori;[3] oppure alimentando in tutte le Chiese cristiane[4] un patrimonio comune costituito da testimonianze eroiche fino allo spargimento del sangue che parla con una voce più alta di tutti i fattori di divisione[5] (n. 9).
I nemici della santità
Ci sono due «falsificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare strada: lo gnosticismo e il pelagianesimo. Sono due eresie sorte nei primi secoli cristiani, ma che continuano ad avere un’allarmante attualità» (n. 35), nonostante la profonda differenza tra il contesto storico odierno secolarizzato e quello dei primi secoli cristiani.
Lo gnosticismo è una deriva ideologica e intellettualistica del cristianesimo, trasformato «in un’enciclopedia di astrazioni», per cui solo chi è capace di comprendere la profondità di una dottrina sarebbe da considerare un vero credente. «Grazie a Dio, lungo la storia della Chiesa è risultato molto chiaro che ciò che misura la perfezione delle persone è il loro grado di carità, non la quantità di dati e conoscenze che possono accumulare» (n. 37). L’esperienza cristiana non può essere trasformata «in un insieme di elucubrazioni mentali che finiscono per allontanarci dalla freschezza del Vangelo» (n. 46). «Una cosa è un sano e umile uso della ragione per riflettere sull’insegnamento teologico e morale del Vangelo; altra cosa è pretendere di ridurre l’insegnamento di Gesù a una logica fredda e dura che cerca di dominare tutto» (n. 39).
Per questo non è possibile considerare la nostra comprensione della dottrina come «un sistema chiuso, privo di dinamiche capaci di generare domande, dubbi, interrogativi», e «le domande del nostro popolo, le sue pene, le sue battaglie, i suoi sogni, le sue lotte, le sue preoccupazioni, possiedono un valore ermeneutico che non possiamo ignorare se vogliamo prendere sul serio il principio dell’incarnazione». Le sue domande ci aiutano a porci domande, i suoi interrogativi ci aiutano a porci interrogativi (n. 44).
L’altro grande nemico della santità è il pelagianesimo, cioè quell’atteggiamento che sottolinea in maniera esclusiva lo sforzo personale, come se la santità fosse frutto della volontà e non della grazia. Esso «si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente diversi tra loro: l’ossessione per la legge, il fascino di esibire conquiste sociali e politiche, l’ostentazione nella cura della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa, la vanagloria legata alla gestione di faccende pratiche, l’attrazione per le dinamiche di auto-aiuto e di realizzazione autoreferenziale» (n. 57).
Ne risulta un cristianesimo soffocante, sommerso da norme e precetti, privo della sua «affascinante semplicità» e del suo «sapore» (n. 58). Al riguardo, Tommaso d’Aquino[6] ci ricorda che «i precetti aggiunti al Vangelo da parte della Chiesa devono esigersi con moderazione per non rendere gravosa la vita ai fedeli». Così facendo, si rischia di trasformare la nostra religione in una schiavitù (n. 59). «La Chiesa ha insegnato numerose volte che non siamo giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore che prende l’iniziativa» (n. 52).
Santità è vivere le Beatitudini e la misericordia
Come si fa – si chiede Francesco – per arrivare ad essere un buon cristiano? «La risposta è semplice»: prendere a riferimento, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. «In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita» (n. 63), grazie alla potenza dello Spirito Santo che «ci libera dalla debolezza dell’egoismo, della pigrizia, dell’orgoglio» (n. 65).
Commentando le otto beatitudini nella versione del Vangelo di Matteo (5,3-12), Francesco esplicita nei termini che seguono il concetto di santità.
Santità è:
- essere poveri nel cuore per permettere al Signore di entrarvi con la sua costante novità e per condividere la vita dei più bisognosi (nn. 67-70);
- reagire con umile mitezza ai torti subiti, alle inimicizie, alle liti, alle critiche impietose, ai comportamenti arroganti e discriminatori (nn. 71-74);
- saper piangere con chi è nel pianto,[7] senza fuggire dalle situazioni dolorose, considerando carne della propria carne chi è nella sofferenza e nell’angoscia (nn. 75-76);
- aver fame e sete di giustizia, realizzandola nella propria vita, contribuendo ad assicurarla ai poveri, ai deboli e agli indifesi e rifiutandosi di salire sul carro del vincitore di turno (nn. 77-79);
- relazionarci e agire con tutti con misericordia mediante il dono e il perdono (nn. 80-82);
- mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore (nn. 83-86);
- seminare pace attorno a noi, prevenendo incomprensioni, componendo contrasti e facendo prevalere l’unità sui conflitti (nn. 87-89);
- accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi o sia per noi motivo di commiserazione o dileggio (nn. 90-94).
Inoltre, la santità gradita agli occhi di Dio è rinvenibile nel testo di Matteo 25,35-36 che Francesco definisce come «la grande regola di comportamento del giudizio finale» (n. 109): «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Alla luce di questa «pagina di cristologia» che, lungi dall’essere «un semplice invito alla carità», «proietta un fascio di luce sul mistero di Cristo» e ci invita a riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti, «essere santi non significa lustrarsi gli occhi in una presunta estasi» (n. 96), ma conformarsi al criterio della misericordia, «cuore pulsante del Vangelo», da accettare e da accogliere «sine glossa, vale a dire senza commenti, senza elucubrazioni e scuse» che finiscono col privarlo della sua forza dirompente (n. 97).
«Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, posso sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema che devono risolvere i politici, e forse anche un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre, un’immagine di Dio, un fratello redento da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può forse intendere la santità prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità di ogni essere umano?» (n. 98). A tal fine non bastano «alcune buone azioni», ma è necessario, anche attraverso l’impegno sociale (n. 101), cercare e realizzare cambiamenti sociali ed economici giusti che prevengano e contrastino ogni forma di esclusione (n. 99). Non è proponibile «un ideale di santità che ignori l’ingiustizia di questo mondo, dove alcuni festeggiano, spendono allegramente e riducono la propria vita alle novità del consumo, mentre altri guardano solo da fuori e intanto la loro vita passa e finisce miseramente» (n. 101).
In conclusione, «la forza della testimonianza dei santi sta nel vivere le Beatitudini e la regola di comportamento del giudizio finale. Sono poche parole, semplici, ma pratiche e valide per tutti, perché il cristianesimo è fatto soprattutto per essere praticato, e se è anche oggetto di riflessione, ciò ha valore solo quando ci aiuta a vivere il Vangelo nella vita quotidiana» (n. 109).
Le caratteristiche della santità
Papa Francesco è convinto che oggi la santità vada vissuta e testimoniata alla luce di cinque caratteristiche o espressioni spirituali «indispensabili per comprendere lo stile di vita a cui il Signore ci chiama» (n. 110).
In un mondo aggressivo e volubile come il nostro, la prima caratteristica della santità ha i tratti della sopportazione delle contrarietà e delle vicissitudini della vita. La santità è fatta di pazienza e di costanza nel bene (n. 112 e n. 121), vince il male con il bene (n. 113), impedisce il radicamento delle inclinazioni aggressive ed egocentriche (n. 114), non tollera la diffamazione e la calunnia, rispetta l’immagine e il buon nome altrui (n. 115). Oltre ad essere fatta di mitezza e di comprensione degli errori e dei difetti altrui, essa evita anche la violenza verbale che distrugge e maltratta (n. 116), non guarda il prossimo dall’alto al basso, non assume il ruolo di giudice spietato, non considera gli altri indegni e non pretende continuamente di dare lezioni (n. 117). La santità sopporta le umiliazioni e richiede il coraggio di reclamare giustizia per i deboli e di difenderli davanti ai potenti (n. 119).
La seconda caratteristica è la gioia e il senso dell’umorismo. La santità non ha nulla a che fare con «uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un basso profilo senza energia» (n.122). «Il malumore non è un segno di santità» (n. 126). Se il libro di Qoelet (11,10) ci ricorda che la malinconia va cacciata dal nostro cuore e la prima lettera a Timoteo (6,17) ci incoraggia a godere di tutto ciò che riceviamo dal Signore (n. 126), il libro del Siracide (14,11.19) ci invita a trattarci bene e a non privarci dei giorni felici (n. 127). «Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza» (n. 122). È capace di gioire del bene altrui (n. 128). Insomma, il Signore «ci vuole positivi, grati e non troppo complicati» (n. 127).
La terza caratteristica è la parresia, cioè l’audacia, l’entusiasmo e il fervore apostolico (n. 129). La santità mai si ferma su una «comoda riva» (n. 130) e mai pretende di camminare soltanto entro confini sicuri (n. 133). Non si lascia paralizzare dalla paura e dal calcolo (n. 133), né tantomeno dalla tentazione di fuggire in luoghi sicuri che possono avere molti nomi: «individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, dipendenza, sistemazione, ripetizione di schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme» (n. 134).
Il santo, uscendo dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante, spiazza e sorprende (n. 138). Egli sa che «Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto per andare oltre il conosciuto, verso le periferie e le frontiere. Ci conduce là dove si trova l’umanità più ferita e dove gli esseri umani, al di sotto dell’apparenza della superficialità e del conformismo, continuano a cercare la risposta alla domanda sul senso della vita. Dio non ha paura! Non ha paura! Va sempre al di là dei nostri schemi e non teme le periferie. Egli stesso si è fatto periferia (cf. Fil 2,6-8; Gv 1,14). Per questo, se oseremo andare nelle periferie, là lo troveremo: Lui sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore di quel fratello, nella sua carne ferita, nella sua vita oppressa, nella sua anima ottenebrata. Lui è già lì» (n. 135).
La quarta caratteristica è il cammino comunitario, perchè è molto difficile contrastare il male se si è isolati (n. 140). A volte la Chiesa «ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto eroicamente il Vangelo o che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri», preparandosi insieme persino al martirio, come nel caso dei beati monaci trappisti di Tibhirine in Algeria (n. 141).
Un altro istruttivo esempio di santificazione come cammino fatto «a due a due» è quello di «molte coppie di sposi sante, in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione dell’altro (n. 141).
La vita comunitaria è in grado di preservare dalla «tendenza all’individualismo consumista che finisce per isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri» (n.146).
La quinta caratteristica è la preghiera costante e la lettura orante della parola di Dio. «La santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare con Dio… Non credo nella santità senza preghiera» (n.147).
Il silenzio orante non va inteso come un’evasione che nega il mondo attorno a noi (n. 152). «La preghiera, proprio perché si nutre del dono di Dio che si riversa nella nostra vita, dovrebbe essere sempre ricca di memoria»: memoria delle opere compiute da Dio a favore del suo popolo, memoria della sua Parola rivelata, memoria della vita nostra e altrui, memoria di ciò che il Signore ha fatto nella sua Chiesa (n. 153).
«La preghiera è preziosa se alimenta una donazione quotidiana d’amore. Il nostro culto è gradito a Dio quando vi portiamo i propositi di vivere con generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che in esso riceviamo si manifesti nella dedizione ai fratelli» (n. 104).
Quanto alla parola di Dio, più dolce del miele (cf. Sal 119,103), spada a doppio taglio (Eb 4,12), lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino (cf. Sal 119,105), Francesco ci ricorda che «la devozione alla parola di Dio non è solo una delle tante devozioni, una cosa bella ma facoltativa. Appartiene al cuore e all’identità stessa della vita cristiana. La Parola ha in sé la forza per trasformare la vita» (n. 156).
Santità di lotta e discernimento
La vita cristiana è un combattimento permanente (n. 158). Si richiedono forza, coraggio, vigilanza per non lasciarsi andare allo stordimento, al torpore e alla tiepidezza (n. 164) o a tante sottili forme di autoreferenzialità (n. 165)
Nella battaglia spirituale che il cristiano è chiamato a condurre è di grande aiuto il dono del discernimento. Infatti, «senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento» (n. 167).
Il discernimento, non «richiede capacità speciali né è riservato ai più intelligenti e istruiti» (n. 170), «è necessario non solo in momenti straordinari, o quando bisogna risolvere problemi gravi, oppure quando si deve prendere una decisione cruciale. È uno strumento di lotta per seguire meglio il Signore. Ci serve sempre: per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non sprecare le ispirazioni del Signore, per non lasciar cadere il suo invito a crescere» (n. 169).
«Quando scrutiamo davanti a Dio le strade della vita, non ci sono spazi che restino esclusi. In tutti gli aspetti dell’esistenza possiamo continuare a crescere e offrire a Dio qualcosa di più, perfino in quelli nei quali sperimentiamo le difficoltà più forti. Ma occorre chiedere allo Spirito Santo che ci liberi e che scacci quella paura che ci porta a vietargli l’ingresso in alcuni aspetti della nostra vita. Colui che chiede tutto dà anche tutto, e non vuole entrare in noi per mutilare o indebolire, ma per dare pienezza. Questo ci fa vedere che il discernimento non è un’autoanalisi presuntuosa, un’introspezione egoista, ma una vera uscita da noi stessi verso il mistero di Dio, che ci aiuta a vivere la missione alla quale ci ha chiamato per il bene dei fratelli» (n. 175).
Santità è vivere in pienezza la vita cristiana
In conclusione, un’efficace sintesi del contenuto dell’esortazione apostolica Gaudete et exsultatemi sembra rinvenibile nelle parole pronunciate da Francesco in occasione della recita del Regina coeli del 29 aprile 2018.
«Quando si è intimi con il Signore, come sono intimi e uniti tra loro la vite e i tralci, si è capaci di portare frutti di vita nuova, di misericordia, di giustizia e di pace, derivanti dalla risurrezione del Signore. È quanto hanno fatto i santi, coloro che hanno vissuto in pienezza la vita cristiana e la testimonianza della carità, perché sono stati veri tralci della vite del Signore. Ma per essere santi «non è necessario essere vescovi, sacerdoti o religiosi… Tutti noi, tutti, siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova».[8] Tutti noi siamo chiamati ad essere santi; dobbiamo essere santi con questa ricchezza che noi riceviamo dal Signore risorto. Ogni attività – il lavoro e il riposo, la vita familiare e sociale, l’esercizio delle responsabilità politiche, culturali ed economiche – ogni attività, sia piccola sia grande, se vissuta in unione con Gesù e con atteggiamento di amore e di servizio, è occasione per vivere in pienezza il battesimo e la santità evangelica».
[1] L’esortazione apostolica è stata presentata il 9 aprile, ma firmata il 19 marzo, solennità di san Giuseppe, dell’anno 2018, sesto del servizio petrino di Francesco.
[2] Nel Commentario alla Lumen gentium, curato da Serena Noceti e Roberto Repole, EDB, Bologna 2015, Dario Vitali scrive: «Il legame tra vita cristiana e universale vocazione alla santità non sembra aver lasciato traccia nella coscienza del popolo di Dio, ma nemmeno nella riflessione teologica che, su questo punto, registra un silenzio assordante» (pag. 175). È possibile che sia anche a motivo di questo silenzio che papa Francesco ha deciso di offrire alla Chiesa un documento magisteriale interamente dedicato alla «santità nel popolo di Dio paziente» (n. 7)? Un’ennesima e chiara dimostrazione della volontà di Francesco di “ritornare” al concilio vaticano II?
[3] Cf. Novo millenio ineunte n. 56 di Giovanni Paolo II.
[4] Cf. Tertio millenio adveniente n. 37 di Giovanni Paolo II.
[5] Cf. Omelia di Giovanni Paolo II del 7 maggio 2000 in occasione della Commemorazione ecumenica dei testimoni della fede del secolo XX.
[6] Cf Summa Theologiae, I-II, q. 107, art. 4.
[7] Francesco era vescovo di Roma da appena venti giorni, quando parlò della «grazia delle lacrime» come di «una bella grazia» perché, a volte, «nella nostra vita gli occhiali per vedere Gesù» sono proprio le lacrime (meditazione del 2 aprile 2013). In occasione della visita all’isola di Lampedusa dopo l’ennesima tragedia dei migranti inghiottiti dal mare, memorabile resta la domanda di Francesco, ripetuta cinque volte, chi di noi ha pianto ? «Domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che nell’anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi come questo» (omelia dell’8 luglio 2013). Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudiumviene stigmatizzata la cultura del benessere e la globalizzazione dell’indifferenza che ci rendono «incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri», così che «non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete» (EG n. 54). «Piangere per l’ingiustizia, piangere per il degrado, piangere per l’oppressione. Sono le lacrime che possono aprire la strada alla trasformazione; sono le lacrime che possono ammorbidire il cuore, sono le lacrime che possono purificare lo sguardo e aiutare a vedere la spirale di peccato in cui molte volte si sta immersi. Sono le lacrime che riescono a sensibilizzare lo sguardo e l’atteggiamento indurito e specialmente addormentato davanti alla sofferenza degli altri. Sono le lacrime che possono generare una rottura capace di aprirci alla conversione» (omelia del 17 febbraio 2016). Ai giovani radunati nel campo sportivo di Manila rivolse questo invito: «Siate coraggiosi: non abbiate paura di piangere» (discorso del 18 gennaio 2015).
[8] Gaudete et exsultate, n. 14.
settimananews