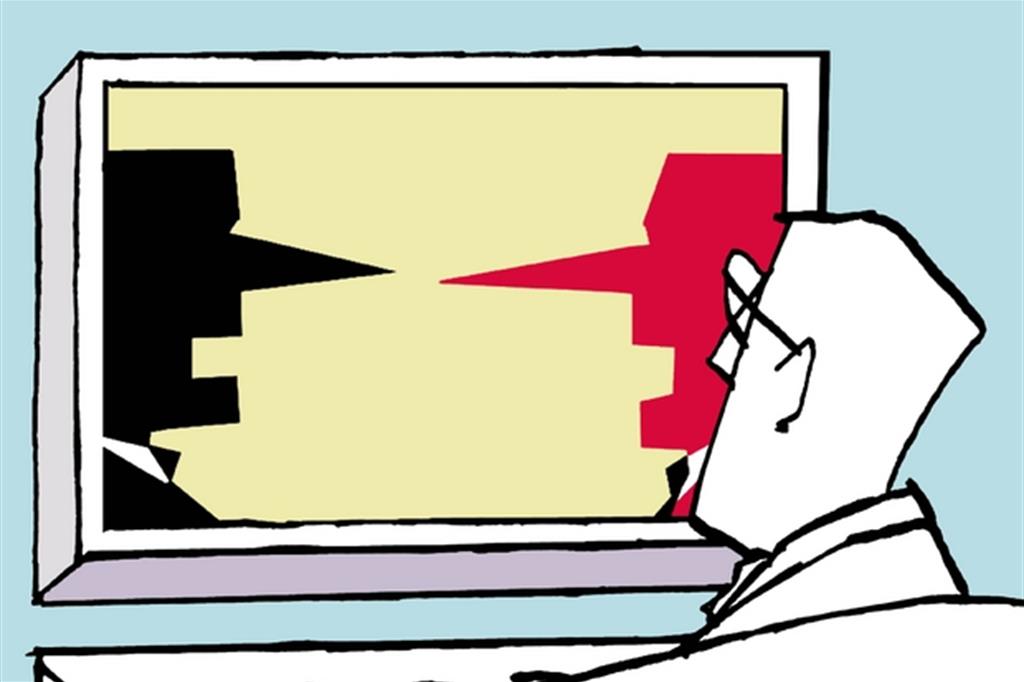“Il Vangelo ricorda che chi è chiamato a dare testimonianza della Risurrezione di Cristo deve lui stesso, in prima persona, nascere dall’alto”. Lo ha detto il Papa durante la Messa concelebrata in San Pietro, all’Altare della Cattedra, con i missionari della misericordia.”Questo significa lasciare veramente il primato al Padre, a Gesù e allo Spirito Santo nella nostra vita – ha spiegato Francesco -. Attenzione: non si tratta di diventare preti invasati, quasi che si fosse depositari di un qualche carisma straordinario. No. Preti normali, semplici, miti, equilibrati, ma capaci di lasciarsi costantemente rigenerare dallo Spirito, docili alla sua forza, interiormente liberi – anzitutto da sé stessi – perché mossi dal vento dello Spirito che soffia dove vuole”.
“Sia la Chiesa sia il mondo di oggi hanno particolarmente bisogno della Misericordia perché l’unità voluta da Dio in Cristo prevalga sull’azione negativa del maligno che approfitta di tanti mezzi attuali, in sé buoni, ma che, usati male, invece di unire dividono”. “Noi siamo convinti che l’unità è superiore al conflitto – ha aggiunto -, ma sappiamo anche che senza la Misericordia questo principio non ha la forza di attuarsi nel concreto della vita e della storia”.
I missionari della Misericordia a Roma avevano già incontrato il Papa nella Domenica della Divina Misericordia: oggi prima di concelebrare la Messa nella Basilica di San Pietro con il Papa erano stati ricevuti di nuovo nella Sala Regia del Palazzo Apostolico. In questa occasione papa Francesco ha rivolto loro un discorso (TESTO INTEGRALE) al termine del quale ha raccontato nuovamente (lo aveva fatto all’inizio del Pontificato) di quando rubò la croce a un confessore morto.
“E vorrei finire con due aneddoti – ha raccontato Francesco – di due grandi confessori, ambedue a Buenos Aires. Uno, un sacramentino, che aveva avuto lavori importanti nella sua congregazione, è stato provinciale, ma sempre trovava tempo per andare al confessionale. Io non so quanti, ma la maggioranza del clero di Buenos Aires andava a confessarsi da lui. Anche quando san Giovanni Paolo II era a Buenos Aires e ha chiesto un confessore, dalla Nunziatura hanno chiamato lui. Era un uomo che ti dava il coraggio di andare avanti. Io ne ho fatto esperienza perché mi sono confessato da lui nel tempo in cui ero provinciale, per non farlo con il mio direttore gesuita… Quando cominciava “bene, bene, sta bene”, e ti incoraggiava: “Va’, va’!”. Com’era buono. E’ morto a 94 anni e ha confessato fino a un anno prima, e quando non c’era in confessionale si suonava e lui scendeva. E un giorno, io ero vicario generale e sono uscito dalla mia stanza, dove c’era il fax – lo facevo tutte le mattine presto per vedere le notizie urgenti –, era la domenica di Pasqua e c’era un fax: “Ieri, mezzora prima della veglia pasquale, è venuto a mancare il padre Aristi”, così si chiamava… Sono andato a pranzo alla casa di riposo dei sacerdoti a fare la Pasqua con loro e al rientro sono andato alla chiesa che era al centro della città, dove c’era la veglia funebre. C’era la bara e due vecchiette che pregavano il rosario. Mi sono avvicinato, e non c’era nessun fiore, niente. Pensavo: ma questo è il confessore di tutti noi! Questo mi ha colpito. Ho sentito quanto brutta è la morte. Sono uscito e sono andato a 200 metri, dove c’era un posto di fiori, quelli che ci sono nelle strade, ho comprato alcuni fiori e sono tornato. E, mentre mettevo i fiori lì presso la bara, ho visto che nelle mani aveva il rosario… Il settimo comandamento dice: “Non rubare”. Il rosario è rimasto là, ma mentre facevo finta di sistemare i fiori ho fatto così e ho preso la croce. E le vecchiette guardavano, quelle vecchiette. Quella croce la porto qui con me da quel momento e chiedo a lui la grazia di essere misericordioso, la porto con me sempre. Questo sarà stato nell’anno ’96, più o meno. Gli chiedo questa grazia. Le testimonianza di questi uomini sono grandi”.
“Poi l’altro caso – ha sottolineato papa Francesco -. Questo è vivo, 92 anni. E’ un cappuccino che ha la coda dei penitenti, di tutti i colori, poveri, ricchi, laici, preti, qualche vescovo, suore… tutti, non finisce mai. E’ un gran perdonatore, ma non un “manica larga”, un gran perdonatore, un gran misericordioso. E io sapevo questo, lo conoscevo, due volte sono andato al santuario di Pompei dove lui confessava a Buenos Aires, e l’ho salutato. Adesso ha 92 anni. In quel tempo ne avrà avuti, quando è venuto da me, 85. E mi ha detto: “Voglio parlare con te perché ho un problema. Ho un grande scrupolo: a volte mi viene da perdonare troppo”. E mi spiegava: “Io non posso perdonare una persona che viene a chiedere il perdono e dice che vorrebbe cambiare, che farà di tutto, ma non sa se ce la farà… Eppure io perdono! E a volte mi viene un’angoscia, uno scrupolo…”. E gli ho detto: “Cosa fai quando ti viene questo scrupolo?”. E lui mi ha risposto così: “Vado in cappella, nella cappella interna del convento, davanti al tabernacolo, e sinceramente chiedo scusa al Signore: “Signore, perdonami, oggi ho perdonato troppo. Perdonami… Ma bada bene che sei stato tu a darmi il cattivo esempio!”. Così pregava quell’uomo”.
A due anni dalla istituzione del loro ministero durante il Giubileo, i missionari della misericordia si sono ritrovati in Vaticano, dall’8 all’11 aprile per un secondo grande incontro, organizzato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Oltre 550 missionari provenienti dai cinque continenti a Romahanno vissuto momenti di catechesi e preghiera. Oltre a testimonianze sulle attività pastorali svolte nelle varie diocesi, hanno celebrato il sacramento della Riconciliazione, cuore di questo speciale ministero istituito dal Papa. I sacerdoti hanno ricevuto l’Annuario che raccoglie i contatti di tutti gli 897 missionari della misericordia attivi in questo momento.
Nel video le testimonianze dei Missionari della Misericordia
Papa Francesco il 1° maggio al Santuario romano del Divino Amore
Papa Francesco si recherà in visita al Santuario romano del Divino Amore a Roma il primo maggio. “I pellegrini abituali sono molto ansiosi e gioiosi per questa visita”, ha spiegato il Rettore del Santuario, don Luciano Chagas Costa. Il Pontefice dovrebbe arrivare al Santuario intorno alle 17 per la recita del rosario ma “è ancora presto”,dice il Rettore, per il programma dettagliato che non è stato ancora definito.
È la prima volta che Francesco si reca al santuario mariano di Roma. L’ultima visita di un Pontefice è stata quella di Benedetto XVI nel 2006, sempre il primo maggio che, come spiega don Chagas Costa, è la data con cui tradizionalmente la Chiesa apre “il mese mariano”.