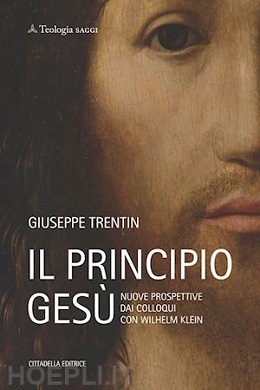Adulterio: “Requiem” per un peccato?
di: Basilio Petrà Settimana News

Domanda strana, quella posta nel titolo. Tuttavia, può aprire alla riflessione un sentiero forse interessante. Proviamo a percorrerne il sentiero.
Si può cominciare osservando che se, dicendo peccato, pensiamo all’atto peccaminoso in quanto posto da un soggetto, certamente si può – anzi si deve – cantare il “Requiem” per esso: attraverso il pentimento e il perdono il peccato infatti in qualche modo muore, si estingue.
Se, invece, dicendo peccato, pensiamo ad un atto peccaminoso in quanto tale, ad es. un furto, una menzogna, un adulterio determinati ecc. allora forse la cosa non sta così. Può davvero un determinato adulterio non essere più un peccato di adulterio?
Realtà giuridica e realtà esistenziale
La prima e immediata risposta che viene alle labbra è chiara: un adulterio rimane sempre un peccato di adulterio.[1]
Tuttavia, supponiamo che si potesse dimostrare che un elemento costitutivo di ogni atto di adulterio (ad es. il fatto che almeno uno della coppia è infedele al suo proprio vincolo matrimoniale) non si dia più formalmente in un atto determinato, allora non sarebbe irragionevole cambiare anche la sua comprensione ovvero si potrebbe ben dire che esso non è più un adulterio.
Ad es. se Antonio ha un rapporto sessuale con Genoveffa che è giuridicamente sposata con Giuseppe ma da anni non vive più con Giuseppe, ha costruito anzi un rapporto di piena condivisione vitale (convivenza stabile di forma coniugale e magari civilmente riconosciuta) con Antonio, allora qualcuno potrebbe sostenere con buone ragioni che non si può più dire che il rapporto tra Antonio e Genoveffa costituisca adulterio. In effetti, Giuseppe e Genoveffa risultano sposati giuridicamente (canonicamente) ma senza che tale indicazione corrisponda alla realtà del vissuto delle persone, giacché o ambedue o almeno uno dei due non solo considerano terminato il proprio legame nuziale (quello canonicamente definito) ma hanno costituito un nuovo legame nuziale, talvolta giuridicamente (civilmente) riconosciuto.
È ragionevole affermare infatti che non si può dare adulterio ovvero violazione di un vincolo nel caso che i soggetti non ritengano più vigente per loro tale vincolo, essendosi esaurito sul piano della relazione reale il loro vincolo nuziale.
Ricordo l’imbarazzo di alcuni moralisti quando furono posti dinanzi a una domanda di questo tipo: «Alberto, sposatosi con Maria nel 1978, si separa e divorzia da lei nel 1985 e si risposa civilmente con Antonietta. Nel 1988 nel corso di una settimana di studi incontra di nuovo Maria e passano la notte insieme. Commette adulterio o no?».
Nella logica che assolutizza la determinazione canonica non lo commettono: ma nella logica della concreta realtà esistenziale commettono adulterio. Agli occhi di molti lo commettono perché la realtà concreta prevale nella valutazione sulla realtà astrattamente considerata, e non sembra uno sguardo ingiusto.
Bisogna dire – e dirlo chiaramente – che la pastorale si è ampiamente accorta di questa necessaria distinzione da fare tra realtà giuridica e realtà esistenziale.
La Chiesa infatti nella sua pastoralità ad un certo punto[2] ha preso atto che per una situazione quale quella di Antonio e Genoveffa non poteva più usare il termine adulterio, perché così facendo non avrebbe guardato alla realtà esistenziale in atto della vita delle persone ma ad una forma della loro vita ormai consegnata al passato e non più corrispondente alla realtà presente.
La pastorale sa bene infatti che ogni forma di coniugio è prima di tutto un reale evento esistenziale, certamente assunto e potenziato nella forma giuridico/sacramentale ma non creato esistenzialmente da quest’ultima.
Per questo tra l’altro permane sempre un dualismo strutturale tra realtà esistenziale e realtà canonica anche all’interno del coniugio. Il permanere strutturale di questo dualismo legittima tra l’altro la celebre affermazione di Giovanni Paolo II (Udienza generale, 1 ottobre 1980) che può darsi adulterio del cuore (dunque un vero peccato di adulterio) anche tra legittimi sposi: «L’adulterio “nel cuore” viene commesso non soltanto perché l’uomo “guarda” in tal modo la donna che non è sua moglie, ma appunto perché guarda così una donna. Anche se guardasse in questo modo la donna che è sua moglie, commetterebbe lo stesso adulterio “nel cuore”».[3]
Alla luce di quanto abbiamo appena detto per l’adulterio, si può senza arbitrio affermare che, nel caso cambiasse radicalmente la valutazione di un elemento definitorio di un qualsiasi peccato, si potrebbe suonare il “Requiem” per quel peccato nel caso il cambiamento venisse acquisito/riconosciuto come reale e ovviamente nella misura di tale riconoscimento.
Ebbene, forse un cambiamento valutativo di questo tipo si sta delineando anche in rapporto al peccato di fornicazione (latino: fornicatio; greco: porneia). Vediamo.
E per quanto riguarda la fornicazione?
Si può cantare il “Requiem” per la “fornicazione” così come sulle orme dell’apostolo Paolo essa è descritta dai manuali di teologia morale e dal Catechismo della Chiesa cattolica?
Il CCC. 2353 così descrive il contenuto del termine fornicatio: «unio est carnalis extra matrimonium inter virum et mulierem liberos. Ea est personarum dignitati graviter contraria atque sexualitati humanae ad bonum coniugum et ad filiorum generationem et educationem naturaliter ordinatae. Est praeterea grave scandalum, cum iuvenum habetur corruptio».[4]
Si noti bene la struttura teorica di questo numero del Catechismo. L’illiceità intrinseca della fornicazione è determinata dal fatto che l’unione sessuale è posta tra persone che non sono legittimamente sposate, pur potendo esse sposarsi liberamente (a questo si allude dicendo “libero”).
Tale illiceità intrinseca è determinata dal fatto che l’unione sessuale è giustamente e degnamente posta quando è rispettata una precisa condizione: l’ordinamento della sessualità al bene dei coniugi e alla generazione/educazione dei figli, ovvero quando l’atto avviene tra coniugi legittimi aperti alla vita.
Questo numero è solo l’ultima formulazione storica della regola pratica pastoralmente decisa dall’apostolo Paolo nel caso della comunità cristiana di Corinto (si veda 1Cor 7). Paolo infatti riconosce moralmente ordinata l’unione sessuale solo se è posta all’interno del legittimo matrimonio (gamos – come lo chiama Paolo – ovvero il matrimonio che la comunità può ritenere legittimo),[5] altrimenti è una porneia (fornicazione).
Per secoli, da tale regola è stata generata la struttura normativa fondamentale dell’etica sessuale cattolica ovvero l’affermazione che ogni unione sessuale tra due persone libere posta al di fuori della condizione del gamos è fornicazione o porneia.
Tuttavia, proprio questa indicazione paolina sul modo ordinato di vivere la sessualità ha subìto una maturazione di grande rilievo negli ultimi secoli della storia della Chiesa, tanto a livello canonico quanto a livello teologico-pastorale. Per meglio presentare tale maturazione, cito qui almeno una pagina del mio libro succitato:
«I punti sui quali ci siamo fermati indicano che, dalla fine del secolo XIX, nell’autocoscienza della Chiesa è cresciuta sempre più la consapevolezza che anche la comunicazione sessuale intramatrimoniale deve essere moralmente esercitata ovvero esercitata in coerenza con il movimento della forma coniugale dell’amore. In questa luce, l’ingresso nello spazio del gamos non sembra costituire più l’ingresso semplice nell’area della liceità morale giacché tale liceità ha un suo valore intrinseco capace di sospendere il diritto (la vicenda dello ius in corpus è esemplare). La liceità giuridica potrebbe nascondere una comunicazione sessuale ed affettiva falsa e menzognera, cioè moralmente illegittima, oppure semplicemente non corrispondente all’amoris coniugalis modus.
È dunque cresciuta la consapevolezza ecclesiale che la legittimità morale della comunicazione sessuale è data dalla contestualità valoriale del rapporto tra le persone e non semplicemente/necessariamente dalla forma giuridica, anche se può essere sostenuto con verità che la forma giuridica nasce spontaneamente dal contesto valoriale coniugale e ne determina una peculiare, concreta e rilevante configurazione storico/sociale.
Per riprendere l’inizio, potremmo dire che la distinzione paolina (porneia/gamos) nel contesto di consapevolezza antropologica e morale contemporanea appare inadeguata per descrivere i confini della legittimità morale nell’esercizio della sessualità.
Il confine non segue la frontiera che separa l’area matrimoniale e l’area extramatrimoniale giacché da più segni emerge ora la consapevolezza che l’esercizio intramatrimoniale della sessualità non garantisce la qualità morale di tale esercizio se esso non è una forma del verus coniugalis amor né l’esercizio extramatrimoniale della sessualità è costituito a priori come esercizio moralmente illegittimo della sessualità.
Ciò può essere detto in tale modo: ogni qualvolta la comunicazione sessuale è forma veramente espressiva della reciproca e intenzionale donazione d’amore di tipo coniugale (responsabile condivisione dell’esistenza secondo la delineazione dell’amore coniugale qualitativamente descritto da Gaudium et spes e Humanae vitae) potrebbe essere considerata moralmente legittima, purché non ferisca attuali responsabilità di giustizia e di verità nei confronti di terze persone; certo, tale legittimità diventerebbe ancor più piena e significativa – anche moralmente – quando tale amore assumesse forma istituzionale (sacramentale) nel matrimonio».[6]
Due dialoghi emblematici
Detto in altro modo, nel secolo XX è emerso sempre più chiaramente il fatto che la legittimità morale dell’unione sessuale non è semplicemente subordinata a quella giuridica ma ha una sua propria, originaria e preistituzionale consistenza di verità, quando l’unione sessuale esprime e articola nel linguaggio del corpo la coesistenza reale dei due amanti ovvero il patto de facto che li unisce nell’esistenza.
Ciò non potrebbe dirsi naturalmente nel caso dell’incontro episodico od occasionale, determinato da bisogni fisici o edonistici o psicologici o altro, un incontro al quale non corrispondesse la comunione esistenziale sopra descritta… Né in linea di principio si potrebbe dire questo della relazione strutturalmente clandestina che non lasciasse trasparire nella concreta esistenza dei due la programmatica unità vitale e intenzionale dei due.
La consapevolezza di questa legittimità morale preistituzionale (precedente alla configurazione giuridica istituzionale) appare concretamente molto diffusa nella sensibilità morale odierna, non solo tra i non cristiani ma anche tra i cristiani, non solo tra molti non cattolici ma anche tra molti cattolici.
È comunemente percepita, infatti, la distinzione qualitativa tra relazioni forti (di unità esistenziale) e relazioni deboli e in connessione con tale percezione appare diversamente compreso anche il valore morale dell’unione sessuale.
Per dare una qualche prova di questo, annoto soltanto due passaggi tratti da due libri da poco pubblicati e largamente conosciuti, data la notorietà degli autori. Sono due passi che mi sembrano particolarmente significativi dal punto di vista delle nostre considerazioni.
Il primo lo traggo da un recente libro di Gianrico Carofiglio.[7] Si tratta di un colloquio tra la protagonista del volume, Penelope Spada, e Alessandro, un uomo conosciuto nei giardini dove Penelope si allenava:
– Dove abiti ? – chiesi.
– Qui vicino. Un appartamento davvero piccolo. Mi ci sono trasferito dopo la separazione. Non ti ho chiesto se sei sposata, convivente, fidanzata.
– Non sposata, non convivente, non fidanzata, – risposi, provando uno stupido senso di contentezza per l’informazione che avevo appena avuto in quel modo casuale. Mi sentii audace.
– Da quanto sei separato?
– Quasi tre anni, ormai. Non sono pochi, ma a me sembra un tempo ancora più lungo. Forse perché sono successe varie cose non belle, a parte la separazione.[….]
– Dunque eri sposato?
– In realtà no. Abbiamo convissuto per cinque anni, l’idea era di sposarci quando avessimo deciso di fare un figlio. Tu da quanto non hai un fidanzato?
– Da molto tempo, se parliamo di un fidanzato vero.
La domanda di Alessandro è interessante: indica tre possibilità diverse, tutte però caratterizzate da un legame forte ovvero indicative di un impegno relazionale che configura un legame esistenziale intenzionale. Il contesto infatti non è quello della semplice proposta sessuale o della relazione occasionale sessualmente centrata: è chiaramente segnato dall’interesse per un legame forte, anche se di intensità diversa.
Un’analoga distinzione tra legame forte e legame debole, con riferimento particolare al fidanzamento, la troviamo in un altro testo letterario. Mi riferisco ad un volume scritto da Donato Carrisi[8] nel quale troviamo un breve dialogo tra il protagonista Pietro Gerber e la sua ex moglie Silvia, un dialogo che suona così:
«E poi, se permetti, mi sono rifatta una vita». Silvia si riprese con prepotenza la sua attenzione.
La precisazione stavolta lo infastidì, era del tutto gratuita. «Non ho mai detto nulla sul conto del tuo nuovo compagno» ribatté.
«Non è un semplice compagno» puntualizzò lei, stizzita. «È il mio fidanzato».
Poi sparì di nuovo e Gerber pregò che cadesse presto la linea per poter spegnere il cellulare».[9]
L’autenticità etica della relazione
Il passaggio dal vissuto della sessualità «giuridicamente ordinato» a quello «eticamente ordinato».
Prendendo atto del passaggio surricordato ovvero del fatto «che la legittimità morale dell’unione sessuale non è semplicemente subordinata a quella giuridica ma ha una sua propria, originaria e preistituzionale consistenza di verità, che si dà quando l’unione sessuale esprime e articola nel linguaggio del corpo la coesistenza reale dei due amanti ovvero il patto de facto che li unisce nell’esistenza», diventa possibile affermare che la regola pastorale (il gamein) posta da Paolo per dare ordine alla vita sessuale dei fedeli che bruciano e non sono chiamati a vivere nella forma escatologica può essere adeguatamente sostituita da una regola pastorale che richieda l’autenticità etica della relazione di coppia sul piano esistenziale e preistituzionale (anche se non anti/istituzionale) ovvero la condivisione dell’esistenza aperta al futuro (alla vita) intenzionalmente ed esplicitamente assunta dalla coppia, una sorta di patto esistenziale de facto.[10]
Ciò significherebbe affermare la liceità morale dell’unione sessuale indipendentemente dalla celebrazione del matrimonio, anche se l’unione sessuale vissuta nel matrimonio potrebbe certamente realizzare una pienezza maggiore di senso e un maggior compimento esistenziale.[11] Il presupposto infatti di questa indicazione pastorale è che l’unione sessuale è l’espressione nel linguaggio del corpo della totale donazione reciproca d’amore dei due nella storia. Per i cristiani il luogo più pienamente espressivo di tale donazione d’amore è certamente l’inveramento sacramentale di essa, ma tanto per i cristiani quanto per i non cristiani la verità esistenziale di essa può darsi anche prima (o indipendentemente) della celebrazione “gamica”.
Alcune conseguenze di tale passaggio
A – Questo cambiamento nella regola pastorale, sottraendo la legittimità morale dell’unione sessuale all’egemonia giuridico/sacramentale, offrirebbe anche la possibilità di sottrarsi ad un’affermazione (spesso dimenticata, peraltro) che riguarda la grande maggioranza dei coniugi cristiani e che determina conseguenze piuttosto discutibili.
Nell’attuale situazione dottrinale, infatti, l’unione sessuale dei cristiani è legittima non solo quando è giuridicamente collocata ma anche quando è sacramentalmente collocata, dal momento che patto matrimoniale tra battezzati e sacramentalità coincidono e dal momento inoltre che, negli ultimi decenni, sempre più la sacramentalità è stata concepita non solo in rapporto al matrimonio in fieri (momento del consenso) ma anche in rapporto al matrimonio in fatto esse (la vita coniugale). Ciò significa, ad esempio, che un rapporto sessuale tra persone non in stato di grazia (per usare questo linguaggio) sarebbe moralmente riprovevole.
Si veda quanto scriveva il 12 febbraio del 1997 il Pontificio consiglio per la famiglia nel Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti alla vita coniugale al punto 1.5 della parte dedicata al Vademecum per i confessori: «Gli sposi attuano la piena donazione di sé nella vita matrimoniale e nella unione coniugale, che, per i cristiani, è vivificata dalla grazia del sacramento. La loro specifica unione e la trasmissione della vita sono impegni propri della loro santità matrimoniale».
Ricollocando adeguatamente il rapporto tra legittimità morale dell’esercizio della sessualità, spazio giuridico e configurazione sacramentale, la conseguenza surricordata non potrebbe darsi perché l’esercizio della sessualità non sarebbe reso lecito dall’unità giuridico-sacramentale del matrimonio ma dall’originaria significatività dell’unione sessuale stessa in rapporto alla comunione esistenziale della coppia.
B – La regola pastorale eticamente ordinata chiederebbe ai cristiani di porsi senza finzioni dinanzi al proprio vissuto e misurarsi veracemente su di esso, senza alibi di alcun tipo. Chiederebbe l’onestà del cuore e della mente.
Là dove la regola pastorale fosse solo quella determinata dalla presenza giuridica dell’istituzione, ogni relazione pre o extra istituzionale avrebbe la stessa sostanziale negatività, senza nessuna richiesta ulteriore di onestà. Ogni rapporto sarebbe moralmente equivalente nella sua legale negatività, allargando il fossato tra il reale vissuto delle persone (che distingue le modalità di comunicazione sessuale) e l’indicazione morale (qui piuttosto etico-legale) della Chiesa.
[1] Si ricordi la definizione di adulterio offerta dal CCC, 2380: «Hoc verbum infidelitatem designat coniugalem. Cum duo, quorum saltem alter est matrimonio coniunctus, relationem sexualem, etiam fugacem,nectunt inter se, adulterium committunt» (= Questa parola designa l’infedeltà coniugale. Quando due persone, di cui almeno una è sposata, intrecciano tra loro una relazione sessuale, anche episodica, commettono un adulterio).
[2] Si veda quel che scrivo nel mio: Una futura morale sessuale cattolica. In/fedeltà all’apostolo Paolo, Cittadella Editrice, Assisi 2021, 27-32.
[3] Giovanni Paolo II, Udienza generale 8 ottobre 1980.
[4] «La fornicazione è l’unione carnale tra un uomo e una donna liberi, al di fuori del matrimonio. Essa è gravemente contraria alla dignità delle persone e della sessualità umana naturalmente ordinata sia al bene degli sposi, sia alla generazione e all’educazione dei figli. Inoltre è un grave scandalo quando vi sia corruzione dei giovani».
[5] Ibidem, pp. 9-32. Queste pagine costituiscono la Parte prima del libro.
[6] Ibidem, pp. 30-32.
[7] Giacomo Carofiglio, Rancore, Giulio Einaudi editore, Torino 2022, 191-192.
[8] Donato Carrisi, La casa senza ricordi, Longanesi, Milano 2021.
[9] Ibidem, 91-92.
[10] Paolo è condotto nella sua indicazione dal principio di realtà che lo guida; la proposta qui avanzata è guidata dallo stesso principio di realtà nella condizione attuale di esistenza. Su tutto ciò si veda Ibidem, 33ss, 83-90.
[11] Si ricordi che questo compimento è in ogni caso una possibilità non un prodotto automatico della celebrazione giuridica e/o giuridico/sacramentale.

 Egli non deve «disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma e una destinazione anteriore datale da Dio, che l’uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire». Quando si comporta in questo modo, «invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui».
Egli non deve «disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma e una destinazione anteriore datale da Dio, che l’uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire». Quando si comporta in questo modo, «invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui».