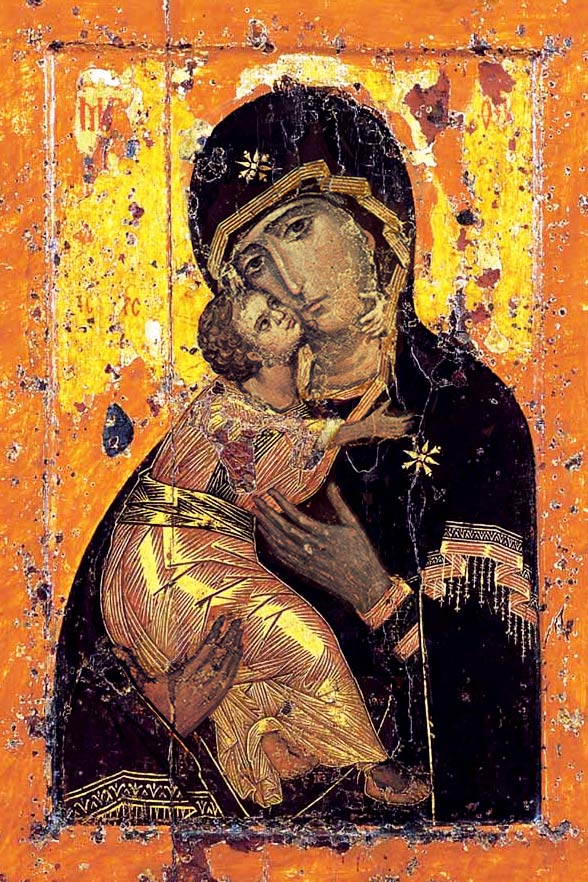Il filosofo e teologo ceco Tomáš Halík propone questo testo all’inizio del cammino quaresimale, invitando a non fermarsi alle forme del culto ma vivendo il messaggio di morte e di vita contenuto nel mistero pasquale. Se non esiste un Messia senza croce, neppure esiste una Chiesa o un cristiano senza croce. Dire “no” a tutte le forme del Male.
L’omelia dovrebbe essere un ponte tra il mondo del testo biblico e il mondo degli ascoltatori. Questo non è un compito facile oggi, perché in questi tempi difficili e drammatici il mondo di cui facciamo parte sta cambiando letteralmente ogni giorno. Non oso prevedere cosa accadrà nei prossimi giorni tra il momento in cui preparo la mia omelia e la domenica in cui è previsto che se ne parli in chiesa.
Poco tempo fa, pochi avrebbero potuto immaginare che l’Europa sarebbe stata di nuovo in guerra, che la Russia di Putin si sarebbe esclusa dalla famiglia dei paesi civilizzati, avrebbe commesso crimini di guerra, distrutto da un giorno all’altro il pacifico ordine mondiale costruito nel corso di decenni, calpestato il diritto internazionale, attaccato il suo vicino più debole in modo insidioso e spregevole, cercato di cancellare dalla carta geografica uno stato democratico, un grande paese vicino a noi culturalmente, e ucciso brutalmente anche donne e bambini. Il sangue dell’Ucraina grida al Signore degli eserciti.
Non appena l’onda del contagio pandemico si è placata, la Russia di Putin ha scatenato una pandemia ancora più terrificante di ingiustizia, paura e violenza, per la quale è difficile trovare un rimedio sufficientemente efficace.
Le ceneri, iniziazione alla maturità
Nelle chiese abbiamo iniziato il periodo di penitenza pre-pasquale con il rito delle ceneri, accompagnato dalle parole: “Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai”. Questa cerimonia e queste parole ci mettono di fronte alla nostra transitorietà, alla nostra morte. È quindi affine agli antichi riti di iniziazione, in cui il confronto con la morte significava l’iniziazione all’età adulta – questo era forse, dopo tutto, il significato del rito del sacrificio di Isacco.
In questo momento storico ci troviamo di fronte alla morte che è destinata a condurci all’età adulta, alla maturità, alla responsabilità.
Iniziamo la Quaresima con la consapevolezza della morte e della transitorietà. Alla fine della Quaresima, celebreremo la grande notte del trionfo sulla morte e sulla paura della morte, quando possiamo chiedere: “Morte, dov’è la tua vittoria?”. La sacra Scrittura ci dice: “Per la paura della morte eravate tenuti in schiavitù”. Ma siamo chiamati alla libertà, anche alla libertà dalla paura. Il compito della Quaresima è una trasformazione interiore, un’opportunità di liberazione, di ri-creazione.
Il racconto figurato della creazione dell’uomo nella Bibbia ci dice che l’uomo è un grande paradosso: è tratto dal nulla, dalla polvere della terra – ed è animato dallo spirito di Dio.
La polvere e la cenere sono un simbolo del nulla: è una sostanza che non ha forma, è subito spazzata dal vento, non serve più a nulla. Solo Dio può creare dal nulla. Solo lui può dare a qualcosa di così insignificante una forma, un volto e un significato: il suo Spirito. Così, per la potenza dello Spirito di Dio, l’uomo, vulnerabile e transitorio, diventa l’immagine e l’espressione della libertà e della creatività di Dio.
Quando l’uomo abusa del dono della libertà, quando si chiude al soffio dello Spirito di Dio nel guscio del suo egoismo – e questa chiusura la chiamiamo peccato –, ricade nel nulla. Nel Libro dei Salmi leggiamo: “Se si toglie loro lo spirito, tornano alla loro polvere”. Ma il salmista parla poi del pentimento, della conversione – come di una ri-creazione: tu restituisci loro lo spirito e sono creati.
Nella preparazione quaresimale è in gioco proprio questo allontanarsi dal nulla, dal peccato di chiusura come morte spirituale, e soprattutto la conversione e il perdono come risurrezione, come risveglio a una vita piena e libera, per entrare nel dramma pasquale della vittoria sulla morte, sulla colpa e sulla paura. È necessario far risorgere la nostra fede, il nostro amore, la nostra speranza.
Non prendiamo alla leggera questa chiamata quaresimale di Dio facendola diventare una rinuncia alla cioccolata e alle troppe spese. I prossimi anni ci porteranno da sé a una rinuncia delle cose materiali e a uno stile di vita più sobrio.
Al tempo del coronavirus, Dio ci ha chiuso le chiese per dirci: se pensavi che il tuo cristianesimo consistesse nel condurre una vita piuttosto perbene e nell’andare in chiesa la domenica, allora sappi che in questo giorno e in quest’epoca, ciò non è sufficiente. “Cerca il Signore sempre, finché si fa trovare” è il motto della Quaresima.
Se abbiamo risposto a questa pedagogia divina solo partecipando alla messa in TV la domenica, allora non abbiamo capito niente. Dio vuole che cerchiamo coraggiosamente, creativamente e generosamente altri modi più profondi e stimolanti per riflettere e realizzare la nostra fede, piuttosto che il consumo passivo del culto.
L’appello di papa Francesco alla riforma sinodale della Chiesa ha lo stesso significato: trasformare una rigida istituzione in una rete di comunicazione reciproca, un modo di cercare insieme una risposta ai segni dei nostri tempi rivoluzionari. Non una fuga nel passato, né una modernizzazione a buon mercato – ma un viaggio impegnativo dalla superficialità alla profondità.
Le tre tentazioni
Il Vangelo della prima domenica di Quaresima ci ricorda che Gesù ha affrontato il duro cammino del digiuno per quaranta giorni nel deserto. Al suo battesimo nel Giordano, uscì dal suo anonimato e fu identificato da Giovanni – e dalla voce di Dio dall’alto – come l’atteso Messia e l’amato Figlio di Dio. Gesù intraprende il suo mandato messianico.
Ma non passa immediatamente dal luogo del battesimo alle strade del mondo. Va in solitudine, nel deserto, in un luogo in cui viene raffinato come si raffina l’oro e l’argento. Sarà messo alla prova in quei quaranta giorni, come il popolo eletto fu messo alla prova nei quarant’anni nel deserto sulla via dalla schiavitù alla libertà.
Il deserto non è un luogo di tranquilla contemplazione; il deserto veniva visto come un luogo di demoni. Gli eremiti non sono andati nel deserto per godere della pace, ma per combattere lo spirito del male sul suo campo da gioco.
Chi entra nella solitudine e nel silenzio, e vi digiuna, non deve aspettarsi nulla di piacevole. È nel silenzio e nella solitudine che può risuonare ciò che è nascosto, quell’ombra della nostra natura, quello che spesso affoghiamo con il rumore e reprimiamo con il divertimento. Quando ci sentiamo tristi e soli, spesso ci buttiamo su cibo e bevande per scacciare via questi sentimenti; quando sperimentiamo la fame, riusciamo a diventare rognosi e risentiti. Possono sorgere molte tentazioni nell’anima di una persona i cui bisogni sono frustrati. Anche Gesù, quando era affamato, fu messo alla prova, fu tentato.
Tutte e tre le tentazioni sono dirette contro la sua missione, che ha accettato al suo battesimo e che ha raffinato nella solitudine del deserto. Tutte e tre le tentazioni mirano a corrompere il suo ruolo messianico.
Tra tutte le idee del Messia dell’epoca – trionfatore sugli occupanti romani e restauratore del potere e della gloria dell’impero davidico – Gesù abbraccia quella raffigurata dal profeta Isaia: Il Messia sarà un uomo dei dolori, che porterà la colpa di tutto il popolo, ucciso come l’agnello pasquale – ma è attraverso le sue ferite, le sue cicatrici, che molti saranno guariti.
Nel deserto, il diavolo – con il suo abile uso dei brani della Bibbia – gli offre un ruolo completamente diverso di Messia – un Messia senza croce, un Messia di successo, di miracoli spettacolari, un Messia di potere e gloria, che raccoglie ammirazione e popolarità.
Trasforma le pietre in pane, nutri te stesso e tutti gli affamati, risolvi i problemi sociali, stabilisci un regno di prosperità! Buttati giù dal tetto del tempio e non ti succederà nulla, anzi: tutti ti applaudiranno! Datti il potere reale sul mondo intero per un piccolo prezzo; per quell’unico inchino davanti al Signore delle Tenebre, ne vale la pena! Nessuna croce – piuttosto un trono d’oro!
Ma Gesù sa che il Cristo senza la croce sarebbe l’Anticristo.
Una Chiesa senza la croce sarebbe una delle potenti istituzioni di questo mondo; un prete senza la croce sarebbe un funzionario, un agitatore, un ideologo. Un cristiano senza la croce sarebbe un membro di una delle tante organizzazioni e un sostenitore di una delle tante visioni del mondo.
Quando Cristo comincia a parlare davanti a Pietro della croce che lo aspetta (dopo averlo lodato per la sua confessione messianica e averlo dichiarato la roccia su cui costruirà la sua Chiesa), Pietro gli parla familiarmente: è meglio per te se eviti ogni sofferenza! E allora Pietro sente le parole più dure uscite dalla bocca di Gesù: vattene dietro di me, satana! Gesù riconosce nelle parole accarezzanti di Pietro un’eco della tentazione di Satana nel deserto.
E la terza volta la stessa tentazione arriva nell’ora della morte: scendi dalla croce – e noi tutti ti crederemo immediatamente!
Il film di Scorsese L’ultima tentazione di Cristo, basato sul romanzo di Kazantzakis, rappresenta l’ultima tentazione sulla croce: rinunciare alla via crucis, vivere una “vita normale” come tutti! Il romanzo e il film – scandaloso per molti cristiani – finiscono in modo abbastanza veritiero: Gesù resiste alla tentazione, torna alla croce.
Gesù non trasforma magicamente le pietre in pane: ma dà il suo corpo e il suo sangue, tutto il suo essere – e così diventa il pane della vita.
Gesù non si schianta contro il fondo di questo mondo, non si getta nella rete di sicurezza degli angeli, ma beve il calice della sofferenza fino alla feccia, non fugge dal peso del destino umano.
A Gesù è dato ogni potere sulla terra e in cielo – ma non è una ricompensa per essersi inchinato al diavolo, ma il frutto della fedeltà alla volontà del Padre celeste.
Dì NO al diavolo
Say no to the devil – di’ no al diavolo, cantava il pastore evangelico ceco e dissidente Sváťa Karásek di fronte al regime di polizia con le sue tentazioni, promesse e intimidazioni durante l’occupazione russa della Cecoslovacchia.
Il nostro mondo è di nuovo minacciato dall’oscurità che pensavamo non sarebbe mai tornata dall’inferno del passato. Ancora una volta, dallo stesso luogo in cui giunse il gelo del 1968, che per vent’anni corrose il desiderio di libertà del nostro paese, si riversano ora di nuovo menzogne, sangue e il fuoco della distruzione e, allo stesso tempo, tenta il mondo all’egoismo e all’indifferenza, alla sciocca convinzione che la fine non stia ancora scoccando. Non è vero. Non lasciamoci cullare in una falsa calma e non lasciamoci intimidire: diciamo NO al diavolo.