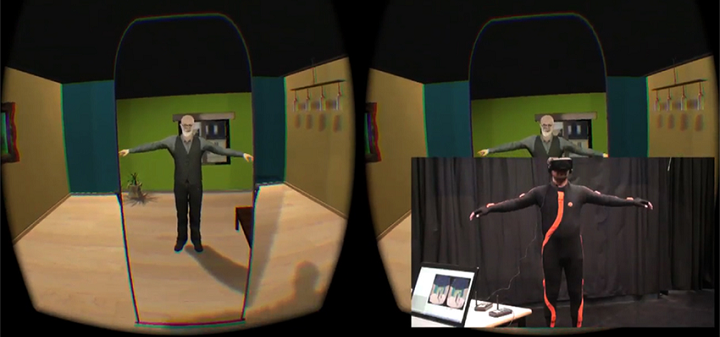Correre ancora…

Prima ancora che sorga il sole qualcosa si muove, anzi c’è gente che corre. Corrono le donne a portare gli aromi, corre Maria di Magdala, corrono anche Pietro e il discepolo amato che Maria chiama; tutti corrono ma dove stanno andando così di fretta?
Proprio loro che prima stavano a guardare da lontano – come le donne – o erano fuggiti – come i discepoli, ora corrono. Che fretta c’è? Che cosa li ha smossi dal loro torpore?
Corrono mentre è ancora buio, la luce non è ancora sorta all’orizzonte; sembrano voler “svegliare l’aurora” come dice il salmo. Bel paradosso: dovrebbe essere il sole a risvegliarci! Eppure, nulla sarebbe accaduto se loro non si fossero messi in moto per andare incontro alla luce. Solo chi cerca può trovare, e l’annuncio della risurrezione lo riceve solo chi gli corre incontro.
Ma cosa spinge queste donne (perché sono loro le prime) a sfidare la notte? Non è tutto finito? Non ha ragione chi pensa che ormai non c’è più nulla da fare, che tanto un cadavere non scappa, e quindi non c’è fretta se si tratta solo di elaborare un lutto e una perdita definitiva?
In questa urgenza che muove le donne, che spinge Maria a correre, c’è un presagio forse? Un’intuizione tipica di chi ama e non si arrende alla perdita dell’amato? Un’intuizione d’amore senza contenuto: non sanno cosa sperare, cosa troveranno, ma cercano e sperano perché il loro cuore non smette di battere, perché l’amore non si è spento del tutto.
Corrono per non perdere il contatto con quel corpo – dove l’hanno messo? – con quella storia d’amore, perché senza quel corpo non possono vivere, non potrebbero andare avanti.
La tomba vuota
La sorpresa inaspettata è che ad attenderle trovano una tomba vuota. Quel corpo che cercavano non c’è, e al suo posto un vuoto che all’inizio mette paura alle donne, lascia smarrita Maria. Che cosa significa? All’inizio solo questo: è davvero successo, le hanno portato via il suo Signore, il suo amato.
E il primo atto di fede consiste nel restare davanti a quel vuoto, entrare – come fanno Pietro e il discepolo amato, pur senza capire – prendere atto, accettare una perdita. Maria lo fa con il cuore gonfio d’amarezza: rimane davanti alla tomba vuota, non accetta di andarsene, non riesce a staccarsi da quel vuoto.
È difficile stare davanti alla tomba vuota. Per Maria lo sguardo è velato dalle lacrime: non vede che il suo dolore, ma dovrà proprio attraversare quel lago di lacrime come si attraversa il mare per entrare nella terra promessa, come si attraversa la morte per entrare nella vita. Dovrà vedere meglio perché all’inizio non riconosce nel giardiniere null’altro che un estraneo: ma sempre il Signore si fa vicino senza essere conosciuto, come uno straniero. E come il popolo nel deserto, davanti a quel vuoto, le donne sono prese dalla paura.
Per questo l’annuncio della Pasqua è preceduto da una parola che invita al coraggio: “non abbiate paura” dice l’angelo alle donne.
Attraversare la paura, reggere il vuoto, vedere oltre le lacrime, oltre il dolore: perché quel vuoto possa parlare, possa rivolgere loro una parola inattesa e sorprendente di speranza. Dalla tomba un buon annuncio, un Vangelo. Ed ecco che proprio da quella tomba giunge alle donne una parola, un Vangelo, un annuncio.
Questa parola pasquale ha a che vedere con un passato e con un futuro: restituisce un senso nuovo a quella storia che sembrava finita e che invece le attende davanti a loro, le aspetta in un futuro che si apre.
Così è per le donne al sepolcro: la pietra è tolta, un angelo – un messaggero che porta loro un annuncio, un Vangelo – rivolge loro queste parole: “voi cercate Gesù, il crocefisso. Non è qui, è risorto e vi attende in Galilea”.
Voi cercate Gesù, quel Maestro che vi ha amato, che avete incontrato sulle strade della Galilea e che è morto. Non vi sembra possibile che quell’uomo così unico che vi ha guarito, vi ha dato così tanta vita, ora sia quel crocifisso sconfitto sul quale la violenza sembra aver prevalso. Non è qui. Non è prigioniero della morte, perché la sua fine non è stata una smentita della sua vita, ma il dono totale di quell’amore con cui tutto è iniziato.
E un amore così totale non finisce, non può essere trattenuto dalla morte. Vi aspetta in Galilea: dovete tornare dove tutto è iniziato, dovete riprendere i primi passi della vostra storia con lui, dovete capire da capo quello che è successo e che non è finto. Lo potrete ritrovare nella memoria delle sue parole e delle sue opere, quelle che, mentre accadevano, non potevate capire fino in fondo, ma che ora potete ritrovare e rivivere, perché il Signore è vivo e voi vivrete ancora con lui per sempre.
Anche per Maria di Magdala c’è da raccordare il passato con il futuro. Si sente chiamata per nome, come la prima volta, come nessuno l’aveva chiamata con quella voce, con quell’amore. L’inizio dell’incontro con il Risorto è iscritto in una memoria viva della sua voce, di quella prima parola che aveva dato inizio a tutto.
Una memoria vivente che risveglia l’amore, che permette di attraversare il lago delle lacrime, di uscire dal dolore e vedere in modo nuovo. Così riconosce in quello straniero il suo Maestro – Rabbunì – il suo amato.
Correre ancora
Così le donne corrono in Galilea, con i discepoli, e Maria corre dai suoi fratelli a portare un annuncio di vita nuova. Correre ancora, con un cuore nuovo, con una speranza nuova. Quei discepoli, sopraffatti dalla stanchezza, abbattuti nel sonno la notte della prova, fuggiti per la paura ora corrono ancora.
Quelle donne smarrite che seguivano il crocifisso da lontano, corrono ancora. Maria di Magdala, che sembrava impietrita davanti al sepolcro, incapace di muoversi, paralizzata dalla perdita del suo Signore, corre ancora.
Chiediamo in questa Pasqua che il Signore ci rimetta in cammino, anzi ci faccia correre ancora. Se siamo giunti a questa Pasqua con tutta la stanchezza di anni difficili che ci hanno visto chiuderci nelle case, smarriti e impotenti davanti al male, alla violenza e alla guerra, ora possiamo correre ancora. La vita non è finita, è sempre all’inizio.
La memoria del Signore, delle sue parole e delle sue opere, la voce amorevole con cui ci ha chiamati la prima volta, non è finta: ci attende in avanti, ci aspetta in un futuro che non conosciamo ma che è certo e più forte della morte. Possiamo correre incontro al futuro nella certezza che ad attenderci ci sarà il Risorto, la vita nuova, i fratelli e le sorelle che il Signore sempre raduna da tutti i luoghi in cui ci siamo dispersi.
Correre ancora, amare ancora, sperare ancora, perché il Signore ha vinto la morte. Il futuro non fa più paura.
settimananews




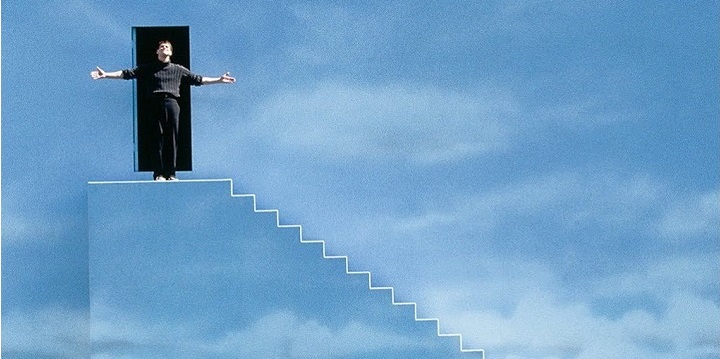
 È quindi essenziale un serio lavoro di riflessione su tali dinamiche, per due motivi: le prospettive temporali dell’interazione coi new media si fanno sempre più ampie, e quindi la qualità di questa interazione deve essere affinata e promossa; in secondo luogo, queste prassi non potranno semplicemente essere accantonate alla fine dell’emergenza ma saranno diventate un canale di evangelizzazione specifico, non sappiamo ancora quanto diffuso ma certo permanente.
È quindi essenziale un serio lavoro di riflessione su tali dinamiche, per due motivi: le prospettive temporali dell’interazione coi new media si fanno sempre più ampie, e quindi la qualità di questa interazione deve essere affinata e promossa; in secondo luogo, queste prassi non potranno semplicemente essere accantonate alla fine dell’emergenza ma saranno diventate un canale di evangelizzazione specifico, non sappiamo ancora quanto diffuso ma certo permanente.