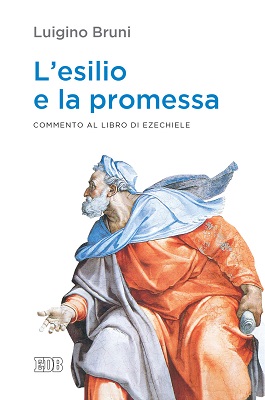Domani, 1 novembre, la Chiesa cattolica celebrerà la solennità di Tutti i Santi. A ciò seguirà la commemorazione dei fedeli defunti. Appuntamenti liturgici che fanno riflettere sul duplice orizzonte dell’umanità: naturale e soprannaturale.
Il binomio naturale-soprannaturale viene storicamente utilizzato dalla riflessione teologica per esprimere i due ordines nell’uomo, la cui elevazione alla vita soprannaturale presuppone l’esistenza di un principio metafisico chiamato natura, come afferma dall’assioma gratia supponit naturam.
La capacità dell’uomo di ricevere la gratia non è qualcosa di radicalmente estraneo alla sua natura, eppure allo stesso tempo è completamente sproporzionato rispetto ad esso. La natura viene creata da Dio in modo tale che, se egli liberamente sceglie di donare la gratia, essa non si oppone a tale donazione gratuita soprannaturale; non la esige, né le è dovuta. Eppure il Creatore costituisce l’ordine naturale inserendo in esso una capacità passiva di ricevere la gratia se da lui donata.
Cosicché, come gratia supponit naturam, così resurrectio supponit immortalitatem.
L’immortalità essenziale dell’uomo
Ratzinger ha rilevato come la riscoperta dell’indivisibilità dell’uomo spinge a comprendere in modo nuovo il messaggio biblico, che non promette immortalità a un’anima separata dal corpo, ma a tutto l’uomo. Nel Nuovo Testamento, infatti, essa non compare propriamente come idea integrativa di una precedente e autonoma immortalità dell’anima, bensì come l’essenziale affermazione fondamentale sul destino dell’uomo. Se la concezione greca si basa sull’idea che l’uomo sia composto da due sostanze estranee fra loro, di cui l’una (il corpo) è destinata a dissolversi, mentre l’altra (l’anima) è per sua natura imperitura, e perciò per sua natura continua a sussistere in maniera indipendente da qualsiasi altro essere, anzi solo nella separazione dal corpo a essa essenzialmente estraneo, l’anima perverrebbe alla sua piena perfezione, viceversa il pensiero biblico, presuppone l’indivisa unità dell’uomo.
Appare chiaro, quindi, che il nucleo centrale della fede nella risurrezione non sta affatto nell’idea di restituzione dei corpi. Piuttosto, il vero contenuto di ciò che la Sacra Scrittura intende annunciare agli uomini, come loro speranza mediante la cifra della risurrezione dei morti, si può enucleare, anzitutto, nel fatto che l’idea dell’immortalità, che la Bibbia esprime parlando della risurrezione, intende un’immortalità della “persona”, dell’unica realtà uomo. Per il teologo di Tubinga si tratta di un’immortalità “dialogica” (risuscitazione, essere risvegliato!), vale a dire che l’immortalità non risulta semplicemente dal naturale non-poter-morire di ciò che è indivisibile, ma dall’azione salvante di colui che ci ama e ha il potere di far questo: l’uomo non può perire totalmente perché è conosciuto e amato da Dio.
Dalle considerazioni sin qui fatte risulta chiarita la formula biblica dell’immortalità grazie a risuscitazione la quale, contrariamente alla concezione dualistica dell’immortalità, così come si esprime nello schema greco di corpo-anima, intende trasmettere un’idea integralmente umana e dialogica dell’immortalità. A questo punto, però, si pongono una serie di interrogativi.
A riguardo Ratzinger scrive: “l’immortalità non viene forse fatta consistere in una pura grazia, benché in realtà debba spettare alla natura dell’uomo in quanto tale? O in altri termini: non si finisce qui per approdare a un’immortalità riservata solo alle persone pie, dunque per introdurre un’inaccettabile differenziazione del destino umano? Teologicamente parlando, non si scambia qui forse l’immortalità naturale dell’essere uomo col dono soprannaturale dell’amore eterno, che rende l’uomo beato? Non bisogna forse attenersi all’immortalità naturale proprio per amore dell’umanità della fede, perché una sopravvivenza dell’uomo concepita in senso puramente cristologico scivolerebbe necessariamente nel miracolistico e nel mitologico?”.
Più precisamente: che cosa rende l’uomo propriamente uomo? E che cos’è lo specifico che distingue l’uomo? Non ci sono dubbi, per il docente di Tubinga, nell’affermare che a causa del suo carattere dialogico chiamato “risuscitazione”, l’immortalità spetta all’uomo in quanto tale, a ogni singolo, e non è nulla di soprannaturale aggiunto successivamente.
Quanto alla domanda circa il proprium dell’uomo, Ratzinger fa notare che ciò che distingue l’uomo è: “visto dall’alto, il suo essere interpellato da Dio, ossia il fatto che egli è interlocutore nel dialogo con Dio, l’essere cui Dio ha rivolto il suo appello. Visto dal basso, ciò significa che l’uomo è la creatura capace di pensare Dio, l’essere aperto alla trascendenza. La questione qui non è se egli pensi davvero Dio, se si apra realmente a lui, ma si afferma che egli è fondamentalmente quella creatura che è in sé capace di farlo, anche se di fatto, per i motivi più diversi, forse non riesce mai a tradurre in atto questa sua capacità”.
Lo specifico dell’uomo è così colto da Ratzinger nel fatto che egli è dotato di un’anima spirituale, immortale; affermazioni che non si contraddicono, ma si limitano a esprimere la stessa cosa in forme di pensiero differenti. Infatti, per il teologo di Tubinga, “avere un’anima spirituale” vuol dire proprio essere voluti in maniera speciale, essere conosciuti e amati da Dio in modo particolare; avere un’anima spirituale significa essere una creatura chiamata da Dio a un dialogo eterno con lui, una creatura quindi capace a sua volta di conoscere Dio e di rispondergli. Ciò che noi – usando un linguaggio più sostanzialistico – diciamo “avere un’anima”, con un linguaggio più storico e attuale lo indichiamo come “essere interlocutori nel dialogo con Dio”.
Pertanto, quando diciamo che l’immortalità dell’uomo si fonda sul dialogo con Dio, il cui amore soltanto dona eternità, non intendiamo affermare un destino speciale riservato alle persone pie, bensì porre in evidenza l’immortalità essenziale dell’uomo in quanto tale. Così, in ultima istanza, per Ratzinger “non è possibile fare una netta distinzione fra “naturale” e “soprannaturale”: il dialogo fondamentale, che per primo fa sì che l’uomo sia uomo, converge senza soluzione di continuità nel dialogo di grazia, che ha nome Gesù Cristo. E come potrebbe essere diversamente, se Cristo è realmente il “secondo Adamo”, l’autentico appagamento di quell’infinito anelito che sale dal primo Adamo, ossia dall’uomo semplicemente?”.
Il concetto greco d’immortalità dell’anima e quello biblico di risurrezione
Per Ratzinger, nella nostra società, il rapporto con la morte appare a prima vista stranamente contraddittorio. Infatti, se da un lato, la morte è considerata un tabù, quasi fosse qualcosa di sconveniente che debba essere possibilmente tenuto nascosto e bandito dalla coscienza, dall’altro, al contrario, si osserva un’esibizione della morte, che corrisponde alla demolizione della barriera del pudore in altri settori dell’esistenza.
Da ciò emerge che “l’eliminazione della paura metafisica non è riuscita interamente; si vorrebbe venirne a capo provocando possibilmente da se stesso la morte, facendola così sparire del tutto quale problema che tocca l’essenza dell’uomo e che non può essere risolto dalla tecnica”. L’importanza crescente che l’eutanasia assume, per esempio, si fonda sul fatto che la morte dev’essere evitata quale fenomeno che interessa la persona e sostituita con la morte tecnica che non impegna personalmente; in definitiva, si vuole chiudere la porta in faccia alla metafisica prima che questa possa presentarsi. Il prezzo per questa repressione della paura è alto.
Per il teologo bavarese, infatti, dalla disumanizzazione della morte consegue necessariamente la disumanizzazione della vita: degradando la malattia e la morte, e collocandole sul piano del tecnicamente fattibile, si degrada contemporaneamente l’uomo. In particolare, fa notare Ratzinger, “nel tendere a ridurre l’humanum, s’incontrano oggi stranamente due opposti atteggiamenti: a una visione positivistica e tecnocratica del mondo l’uomo è d’intralcio, quanto lo è al naturalismo integrale, che, vedendo nello spirito il vero ostacolo, tenta sempre più di denigrare l’uomo quale “animale mal riuscito”. Con la scelta dell’atteggiamento verso la morte viene scelto insieme l’atteggiamento verso la vita; per cui la morte ci può far da chiave per decifrare che cosa sia in fondo l’uomo”.
Anche interrogando i professionisti della tradizione cristiana, considerando le diverse tendenze, si giunge per Ratzinger a risultati alquanto insoddisfacenti. In particolare, i lavori dei teologi luterani tedeschi (Althaus e Jüngel), basati sull’antitesi tra il pensiero biblico e quello greco, delineano una conclusione che ha avuto gravi conseguenze per gli interrogativi della fede cristiana e il suo annunzio. Si afferma, infatti, che la fede nell’immortalità dell’anima è nata dal pensiero idealistico-dualistico ostile al corpo del platonismo e non ha nulla in comune con il pensiero biblico, poiché quest’ultimo, al contrario, considera l’uomo nella sua interezza e unità indivisa come creatura di Dio, la quale non può essere divisa in corpo e anima.
Motivo per cui neppure la morte viene trasfigurata in modo idealistico, ma sperimentata nel suo pieno e crudo realismo come nemico che distrugge la vita. Solamente la resurrezione del Cristo porta una nuova speranza, che tuttavia nulla toglie alla morte integrale in cui non muore soltanto il corpo, ma l’uomo. Non vi può essere dubbio: la morte è totale e divora l’uomo intero. Certo, l’uomo intero sarà ridestato a una nuova vita. Comunque, la speranza biblica può essere espressa soltanto con la parola “resurrezione” e presuppone la morte integrale. Di conseguenza il concetto dell’immortalità dell’anima dev’essere abbandonato quale concetto che contraddice al pensiero biblico.
Tentando di esaminare a fondo il dato storico-filosofico nella sua coerenza oggettiva si nota, anzitutto, che il confronto (greco-biblico) tra le civiltà e i modi di pensare è sotto l’aspetto storico senza senso. Suddetta disamina per il teologo bavarese appare necessaria per dimostrare l’insostenibilità della consueta schematica platonica, su cui si fonda il cliché di tante teorie teologiche. Per Ratzinger, infatti, il vero orientamento del pensiero platonico viene completamente travisato qualora lo si qualifichi come una concezione individualistica che nega i valori terreni e induce gli uomini a rifugiarsi nell’aldilà; il concetto della forza vitale della verità, che comprende il concetto dell’immortalità, non è la componente di una filosofia che postula la fuga dal mondo.
Anima e corpo al momento della morte
Per Ratzinger, l’interrogativo sorto nella tematica dell’immortalità dell’anima e della resurrezione, trasformando gradualmente l’intero panorama della teologia, non potrebbe essere formulato più sinteticamente e più drammaticamente di quanto fatto dal teologo luterano tedesco Cullmann. Per Cullmann, infatti, se si domandasse a un cristiano, protestante o cattolico, intellettuale o non, che cosa insegni il Nuovo Testamento sulla sorte individuale dell’uomo dopo la morte, salvo pochissime eccezioni, si avrebbe sempre la stessa risposta: l’immortalità dell’anima.
Eppure questa opinione, pur diffusa, è uno dei più gravi fraintendimenti che riguardano il Cristianesimo. Pionieri di questo nuovo atteggiamento furono i teologi protestanti Stange e Schlatter, al cui pensiero aderì ampiamente Althaus. In sostanza, rifacendosi alla Sacra Scrittura e a Lutero, si rifiutava come dualismo platonico il concetto di una separazione nella morte tra il corpo e l’anima, qual è presupposta nella dottrina dell’immortalità dell’anima, e si affermava che l’unico insegnamento biblico è quello secondo cui nell’uomo perisce il corpo e l’anima, e che soltanto così si conserva il carattere di giudizio della morte.
Di conseguenza, non sarebbe cristiano parlare di immortalità dell’anima, ma si dovrebbe parlare unicamente della resurrezione dell’uomo intero, e contrapporre alla religiosità corrente del morire, e alla sua escatologia del cielo, l’unica prospettiva della speranza cristiana, cioè quella dell’ultimo giorno.
Lo stesso Althaus, tuttavia, tentò di apportare alcune rettifiche a questa tesi, che nel frattempo si stava diffondendo rapidamente, obiettando che anche la Sacra Scrittura conosce lo schema dualistico, che anch’essa non conosce soltanto l’attesa dell’ultimo giorno, ma una sorta di speranza individuale in un cielo futuro. L’idea che parlare dell’anima non fosse un discorso biblico s’impose al punto che perfino il Missale Romanum del 1970 bandì il terminus “anima” dalla liturgia dei defunti, il quale finì con lo scomparire altresì dal rituale della sepoltura.
“Ma che cosa ha potuto rivoluzionare tanto rapidamente una tradizione, che fin dai tempi della Chiesa antica era radicata saldamente ed era stata sempre considerata centrale?”, si domanda Ratzinger. Infatti, l’apparente evidenza del pensiero biblico da sola non vi sarebbe certo sufficiente. È presumibile che l’efficacia delle nuove argomentazioni sia derivata in notevole parte dal fatto che la concezione definita “biblica” dell’assoluta indivisibilità dell’uomo collima con la moderna antropologia naturalistica, la quale vede l’uomo unicamente come corpo e non vuole sapere nulla di un’anima che ne possa essere separata.
Sebbene la rinuncia al concetto dell’immortalità dell’anima elimini un potenziale punto conflittuale tra la fede e il pensiero moderno, per Ratzinger, ciò non salverebbe ancora la Sacra Scrittura, poiché per la coscienza moderna la via biblica sembra ancora molto meno percorribile.
In particolare, “l’unità dell’uomo – sta bene –, ma chi sarebbe in grado, visti i dati odierni della scienza naturale, di immaginarsi una resurrezione del corpo? Una tale resurrezione supporrebbe una materialità radicalmente nuova, un cosmo fondamentalmente cambiato; il che sorpassa del tutto i limiti della nostra capacità intellettiva. Pure la domanda che cosa avvenga in tal caso nel periodo che precede la “fine dei tempi” non può essere semplicemente ignorata. La spiegazione data da Lutero, di un “sonno dell’anima”, non è certo una risposta che possa convincere. Ma se non esiste un’anima, se di conseguenza non vi può essere un “sonno”, sorge il problema, chi allora potrebbe essere risvegliato? Come si forma l’identità tra l’uomo precedente e l’uomo che, a quanto pare, dovrà essere ricreato dal niente? Voler respingere con sdegno simili domande come “filosofiche” non contribuirebbe certamente a dare una spiegazione a tutto ciò”.
Si è giunti così a comprendere che il solo biblicismo non avrebbe generato un progresso, che senza ermeneutica, cioè senza accompagnare il dato biblico con la ragione non si sarebbe ottenuto nulla. A questo punto, osserva il teologo bavarese, volendo prescindere da tentativi radicali che intenderebbero risolvere il problema opponendosi a tutte le affermazioni oggettivanti e ammettendo soltanto interpretazioni esistenziali, sono state tentate due vie: da un lato, la formulazione di un nuovo concetto del tempo e, dall’altro, l’interpretazione in modo nuovo della corporeità. In particolare, con la prima sfera concettuale, si cercò di risolvere la questione richiamando il fatto che la “fine del tempo”, come tale, non è più tempo.
Essa, quindi, non indica una futura data del calendario, bensì è un non-tempo, per cui trovandosi fuori della temporalità è vicina a ogni tempo in modo uguale. Da questo concetto, si trasse la facile conclusione che, essendo anche la morte un “uscire dal tempo”, essa conduca all’a-temporalità. Si impose così la tesi per la quale il tempo è una forma della vita fisica; la morte significa uscire dal tempo per entrare nell’eternità, nel suo unico oggi. A questo proposito, per Ratzinger, emergono due considerazioni.
La prima: “non si tratta forse qui di una velata restaurazione della dottrina dell’immortalità che, dal punto di vista filosofico, si fonda su supposizioni un tantino avventate? Infatti qui si presume la resurrezione già per l’uomo appena morto, per l’uomo che sta per essere portato alla tomba”. Infatti, l’indivisibilità dell’uomo e il suo legame con la sua vita fisica appena spenta, ovvero quell’indivisibilità che era stata il punto di partenza della tesi, sembra ora non avere più alcuna importanza.
Sebbene simili pensieri possano essere sensati, Ratzinger si chiede ancora: “con quale diritto si possa parlare ancora di “corporeità” quando si nega esplicitamente ogni rapporto con la materia, alla quale si concede di partecipare all’eternità soltanto in quanto è stata un “momento estatico d’un esercizio umano di libertà”. In ogni caso, anche in questo modello il corpo è abbandonato alla morte, mentre contemporaneamente viene affermata una sopravvivenza dell’uomo. Per cui, la confutazione del concetto dell’anima perde la sua credibilità, poiché implicitamente vi si ammette l’esistenza di una “realtà” personale, separata dal corpo, il che è esattamente quanto aveva voluto esprimere il concetto dell’anima. Riguardo al problema della corporeità e dell’esistenza dell’anima rimane, dunque, una strana mescolanza di concezioni, che non si può certo accettare come definitiva”.
La seconda considerazione riguarda la filosofia del tempo e della storia, la quale, per il teologo bavarese, rappresenta la leva del tutto: “è davvero soltanto così che esiste quell’alternativa al tempo fisico e al non-tempo che viene identificata con l’eternità? È logicamente possibile collocare l’uomo, il quale ha vissuto il periodo determinante della sua esistenza nel tempo, nella struttura della pura atemporalità? Può, pertanto, un’eternità che ha un inizio essere eternità? Non è, qualcosa che ha un inizio necessariamente non-eterno, temporale? Ma come negare, che la resurrezione dell’uomo ha un inizio, cioè che avviene dopo la sua morte?”.
È chiaro, per Ratzinger, che se lo negassimo, la logica ci costringerebbe a concepire l’uomo come già risorto nell’ambito dell’eternità che non ha inizio; il che significherebbe contraddire a ogni seria antropologia e cadere praticamente proprio in quel platonismo che intendiamo combattere. Anche il richiamo al concetto medievale dell’aevum del teologo tedesco Lohfink, sostenitore della tesi della resurrezione nella morte stessa non elimina gli interrogativi precedenti, piuttosto “occorre qui denunciare nuovamente un platonismo accentuato sotto un duplice aspetto: in primo luogo, in simili modelli il corpo viene privato definitivamente della speranza della salvezza e, in secondo luogo, con l’aevum l’impostazione della storia è minore rispetto alla dottrina di Platone, soprattutto perché manca di logica”.
L’indistruttibilità della vita che si apre nella fede
Per poter giudicare la reale importanza dell’influsso greco sul pensiero cristiano, e per essere in grado di formulare qualche affermazione sensata sullo sviluppo di quest’ultimo, è indispensabile, per Ratzinger, riflettere su quale sia stato l’atteggiamento greco nei confronti del nostro problema. Il retaggio dell’antichità non ha trasmesso alcuna concezione chiara, circa la sorte dell’uomo dopo la morte; da qui, la Chiesa antica, non poté trarre le sue risposte al riguardo. Piuttosto, le concezioni sviluppate nella Chiesa antica sulla provenienza dell’uomo tra la morte e la risurrezione, si fondano sulle tradizioni giudaiche, circa l’esistenza dell’uomo nello sheol, tradizioni che il Nuovo Testamento ha trasmesso e incentrato sulla cristologia.
Nessun’altra concezione può reggere di fronte ai dati di fatto storici. Il che significa che la dottrina dell’immortalità dell’anima, qual è insegnata dalla Chiesa antica, ha due aspetti. Da una parte, infatti, “essa è determinata dal centro cristologico, che garantisce al credente l’indistruttibilità della vita che si apre per lui nella fede; essa basa questa affermazione teologica sul concetto dello sheol quale suo sostrato antropologico e poggia quindi su una concezione di fondo universale-umana, che tuttavia, sebbene nel frattempo si sia sviluppata ulteriormente rispetto alle concezioni arcaiche, non era stata approfondita sufficientemente per quanto riguarda le sue implicazioni antropologiche. Motivo per cui non dispose neppure di una terminologia unitaria. Come nella tradizione giudaica, il veicolo dell’“essere con Cristo”, dell’esistenza della persona umana che perdura oltre la morte, è chiamato quasi ovunque “anima” oppure “spirito” ”.
Dall’altra parte, ambedue i termini erano influenzati dai sistemi gnostici largamente diffusi, in cui la psiche (anima) era considerata di grado inferiore rispetto allo spirito dei “pneumatici”. A questo punto, come rileva Ratzinger, è chiaro che proprio quando si trattava di conservare la certezza centrale dell’esistenza col Cristo che perdura oltre la morte, e dell’attesa della definitiva resurrezione della carne, si avvertisse la necessità di dare a questa affermazione una base antropologica.
Altrettanto evidente è che la fede cristiana esigeva dall’antropologia delle motivazioni che nessuna delle antropologie esistenti poteva darle, ma di cui avrebbe potuto utilizzare i concetti adeguatamente rielaborati. Infatti, occorreva sviluppare un’antropologia che da un lato, riconoscesse l’uomo quale opera di Dio, creato e voluto da Dio come un intero, ma che, dall’altro lato, distinguesse in questo uomo tra ciò che è perituro e ciò che rimane. A sua volta, questa distinzione doveva essere fatta in modo da lasciare aperta la via verso la resurrezione, ovvero verso la definitiva unità dell’uomo e della creazione.
Una simile antropologia avrebbe dovuto conciliare in sé proprio ciò su cui Platone e Aristotele divergevano. Se, da una parte, occorreva accogliere l’inscindibile unità tra il corpo e la psiche insegnata da Aristotele, dall’altra parte bisognava evitare di interpretare la psiche nel senso di un ἐντελέχεια. Altresì, bisognava evidenziare il particolare carattere spirituale della psiche senza dissolverla in una concezione universalistica dello spirito.
Di fronte alla difficoltà di una simile impresa non può meravigliare che questa sintesi sia maturata soltanto lentamente; essa troverà la sua forma definitiva solamente in Tommaso d’Aquino. Con l’Aquinate, infatti, come sottolinea Ratzinger, si è giunti ad un’affermazione estremamente importante: nell’uomo, lo spirito è talmente uno con il corpo che gli si può attribuire a pieno diritto il termine di “forma”. E, all’inverso, la forma del corpo è tale da essere spirito, e come tale fa dell’uomo una persona.
Con ciò, quello che dal punto di vista filosofico sembrava impossibile è stato ottenuto, ed è resa giustizia alle istanze apparentemente perfino contraddittorie della dottrina della creazione e del concetto ormai cristallizzato dello sheol: l’anima fa parte del corpo quale forma, ma ciò che è forma del corpo è insieme spirito e fa dell’uomo una persona schiudendo a lui la realtà dell’immortalità. Trattandosi qui di un principio centrale, il teologo bavarese ribadisce come il concetto dell’anima, qual è stato usato nella liturgia e nella teologia fino al Concilio Vaticano II, abbia in comune con l’antichità altrettanto poco quanto il concetto della resurrezione; esso, infatti, è un concetto specificamente cristiano e solo per questo motivo ha potuto essere formulato sul terreno della fede cristiana, di cui esprime la visione di Dio, del mondo e dell’uomo nell’ambito dell’antropologia. In realtà, lo struggente desiderio greco della visione, il concetto greco che contemplare è vivere, che la conoscenza, l’assimilazione della verità è vita – questa grande conquista dello spirito greco – viene qui accolta e trova qui conferma.
E richiamandosi ad un’omelia di Gregorio di Nissa, Ratzinger osserva che “il pensiero platonico della vita che scaturisce dalla verità è qui approfondito nella sua versione cristologica e trasformato in una concezione dialogica dell’esistenza dell’uomo, che contiene contemporaneamente affermazioni del tutto concrete su ciò che conduce l’uomo sulla via dell’immortalità e tramuta quindi la teoria apparentemente speculativa in un’indicazione pratica: quella “purificazione” del cuore che si compie nella pazienza della fede e nell’amore che da questa nasce, trova sostegno nel Signore, il quale solo rende possibile il cammino paradossale sulle acque e conferisce con ciò un senso all’assurda esistenza dell’uomo”.
Tale concezione fondamentale, caratteristica per la tradizione del pensiero cristiano, appare nell’Aquinate inserita in un’interpretazione della dinamica dell’intero creato verso Dio. Infatti, nell’anima che appartiene, da un lato, interamente al mondo materiale, ma dall’altro lato trascende questo mondo, il mondo materiale acquista consapevolezza di se stesso, e ciò proprio perché nell’uomo esso tende a Dio; ragion per cui è accolta la concezione dialogica, nata dalla visione cristologica dell’uomo ed è insieme collegata al problema della materia, dell’unità dinamica di tutto il mondo creato.
La destinazione creaturale dell’uomo all’immortalità
Se si afferma che la vita dell’uomo, oltre la morte, è determinata dialogicamente e il dialogo è concretizzato in base alla cristologia, a questo punto, per il teologo bavarese, non possiamo non domandarci se non ci abbandoniamo con ciò a un soprannaturalismo, che o non risponde più alle domande comuni a tutti gli uomini, oppure estende la cristologia all’indefinito al punto da farle perdere quanto le è specifico. Infatti, se l’immortalità è concepita soltanto come gratia, o addirittura come il privilegio dei soli devoti, essa si adegua nel miracoloso e perde la sua base razionale; per Ratzinger, piuttosto, si delinea che la ricerca di Dio non è per l’uomo un qualsiasi capriccio intellettuale; se viene intesa in base alla formula anima forma corporis, essa tocca il centro del suo essere.
L’uomo, quale creatura, è fatto in un modo che, per sua natura, comporta l’indistruttibilità. Così, “non è nell’essere se stesso e nell’incomunicazione che l’uomo raggiunge l’immortalità, bensì proprio nel suo rapporto, nella capacità di comunicare con Dio, dobbiamo ora aggiungere che questa apertura non è un “in più” nell’esistenza, la quale potrebbe anche essere vissuta indipendentemente da essa, bensì che questa apertura rappresenta quanto vi è di più profondo nell’uomo, ossia propriamente ciò che noi chiamiamo “anima”. Alla medesima conoscenza si può giungere pure da un’altra direzione e dire per esempio: un essere è tanto più se stesso quanto più è aperto, quanto più è comunicazione. Il che, a sua volta, porta alla conoscenza, che l’uomo è “se stesso”, cioè è “persona” in quanto è aperto al tutto e al più profondo dell’essere”.
Una simile apertura, per Ratzinger, è data all’uomo, e pertanto non è un prodotto di un suo sforzo proprio. Tuttavia, essa è data all’uomo in quanto persona, in modo da far ora parte della personalità dell’uomo, secondo l’intenzione della creazione. E richiamandosi all’insegnamento di Tommaso, egli afferma: “a questo si riferisce Tommaso quando dice che l’immortalità appartiene all’uomo per natura. Alla base di questa sua affermazione ritroviamo coerentemente il suo concetto della creazione, che dice come una tale natura può essere comunicata soltanto dal Creatore, ma che di questo dono l’uomo diviene proprietario, diventando partecipe di quanto gli è stato conferito. Il che costituisce, invero, già una risposta alla domanda: che cosa accade però, quando l’uomo viva contrariamente alla sua natura, quando sia chiuso invece che aperto? Che cosa, se nega il suo rapporto con Dio o addirittura non se ne rende conto?”.
Adesso si chiarisce la portata del concetto della creazione, e si evidenzia insieme il luogo dove inizia la novità, la particolarità della cristologia. Infatti, l’uomo, quale è, vorrebbe procurarsi l’immortalità da se stesso, ma nel tentativo di procurarsi da sé l’eternità egli non può, in ultimo, che fallire, sprofonda nel non-essere, e addirittura consegna già la sua vita alla morte.
Quanto alla correlazione tra il peccato e la morte, Ratzinger osserva: “una simile esistenza, in cui l’uomo intende sostituirsi a Dio e vuole affermare la propria autonomia, la propria indipendenza e essere dunque soltanto se stesso, “simile a un Dio”, diviene un’esistenza da sheol, un essere nel non-essere, una vita d’ombra che è esclusa dalla vita vera. Ma ciò non significa che l’uomo possa revocare o annullare da sé la creazione di Dio. Ciò che ne consegue non è il puro nulla. L’uomo, al pari di ogni altra creatura, può muoversi sempre solamente dentro la creazione, ma non può né produrla da sé né può precipitarla nel puro nulla. Ciò che egli ottiene in questo modo non è quindi l’annullamento dell’essere, ma un essere in contraddizione con se stesso, una potenzialità che nega se stessa: lo “sheol”. La connaturale ordinazione alla verità, a Dio, la quale esclude il non-essere, sussiste anche quando venga negata o dimenticata”.
Solo a questo punto, per Ratzinger, s’innesta l’affermazione propriamente cristologica. L’evento cristiano, infatti, significa che Dio annulla questa auto-contraddizione senza distruggere la libertà dell’uomo con un atto arbitrario dall’esterno. Più segnatamente, “nella vita e nella morte del Cristo è manifesto che Dio stesso si reca nello sheol, instaura la comunicazione nel luogo dell’incomunicabilità, guarisce il cieco (Gv 9) e crea così la vita della morte, in mezzo alla morte. E qui l’insegnamento cristiano sulla vita eterna diviene nuovamente un’affermazione assolutamente pratica. L’immortalità non può essere prodotta e, sebbene sia dono della creazione, non è semplicemente un fatto naturale. Se viene considerata tale, essa si trasforma, al contrario, in infelicità. Essa si fonda su un rapporto che ci viene offerto, ma che proprio per essere offerto, ci coinvolge personalmente: esso richiama a una prassi del ricevere, al modello della discesa di Gesù (Fil 2,5-11) contro l’eritis sicut Deus, contro la totale emancipazione, nella quale sarebbe vano voler cercare la salvezza. Se la capacità di conoscere la verità e la capacità di amare sono il luogo dell’uomo in cui si apre per lui la vita eterna e dove questa riceve un senso, questa vita eterna diviene la tematica dell’“oggi” e la forma corporis pure nel senso che non estrania l’uomo al mondo, ma lo toglie dall’informalità anarchica e lo rende persona”.
L’uomo spirituale e il suo rapporto con Dio nel tempo
A questo punto, per il teologo bavarese, occorre riflettere su quale modo l’uomo disponga del tempo in quanto uomo, e se su questa base sia possibile concepire un modo d’essere dell’uomo fuori dalle condizioni fisiche dell’essere. Così, approfondendo la domanda, emerge che la temporalità è presente nell’uomo in diversi strati, e quindi pure in diversi modi. A tal riguardo, l’aiuto più valido, per una simile analisi, può venire dal Libro X delle Confessiones di Agostino, in cui egli passa attraverso i vari strati del proprio essere e vi incontra la “memoria”.
Da suddetta analisi, Ratzinger osserva che l’uomo, in quanto corpo “partecipa al tempo fisico che, secondo la velocità rotatoria dei corpi, viene misurato con parametri, i quali essendo a loro volta movimento, sono insieme relativi. Tuttavia l’uomo non è soltanto corpo, ma anche spirito. Essendo entrambi in lui inscindibili, la sua appartenenza al mondo materiale si ripercuote necessariamente pure sul suo essere spirituale; tuttavia quest’ultimo non è analizzabile in base ai soli dati di fatto fisici. Sebbene la sua partecipazione al tempo fisico impronti il tempo del suo spirito, nelle sue funzioni spirituali egli è tuttavia “temporale” in una maniera diversa e più profonda di quanto lo sono i corpi fisici”.
Dunque, l’uomo non ha un solo tempo fisico, ma ha pure un suo tempo antropologico o “tempo umano”, collegandosi al “tempo-memoria” del santo d’Ippona e benché questo tempo-memoria sia improntato dal rapporto dell’uomo col mondo fisico, non è totalmente legato a quest’ultimo e non si fonde neppure totalmente con esso. Il che significa che quando lascia il modo del βίος, il tempo-memoria si scinde dal tempo fisico per perdurare in seguito come puro tempo-memoria, ma non si trasforma in eternità. In definitiva, ciò significa che un parallelismo eternamente senza rapporti reciproci e quindi pure statico tra il mondo materiale e quello spirituale, contraddice alla ragion d’essere della storia, contraddice alla creazione di Dio e contraddice alla parola della Bibbia.