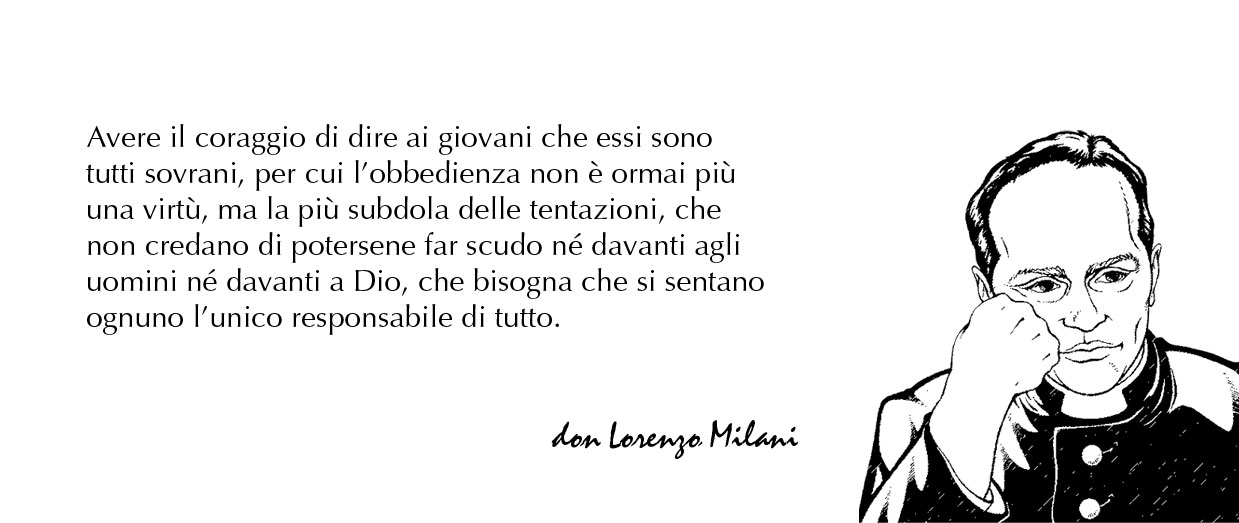Il ct della Nazionale Enzo Bearzot (1927-2010)
Fissi gli occhi melanconici, paterni, del ct uruguayano Oscar Washington Tabarez e rivedi la stessa figura serafica e protettiva del nostro indimenticabile Enzo Bearzot. Sono trascorsi quasi otto anni dall’ultima nuvola di fumo uscita dalla pipa del Vecio che è volato via poco prima del Natale 2010. Alla fine di un anno, anche quello da disfatta mondiale, in Sudafrica: gli azzurri di Marcello Lippi eliminati al girone, fuori da campioni del mondo in carica. Un dolore provato anche da Bearzot nel 1986 in Messico, quando la sua Italia, in gran parte composta dal gruppo vittorioso al Mundial di Spagna ’82, si inchinava alla Francia di Platini. Pagine amare che Bearzot ricordava mentalmente, in silenzio, nella sua casa milanese, prima in via Washington e poi in Porta Romana, preferendo invece rileggere quelle dei libri come I canti ultimi del suo caro amico friulano, la sua guida cristiana, padre Davide Maria Turoldo. Due furlani, di Aiello Enzo, di Coderno padre Turoldo, vite di uomini giusti che si incrociarono davanti a un fogolàr di una frasca riparata dal vento di follia. La fola impazzita dell’intronata routine del pallone, specie quello dei giorni nostri, che Bearzot ammoniva: «A causa dell’ingresso di grandi sponsor sulla scena del calcio, sembra che il denaro abbia spostato i pali delle porte». Confessioni proseguite nella seconda vita metropolitana con l’altrettanto fraterno don Luigi della chiesa del Paradiso di Milano. Una vita quella del Ct tutta casa, chiesa e panchina. Ma poi non era tutta lì l’esistenza profonda e riflessiva del Vecio.
A ribattezzarlo così era stato il bracconiere di storie, anche di cuoio, l’amico e sodale Giovanni Arpino nel suoAzzurro tenebra, quando Bearzot, non ancora cinquantenne, era il vice del Ct Ferruccio Valcareggi nella sfortu- nata spedizione mondiale di Germania ’74. «Ah Arpino, uno dei responsabili nell’aver portato il calcio in prima pagina!», sbuffava ridendo con la pipa in bocca il buon Enzo quando gli si parlava del calcio come della disciplina sacra, intoccabile, unico vero dogma nazionale. Ma la fede per lui non era neppure quella per l’amato Torino – in cui aveva giocato – e la chiesa non fu mai lo stadio, come continua ad essere per molti suoi illustri colleghi del passato e del presente. «Ciò che ha amato di più era sicuramente la famiglia. Quando tornava dai ritiri e magari io e mio fratello eravamo già a letto veniva a svegliarci, si metteva dietro la porta e iniziava a giocare con noi per farci ridere. “La casa – ripeteva papà – dovrebbe essere un recinto pieno di bambini”». Così Cinzia Bearzot, la figlia dell’intramontabile Ct ricorda suo padre. E alla «memoria» ora ha deciso di donare al suo Ateneo (la professoressa Bearzot è ordinario di Storia greca all’Università Cattolica di Milano) parte della ricca biblioteca del Vecio. «È un dono che viene dal cuore perché i giovani possano avvicinarsi alla figura di uomo e di sportivo di mio padre, un selezionatore che ha cresciuto generazioni di giocatori ai quali ha cercato di trasmettere anche la passione per la cultura».
Che non si vive di solo calcio fu la sua lezione, recepita soprattutto dagli azzurri dioscuri silenti, Zoff e Scirea: «Silenziosi quanto lui, e non a caso aveva scelto Zoff come portavoce della Nazionale », dice sorridendo la prof. Bearzot. «Mio padre era un uomo dotato del dono dell’ironia. Non si sentiva un intellettuale, ma aveva solide basi culturali che gli avevano dato i salesiani al Collegio San Luigi di Gorizia». Quel diploma di maturità Classica all’epoca valeva quanto una laurea. «Del resto l’unico calciatore laureato dei suoi tempi era Fulvio Bernardini, dottore in Economia alla Bocconi». Il “dottor” Fuffo, un altro che, come Bearzot, quando non era alle prese con strategie di campo si rifugiava nel pensatoio domestico. Bearzot nello studio di casa passava le ore a leggere romanzi, libri di storia dell’arte e ad ascoltare la sua musica dell’anima, il jazz. I dischi non sono contemplati nella sala “Giuseppe Billanovich” – intitolata a un emerito filologo della Cattolica – ma qui hanno trovato nuova dimora una montagna di libri. «Almeno cinquecento sono cataloghi d’arte autografati e con dediche personalizzate», spiega illustrando i preziosi cimeli Paolo Senna, responsabile degli archivi e dei fondi culturali dell’Ateneo milanese. Ci sono anche disegni d’autore autografati. “L’albero”, del raffinato pittore modenese Carlo Mattioli, che finisce dentro una porta con un pallone, datato 26 novembre 1984. Anno degli Europei di Francia, ancora una volta una campagna da azzurro tenebra, con Platini protagonista assoluto che alzò la Coppa al cielo di Parigi. Città cara nelle letture del Ct, omaggiato anche da Aligi Sassu: l’autore noto per i suoi “Uomini rossi” che a Bearzot donò il “calciatore e il portiere”. «Sassu era un grande amico di papà con il quale si incontravano spesso al Teatro Nazionale dove trovavano il comune sodale, il direttore del Teatro Giordano Rota. Con Arpino c’era una grande affinità elettiva, anche dal punto di vista letterario».
La “biblioteca Bearzot”, pur rispettando sempre il «vivere parvo», massima del suo autore latino di riferimento, Orazio, è ricolma di capolavori della letteratura americana. «Per mio padre e per la sua generazione, era stata una scoperta incredibile la lettura delle opere di Steinbeck, Hemingway, Caldwell… Era una cosa di cui avevamo parlato spesso, considerava quasi un privilegio quelle traduzioni di Pavese e Vittorini che all’improvviso avevano permesso ai giovani italiani di abbandonare il romanzo ottocentesco per tuffarsi nella letteratura del nuovo mondo». Dall’America e dal Canada sono arrivate anche le lettere dai tifosi, «tale Rino Argento dal Los Angeles spedisce una missiva con tanto di foto con Bearzot… Dalla Italian Canadian Benevolent Corporation Culumbus Centre di Toronto, inviano i complimenti al Ct per la vittoria del Mundial grazie alla quale scrivono commossi i connazionali: “è la fiamma di amore che ci sostiene lontani dall’Italia nostra” », spiega Paolo Senna. Bearzot era criticato dai mediocri, dalle «belle gioie» arpiniane che affollavano e affollano ancora la tribuna stampa, ma era assai più amato dalla gente comune, e dalla maggioranza del popolo degli stadi. Anche se il calcio, specie negli ultimi tempi, lo seguiva distrattamente, preferendo perdersi – fino all’ultimo – nella lettura. Alla storia di cuoio, anteponeva la “Storia dei Longobardi” di Paolo Diacono. «Il calcio lo guardo meno, lo sento più estraneo – disse Bearzot in una delle ultime interviste – . Calciopoli ha prodotto danni profondi, quasi quasi non si crede più al verdetto del campo, è come se qualcosa mi si fosse spento dentro. Riesco ancora a indignarmi, questo sì. Per i fischi di San Siro alla Marsigliese, così come nel ’90 a Roma mi ero indignato per i fischi all’inno argentino, con Maradona in campo che piangeva. E fischiavano i politici, in tribuna d’onore, gente che aveva studiato. Che vergogna».
Vergognosi furono anche gli attacchi reiterati nei suoi confronti e uno dei massimi difensori della prima ora fu Indro Montanelli, che in calce al frontespizio del libro Gli incontri (Rizzoli) scrive la dedica: «Al grande Bearzot il piccolo Montanelli». Uno scambio tra maestri, cresciuti con nel culto della coerenza e della grande attenzione verso l’animo umano. Il Mondiale più umano, specie per noi che l’abbiamo vissuto, rimarrà per sempre quello dell’82. «Dove ero la sera della finale di Madrid? A casa con mio marito. Una gioia immensa vedere mio padre sollevato dai suoi ragazzi e stringere tra le mani la Coppa del Mondo. Ricordo che piansi e risi di gioia, poi presi delle pentole e cominciai a sbatterle forte… – sorride al ricordo Cinzia Bearzot – Il giorno dopo andai a comprare due stampe antiche raffiguranti il mondo. Papà le mise nel suo studio, e se le guardava mentre continuava a leggere questi suoi amati libri».