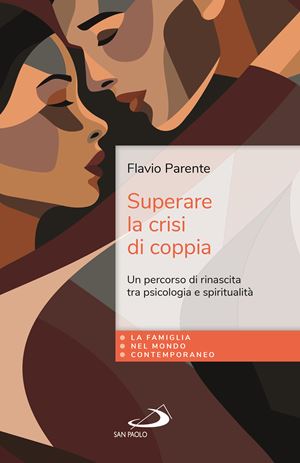di: Leonardo Catalano
Settimana News

La coscienza occupa un posto centrale nella riflessione morale moderna.1 È tra i riferimenti più richiamati per interpretare i cambiamenti culturali e storici del nostro tempo. Il Concilio Vaticano II dedica un testo che invita il credente a coltivarla come luogo di ascolto, di giudizio, di scelta e di incontro con la voce dello Spirito.2
«L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la dignità stessa dell’uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità. Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo compimento nell’amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità numerosi problemi morali, che sorgono tanto nella vita privata quanto in quella sociale».3
La coscienza è un ponte attraverso il quale credente e non credenti possono ascoltarsi e comprendersi. È in questa grammatica comune che insieme si cerca la verità e nella verità risolvere i problemi morali che sorgono nella vita dei singoli e nella collettività.
La categoria della coscienza viene citata 20 volte nell’Amoris laetitia.4 Eppure la cultura contemporanea sembra aver svuotato il significato antropologico di coscienza e il senso di obbligazione verso gli imperativi della coscienza stessa, in particolare verso tutte quelle “voci” che richiamano a scelte più impegnative e onerose in senso morale come la voce divina che risuona nel segreto, l’ascolto intimo, il giudizio, un Tu con cui dialogare, l’obbedienza sincera al comando interiore “fa’ questo, evita quest’altro”, la responsabilità verso l’altro.
Il Magistero della Chiesa ribadisce il significato di coscienza morale per integrare la verità e la libertà, la legge e la responsabilità, l’autorità e l’obbedienza. È la coscienza morale, infatti, a porre all’uomo alcune domande radicali e ineludibili: come devo comportarmi? In che modo distinguere le voci di bene e di male radicate nel cuore? Chi sono chiamato ad essere? Come amare autenticamente?
La coscienza nel Magistero
Il cardinale John Newman definì la coscienza come «una legge del nostro spirito, ma che lo supera, che ci dà degli ordini, che indica responsabilità e dovere, timore e speranza. […] Essa è la messaggera di colui che, nel mondo della natura come in quello della grazia, ci parla velatamente, ci istruisce e ci guida. La coscienza è il primo di tutti i vicari di Cristo».5
Il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica alcuni paragrafi alla coscienza e premette: «Quando ascolta la coscienza morale, l’uomo prudente può sentire Dio che parla».6 Per la Chiesa la coscienza morale «è un giudizio della ragione mediante il quale la persona umana riconosce la qualità morale di un atto concreto».7 Occorrono però due condizioni.
La prima è quella di essere presenti a se stessi, ritornando alla coscienza per interrogarla. Poi è essere prudenti cioè capaci di cercare il punto di equilibrio tra princìpi immutabili e le situazioni concrete della vita: «La verità sul bene morale, dichiarata nella legge della ragione, è praticamente e concretamente riconosciuta attraverso il giudizio prudente della coscienza».8 È la coscienza morale che permette di scoprire che cosa è giusto e buono fare nelle circostanze concrete della vita seguendo il principio del bene da fare e il male da evitare.
La coscienza del credente diventa la bussola per comprendere l’amore radicale vissuta da Cristo e la qualità dell’amore che si vive. L’esperienza della fede illumina la coscienza secondo la Lumen fidei: «È urgente perciò recuperare il carattere di luce proprio della fede […] capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo. […] La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore […]. Trasformati da questo amore, riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo che in esso c’è una grande promessa di pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro. La fede […] appare come luce per la strada, luce che orienta il nostro cammino nel tempo».9
La coscienza va dunque educata ed è questo «il compito di tutta la vita».10 Gli effetti di una educazione prudente includono la guarigione dalle paure interiori, dall’egoismo, dall’orgoglio, dai risentimenti, dai moti di compiacimento. Questa educazione garantisce la libertà del cuore e la pace interiore. Dialogare nella coscienza è lo sforzo di interpretare i dati dell’esperienza, i segni dei tempi che cambiano, i consigli delle persone rette e l’aiuto dello Spirito.
La connessione tra amore e coscienza
Proprio a questo livello, il dialogo nella coscienza, appare evidente la connessione tra amore e coscienza. L’amore è una forza di comunione e di gratificazione che, mentre accoglie il dono, spinge all’impegno di donarsi.
Questa visione, che la fede offre dell’amore determina il rapporto inscindibile tra amore e coscienza nell’atto di decidere e del decidersi del credente. Papa Francesco precisa: «può la fede cristiana offrire un servizio al bene comune circa il modo giusto di intendere la verità? […] Il cuore, nella Bibbia, è il centro dell’uomo, dove s’intrecciano tutte le sue dimensioni: il corpo e lo spirito; l’interiorità della persona e la sua apertura al mondo e agli altri; l’intelletto, il volere, l’affettività. Ebbene, se il cuore è capace di tenere insieme queste dimensioni, è perché esso è il luogo dove ci apriamo alla verità e all’amore e lasciamo che ci tocchino e ci trasformino nel profondo. La fede trasforma la persona intera, appunto in quanto essa si apre all’amore. È in questo intreccio della fede con l’amore che si comprende la forma di conoscenza propria della fede, la sua forza di convinzione, la sua capacità di illuminare i nostri passi. La fede conosce in quanto è legata all’amore, in quanto l’amore stesso porta una luce. La comprensione della fede è quella che nasce quando riceviamo il grande amore di Dio che ci trasforma interiormente e ci dona occhi nuovi per vedere la realtà».11
Questo dato sulla coscienza credente, toccata dall’Amore e in cerca dell’amore, spiega perché alcune norme valgono sempre davanti alla propria coscienza. Non è mai permesso di fare il male perché ne derivi un bene. Va sempre rispettata le regola d’oro evangelica: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12). La carità passa sempre attraverso il rispetto del prossimo e della sua coscienza, anche se questo non significa accettare come un bene ciò che è oggettivamente un male.
Il cammino della vita è un decidersi davanti ai “casi di coscienza”, quando ci si trova divisi tra l’obbedienza a una legge civile e la voce della propria coscienza. Per decidere moralmente cosa fare è necessario raccogliere più informazioni possibili, richiamarsi ai princìpi che guidano la propria esistenza e interrogarsi sulle conseguenze della propria scelta. Richiamarsi ai princìpi etici richiede il dialogo con un “Tu” perché ci sia un’adesione personale a Cristo che è entrato nella storia. Afferma san Giovanni Paolo II nella Veritatis splendor che esiste un rapporto inscindibile tra coscienza e verità, una «teonomia partecipata, perché la libera obbedienza dell’uomo alla legge di Dio implica effettivamente la partecipazione della ragione e della volontà umane alla sapienza e alla provvidenza di Dio».12
Il dialogo interiore
Nella coscienza l’uomo deve esercitare la sua libertà e la sua responsabilità. La coscienza non si può ridurre a un “grillo parlante” o a un censore interiore o una voce sottilmente nemica che prescrive divieti. Quando papa Francesco richiama la responsabilità dei coniugi ad essere storia di salvezza precisa che la Chiesa è chiamata «a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle».13
Quando il funzionamento della coscienza cristiana è concepito come un tribunale civile, in cui il soggetto è inteso come il reo davanti all’accusa di trasgressione, lo sforzo di autogiustificazione è teso a sottrarsi per quanto è possibile alla pena. Questo è il senso del testo magisteriale: «Per comprendere in modo adeguato perché è possibile e necessario un discernimento speciale in alcune situazioni dette “irregolari”, c’è una questione di cui si deve sempre tenere conto, in modo che mai si pensi che si pretenda di ridurre le esigenze del Vangelo.
La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. I limiti non dipendono semplicemente da una eventuale ignoranza della norma. Un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può avere grande difficoltà nel comprendere “valori insiti nella norma morale” o si può trovare in condizioni concrete che non gli permettano di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa. Come si sono bene espressi i Padri sinodali, “possono esistere fattori che limitano la capacità di decisione”.
Già san Tommaso d’Aquino riconosceva che qualcuno può avere la grazia e la carità, ma senza poter esercitare bene qualcuna delle virtù, in modo che anche possedendo tutte le virtù morali infuse, non manifesta con chiarezza l’esistenza di qualcuna di esse, perché l’agire esterno di questa virtù trova difficoltà: “Si dice che alcuni santi non hanno certe virtù, date le difficoltà che provano negli atti di esse, […] sebbene essi abbiano l’abito di tutte le virtù”».14
Così concepita, la voce divina, il richiamo multiforme alla verità, non può che assumere il ruolo del pubblico ministero. Essa non può per definizione essere dalla parte dell’imputato. L’effetto di questa impostazione è quello di assegnare alla “voce” un ruolo accusatorio, facendole assumere interiormente quell’atteggiamento costantemente accusatorio nocivo nelle relazioni educative, proprio perché genera scoraggiamento e irritazione, che allontanano dai richiami che si ascoltano.
«La correzione è uno stimolo quando al tempo stesso si apprezzano e si riconoscono gli sforzi e quando il figlio scopre che i suoi genitori mantengono viva una paziente fiducia. Un bambino corretto con amore si sente considerato, percepisce che è qualcuno, avverte che i suoi genitori riconoscono le sue potenzialità. Questo non richiede che i genitori siano immacolati, ma che sappiano riconoscere con umiltà i propri limiti e mostrino il loro personale sforzo di essere migliori. Ma una testimonianza di cui i figli hanno bisogno da parte dei genitori è che non si lascino trasportare dall’ira.
Il figlio che commette una cattiva azione, deve essere corretto, ma mai come un nemico o come uno su cui si scarica la propria aggressività. Inoltre un adulto deve riconoscere che alcune azioni cattive sono legate alle fragilità e ai limiti propri dell’età. Per questo sarebbe nocivo un atteggiamento costantemente sanzionatorio, che non aiuterebbe a percepire la differente gravità delle azioni e provocherebbe scoraggiamento e irritazione: “Padri, non esasperate i vostri figli” (Ef 6,4; cfr Col 3,21)».15
Per san Tommaso l’obiettivo principale non è quello di mettere la persona di fronte alle proprie responsabilità morali, ma quello di accompagnarla in primo luogo nella comprensione dell’esperienza del dialogo interiore, da qui, alla scoperta della presenza benefica della “voce divina”, per divenirne convinta ascoltatrice. «Piuttosto che un pubblico ministero, quello che si incontra interiormente è un partner affidabile, vicino alla persona anche nell’accusa del male che la segna o di cui si è resa protagonista. […] la coscienza va anzitutto compresa come un luogo spirituale, in cui l’esperienza morale può essere ripresa e reimpostata, conducendo a una sempre più affinata capacità di ascolto interiore e di riconoscimento del gusto tipico, quasi del timbro interiore della “voce divina”».16
Il discernimento delle “voci” della coscienza è anzitutto orientato all’incontro con Dio e poi, anche, come frutto di maturazione progressiva di questo incontro, all’agire secondo il bene.
«Riguardo a questi condizionamenti il Catechismo della Chiesa Cattolica si esprime in maniera decisiva: “L’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere diminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali”. In un altro paragrafo fa riferimento nuovamente a circostanze che attenuano la responsabilità morale, e menziona, con grande ampiezza, l’immaturità affettiva, la forza delle abitudini contratte, lo stato di angoscia o altri fattori psichici o sociali.
Per questa ragione, un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica un giudizio sull’imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta. Nel contesto di queste convinzioni, considero molto appropriato quello che hanno voluto sostenere molti Padri sinodali: “In determinate circostanze le persone trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso. […] Il discernimento pastorale, pur tenendo conto della coscienza rettamente formata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi”».17
In ascolto del vissuto ferito
L’Esortazione apostolica di papa Francesco presenta l’attività della coscienza che si mette in moto non tanto in presenza di infrazioni della legge contestate da altri quanto dinanzi alle fratture della vita. È dal dolore e dai fallimenti di scelte fatte o di esperienze vissute che sorge l’esigenza di chiarire a se stessi come abbia potuto farsi strada il male che ferisce e sfigura. L’ambiente della coscienza inizia dunque a dilatarsi lì dove sorge un’esigenza di comprensione di sé, per capire ciò che si muove dentro, e in particolare di ciò che ha condotto a un agire corrosivo del bene.
È necessario il primato dell’ascolto sia per dare nome alle ferite inferte e autoinferte, sia per comprendere quella nostalgia profonda di conversione, di una vita compiuta e creativa. Si inizia a dare ascolto alla pena più che mettendosi alla ricerca della colpa, che non viene elusa ma capìta a partire dall’esperienza e da una rilettura accompagnata, la quale consente di dare nome tanto al male quanto al bene.
Si tratta del metodo induttivo a cui papa Francesco riconosce maggiore efficacia in campo educativo, proprio perché sostenuto dalla forza della scoperta, della presa di coscienza. «Il compito dei genitori comprende una educazione della volontà e uno sviluppo di buone abitudini e di inclinazioni affettive a favore del bene. Questo implica che si presentino come desiderabili comportamenti da imparare e inclinazioni da far maturare. Ma si tratta sempre di un processo che va dall’imperfezione alla maggiore pienezza.
Il desiderio di adattarsi alla società o l’abitudine di rinunciare a una soddisfazione immediata per adattarsi a una norma e assicurarsi una buona convivenza, è già in se stesso un valore iniziale che crea disposizioni per elevarsi poi verso valori più alti. La formazione morale dovrebbe realizzarsi sempre con metodi attivi e con un dialogo educativo che coinvolga la sensibilità e il linguaggio proprio dei figli. Inoltre, questa formazione si deve attuare in modo induttivo, in modo che il figlio possa arrivare a scoprire da sé l’importanza di determinati valori, principi e norme, invece di imporgliele come verità indiscutibili».18
Le proprie decisioni fallimentari costituiscono l’ambito di riflessione più promettente per chi volesse andare in profondità. In molte situazioni della vita in cui si è protagonisti di scelte non buone, «c’è l’avvertenza della ferita, ma non della contraddizione. […] Sono le situazioni in cui, pur nella problematicità dell’accaduto, la volontà della persona è rimasta integra»19, perché le cose sono andate male, ma quell’esito non era propriamente voluto. Non basta cioè una ferita per mettere in discussione, ci vuole la percezione della contraddizione.
Per questo vanno considerati «i vissuti interessanti per l’introspezione, […] le scelte ed i gesti che esprimono il protagonismo della persona nella decisione e che segnalano una qualche frattura nel piano stesso del volere, non tra il volere e il realizzare. L’analisi introspettiva dovrebbe allora partire preferenzialmente dall’ascolto di quei vissuti in cui le cose sono andate esattamente come la persona voleva che andassero, secondo la propria decisione, e che tuttavia restituiscono in vario modo una percezione di disagio, di insoddisfazione».20
La coscienza si attiva a partire dall’esperienza vissuta, iniziando a dilatarsi sul fronte dell’ascolto di quel che sta attorno ad un fatto dandogli la profondità del vissuto. Il dialogo si coltiva anzitutto in una più acuta e differenziale capacità di ascolto.
Si può dire che il tempo qualitativo di cui necessitano le relazioni e che consiste nell’ascoltare con pazienza e attenzione, lo si apprende e coltiva anzitutto imparando a sostare dinanzi alle proprie stonature.
Occorre «Darsi tempo, tempo di qualità, che consiste nell’ascoltare con pazienza e attenzione, finché l’altro abbia espresso tutto quello che aveva bisogno di esprimere. Questo richiede l’ascesi di non incominciare a parlare prima del momento adatto. Invece di iniziare ad offrire opinioni o consigli, bisogna assicurarsi di aver ascoltato tutto quello che l’altro ha la necessità di dire. Questo implica fare silenzio interiore per ascoltare senza rumori nel cuore e nella mente: spogliarsi di ogni fretta, mettere da parte le proprie necessità e urgenze, fare spazio. Molte volte uno dei coniugi non ha bisogno di una soluzione ai suoi problemi ma di essere ascoltato.
Deve percepire che è stata colta la sua pena, la sua delusione, la sua paura, la sua ira, la sua speranza, il suo sogno. Tuttavia sono frequenti queste lamentele: “Non mi ascolta. Quando sembra che lo stia facendo, in realtà sta pensando ad un’altra cosa”. “Parlo e sento che sta aspettando che finisca una buona volta”. “Quando parlo tenta di cambiare argomento, o mi dà risposte rapide per chiudere la conversazione”».21
È l’ascolto che implica una capacità di lettura del sentito, un affinamento progressivo nel decifrare il messaggio delle percezioni della gioia, della tristezza, dell’attrazione e della paura, il tutto senza moralismi, senza togliere la cittadinanza interiore ad alcuna delle passioni.
Infatti «provare un’emozione non è qualcosa di moralmente buono o cattivo per sé stesso. Incominciare a provare desiderio o rifiuto non è peccaminoso né riprovevole. Quello che è bene o male è l’atto che uno compie spinto o accompagnato da una passione. Ma se i sentimenti sono alimentati, ricercati e a causa di essi commettiamo cattive azioni, il male sta nella decisione di alimentarli e negli atti cattivi che ne conseguono. Sulla stessa linea, provare piacere per qualcuno non è di per sé un bene. Se con tale piacere io faccio in modo che quella persona diventi mia schiava, il sentimento sarà al servizio del mio egoismo.
Credere che siamo buoni solo perché “proviamo dei sentimenti” è un tremendo inganno. Ci sono persone che si sentono capaci di un grande amore solo perché hanno una grande necessità di affetto, però non sono in grado di lottare per la felicità degli altri e vivono rinchiusi nei propri desideri. In tal caso i sentimenti distolgono dai grandi valori e nascondono un egocentrismo che non rende possibile coltivare una vita in famiglia sana e felice».22
Piuttosto occorre discernere in che modo i sentimenti si intreccino con i pensieri, «bisogna incoraggiare la maturazione di una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal discernimento responsabile e serio del Pastore, e proporre una sempre maggiore fiducia nella grazia.
Ma questa coscienza può riconoscere non solo che una situazione non risponde obiettivamente alla proposta generale del Vangelo; può anche riconoscere con sincerità e onestà ciò che per il momento è la risposta generosa che si può offrire a Dio, e scoprire con una certa sicurezza morale che quella è la donazione che Dio stesso sta richiedendo in mezzo alla complessità concreta dei limiti, benché non sia ancora pienamente l’ideale oggettivo. In ogni caso, ricordiamo che questo discernimento è dinamico e deve restare sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che permettano di realizzare l’ideale in modo più pieno».23
È partendo dall’ascolto più attento del fatto che può farsi strada l’attesa di un fare altrimenti, attesa di un cambiamento possibile e non utopistico. Sia i Padri sia san Tommaso invitano a vigilare sui pensieri fin dal loro sorgere.24
Coscienza e discernimento
La coscienza è il luogo in cui ciascuno si misura con la tensione al cambiamento. La lotta interiore può assumere configurazioni diverse. «È la tensione tra una novità suggestiva ma ambigua (tentazione) e una abitudine buona (virtù) che, tra l’altro, mette in guardia dal cambiare rotta; ma è anche tensione tra una provocazione in se stessa buona (legge), che incontra una resistenza nella persona e porta così maggiormente alla luce una cattiva abitudine (vizio)».25
Non ci si può affidare ciecamente all’idea che tutto il male venga dall’esterno e che quindi sia bene fare solo quello che “si sente”. Viceversa, è sensato ritenere che in qualcuno il male prevalga anche perché non c’è una memoria di bene, una virtù, pronta a farsi avanti, a prendere parola interiore.
San Tommaso concepisce la coscienza come un atto della ragione pratica dentro il continuo colloquio interiore26.
Per il magistero la coscienza è anzitutto luogo di incontro spirituale con la voce dello Spirito di Dio, luogo costantemente visitato da parole e in cui risuona la Parola, non esclusivamente come un richiamo a un “no”27, pur necessari, ma come continuo e multiforme invito positivo al cambiamento possibile, alla conversione desiderata, al bene praticabile, fatto di «piccoli passi che possano essere compresi, accettati e apprezzati».28
«È stato scritto che per la Scrittura l’amore è dirsi “eccomi”, più che “ti amo”. L’obbedienza a questo “eccomi” è la fedeltà alle voci benefiche che risuonano nella coscienza».29
1 Francesco OCCHETTA, «La coscienza morale e il governo di sé», in La Civiltà Cattolica III (2009) 29-41.
2 Francesco OCCHETTA, «La coscienza morale e l’amore umano», in La Civiltà Cattolica III (2016) 459-469.
3 GS 16.
4 AL 37.42(2x).83.149(2x).188.218.222(2x).265.279.298(2x).300(2x).302.303(3x).
5 John NEWMAN è citato dal CCC n. 1778. Cfr. John NEWMAN, La coscienza, Jaca Book, Milano 1999.
6 CCC n. 1777.
7 CCC n. 1778.
8 CCC n. 1780.
9 LF 4.
10 CCC n. 1784.
11 LF 26.
12 VS 41.
13 AL 37.
14 AL 301.
15 AL 269.
16 Francesco OCCHETTA, «La coscienza morale e l’amore umano», in La Civiltà Cattolica III (2016) 465.
17 AL 302.
18 AL 264.
19 Giovanni GRANDI, Alter-nativi. Prospettive sul dialogo interiore a partire dalla “moralis consideratio” di Tommaso d’Aquino, Meudon, Trieste 2015, 153.
20 Ibidem.
21 AL 137.
22 AL 145.
23 AL 303.
24 Evagrio PONTICO, Sentenze. Gli otto spiriti della malvagità, Città Nuova, Roma 2010; Evagrio PONTICO, Contro i pensieri malvagi, Qiqajon, Magnano 2005; Giovanni IL SOLITARIO, Le passioni dell’anima, Qiqajon, Magnano 2012.
25 Francesco OCCHETTA, «La coscienza morale e l’amore umano», in La Civiltà Cattolica III (2016).
26 Francesco OCCHETTA, «La coscienza morale e l’amore umano», in La Civiltà Cattolica III (2016) 469.
27 Cfr. Asha PHILLIPS, I no che aiutano a crescere, Feltrinelli, Milano 2013.
28 AL 271.
29 Francesco OCCHETTA, «La coscienza morale e l’amore umano», in La Civiltà Cattolica III (2016) 469.