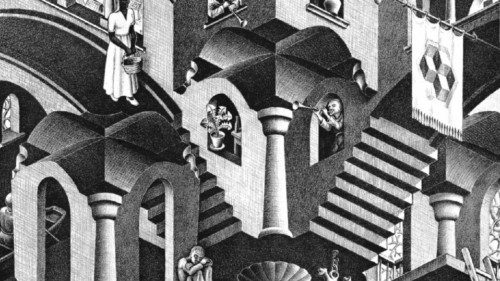Mario De Caro
Avvenire
Da Bentornata realtà, antologia da lei curata nel 2012, a semplicemente Realtà di oggi, una agile monografia che non ha bisogno nemmeno di un sottotitolo. Il realismo è dunque tornato protagonista in filosofia e sulla scena culturale? E che cosa significa questo?
Nell’ultimo paio di decenni il tema della realtà è tornato al centro del dibattito filosofico da cui, per varie ragioni, era stato estromesso nel secolo scorso – risponde Mario De Caro, filosofo con cattedra a Roma Tre e alla Tufts University di Boston, esecutore letterario del grande pensatore americano Hilary Putnam e autore dell’appena pubblicato Realtà ( Bollati Boringhieri, pagine 126, euro 13,00) –. Un fattore fondamentale di quella estromissione fu la cosiddetta “svolta linguistica”, che accomunò il mondo analitico (da Frege e Russell sino a Dummett e Davidson) e quello continentale (con lo strutturalismo, ma in un certo senso anche con Heidegger, il quale con audace metafora georgica aveva proclamato che il linguaggio è “il pastore dell’essere”). Se il punto di partenza dell’indagine filosofica è il linguaggio, la questione della realtà arriva molto dopo – se arriva affatto. Un’altra ragione, parzialmente indipendente, dell’oblio filosofico in cui la realtà cadde per parecchi decenni fu l’avversione verso la metafisica di molti filosofi del secolo scorso: e, di nuovo, ciò avvenne sia in ambito analitico (si pensi al positivismo logico o alla tradizione legata alle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, via via sino a Rorty) sia in quello continentale (con il postmoderno, il decostruzionismo, il pensiero debole). Oggi però, appunto, nelle discussioni filosofiche la realtà è tornata in pompa magna: e ciò soprattutto perché l’antirealismo – che pur era mosso spesso da nobili ragioni intellettuali e politiche – ha esaurito la sua forza propulsiva e spesso porta a risultati, teorici e pratici, che molti ritengono inaccettabili.
Viene da chiedersi che cosa sostengono gli anti–realisti e chi sono.
Premessa: ogni filosofo serio è realista su alcune questioni e antirealista su altre. Una filosofia integralmente realista sarebbe trivialmente onnivora, priva di ogni punto di vista; mentre una filosofia integralmente antirealista sarebbe l’equivalente filosofico della pagina bianca di Mallarmé. Ciò detto, con il termine “antirealismo” oggi in genere si intendono le concezioni che, da una parte, rifiutano di considerare l’idea della realtà nel suo complesso come una nozione sensata e, dall’altra, non ritengono che la scienza offra un punto di vista rilevante per le discussioni filosofiche. Queste concezioni hanno avuto una funzione propulsiva e antidogmatica, ma oggi tendono a ripetere stancamente tesi sviluppate nel secolo scorso. E questo è il migliore dei casi, perché nel peggiore l’antirealismo produce forme di irrazionalismo francamente velleitarie e talora pericolose. Spesso, per esempio, il negazionismo rispetto alle questioni sanitarie è prodotto da questo humus filosofico.
La posizione realista non mette tutto a posto. Ci sono domande chiave che il libro affronta. Per esempio: meglio affidarsi ai sensi o alla scienza per indagare la realtà? Che dobbiamo fare con le proprietà qualitative – colori, suoni, odori – che Galileo aveva escluso dalla scienza? Le entità collettive, come le multinazionali, per non parlare di quelle non materiali, come i numeri, che statuto hanno? E i giudizi morali su che cosa si basano?
Un momento cruciale per la discussione su quale sia il migliore realismo filosofico si ebbe tra fine Cinquecento e inizio Seicento, quando l’Italia era ancora il centro della cultura europea (bei tempi). Si sviluppò allora una vivacissima discussione tra un partito culturale di matrice aristotelica e uno di matrice platonica (a cui apparteneva Galileo). Quella discussione riguardava il modo in cui si deve intendere l’idea di realtà naturale. Per i platonici il mondo vero era solo quello delle entità matematizzate di cui ci parlava la nuova fisica: un mondo in cui c’era posto per entità inosservabili (come gli atomi) ma non per le cosiddette “qualità secondarie” (colori, odori, sapori) che sono un prodotto della nostra mente. Questa discussione – con i dovuti aggiornamenti – è viva ancora oggi.
E infatti, in realtà – il gioco di parole è voluto – anche oggi esistono diversi realismi. Definiamo in breve quello ordinario e quello scientifico.
Secondo il realismo ordinario (che è erede del partito aristotelico di cui abbiamo parlato) il mondo reale è sostanzialmente quello che esperiamo con la percezione, mentre la scienza naturale – soprattutto quando fa riferimento a entità inosservabili, come i buchi neri e gli atomi – è un utile strumento di previsione, ma non ci parla veramente del mondo così com’è. Questa opinione è propria della fenomenologia a partire da Husserl e di molta parte della filosofia continentale, ma è anche difesa da uno dei maggiori filosofi della scienza contemporanei come Bas van Fraassen. Il realismo scientifico (difeso, per esempio, da Quine e da Searle) assume il punto di vista opposto. Secondo questa concezione, è la scienza naturale a descrivere il mondo così com’è, mentre la percezione ci mostra un mondo che è nulla più di un’approssimazione di quello reale, perché il mondo reale non è colorato, non ha suoni né odori. Inoltre, mentre oggi i realisti ordinari tendono ad accettare come legittime le pretese oggettive della morale (in fondo, noi percepiamo la sofferenza delle persone e per questo sappiamo che dovremmo aiutarle), molti realisti scientifici sono scettici sull’oggettività dei giudizi morali.
Il più nuovo e interessante è il realismo pluralistico (o naturalismo liberalizzato). Come nasce, che cosa sostiene e come può mettere d’accordo (quasi) tutti?
L’idea fondamentale del naturalismo liberalizzato è che tanto il realismo ordinario quanto quello scientifico sono plausibili nelle rispettive tesi positive ma le accompagnano con tesi negative molto recise e unilaterali. Questa duplice unilateralità dipende da una tendenza intellettuale molto diffusa, ma spesso fuorviante: quella alla semplificazione. La realtà però non è semplice, ma estremamente variegata. Assumendo questa prospettiva, il naturalismo liberalizzato è caratterizzato da un costitutivo pluralismo, sia sul piano ontologico sia su quello epistemologico: accetta, cioè, che sia la percezione sia la scienza parlino della realtà. Ovviamente, è una posizione complessa: ma di soluzioni semplici, nella storia del pensiero, ne abbiamo avute sin troppe.