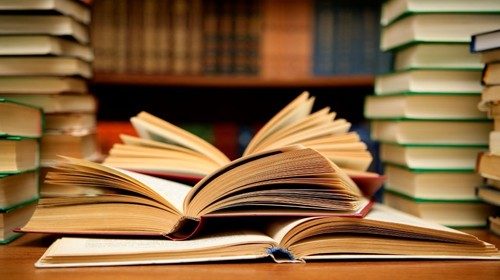
Osservatore Romano
Oscar Wilde consigliava, nell’atto di valutare la realtà, di rimanere in superficie, perché se si vuole andare sotto di essa, «lo si fa a proprio rischio e pericolo»: si potrebbero infatti scoprire cose che sarebbe stato meglio lasciare sepolte, e quindi ignorate. Consiglio sicuramente utile in molti casi, ma non sempre. Come dimostra l’approfondita analisi che Marco Testi conduce, riguardo ad opere che hanno fatto la storia della letteratura, nel libro Sentieri nascosti (Roma, Edizioni Fili d’Aquilone, 2019, pagine 144, euro 15) il cui sottotitolo, in modo eloquente, recita: Quando i libri celano nuovi modi di vedere il mondo. Insomma, l’autore (critico letterario e docente di letteratura) squarcia la superficie, se ne assume il rischio, e traccia un itinerario che va in profondità, per favorire una lettura incisiva e un’interpretazione illuminante delle opere prese in esame. Il risultato di questa operazione — che spazia da L’amore e l’occidente di Denis de Rougement a Un canto di Natale di Charles Dickens, da Spoon river di Edgar Lee Masters a Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati — è più che salutare.
«Un libro geniale e originale» lo definisce, nell’introduzione, il sociologo Franco Ferrarotti. Un libro che non rientra, in modo sterile, nella cultura libresca, ma ha la virtù che hanno i buoni libri, ovvero di «far parlare i morti». «Ne risuscita l’intento profondo — scrive Ferrarotti —. È una chiamata dall’oltretomba, richiama un passato ormai ritenuto lontano, che invece ha ancora cose importanti da dire nel presente o addirittura contiene i semi dell’avvenire». Il volume di Testi vanta un merito ulteriore: non parla solo di libri best-seller, ma anche di quelli poco noti al grande pubblico. Oppure parla di libri divenuti celebri per le ragioni sbagliate. «Ma parla anche di “rivisitazioni” critiche necessarie — osserva Ferrarotti —, non più rinviabili, vala a dire di libri riscoperti pienamente, valutati solo generazioni dopo la loro prima pubblicazione».
Nell’introdurre il cammino lungo “i sentieri nascosti” Testi cita una frase di Proust tratta da Il tempo ritrovato: «Talvolta, nel momento in cui tutto sembra perduto, giunge il messaggio che può salvarci; abbiamo bussato a tutte le porte che non portano a niente, e la sola per cui si può entrare, che avremmo cercato invano per cento anni, la urtiamo senza saperlo e si apre». Testi varca quella soglia ed avvia l’esplorazione, per portarli poi alla luce, dei talenti nascosti nel patrimonio letterario.
Nell’analizzare L’uomo che fu giovedì di Gilbert Keith Chesterton, l’autore ne richiama, con limpida chiarezza, il messaggio: «il credente che è passato attraverso il suo personale inferno ha diritto di opporsi al disordine del mondo moderno; egli ha il diritto di combattere perché ha vissuto la passione come Cristo, perché è stato trascinato fin nella più abietta miseria del peccato e si è redento attraverso la sofferenza, la morte, la disperazione». Acutamente Testi nota che il cristiano di Chesterton combatte «senza ergersi a giudice». Ha capito infatti che giudicare è pericoloso, ha conosciuto il deus absconditus, il quale si è rivelato nella riconciliazione della sua pace dopo aver portato i suoi fedeli fino alla Genna, perché potessero proclamare fino alla fine: «Nessuna sofferenza può essere troppo grande, per comprarci il diritto di dire a costui che ci accusa, “Abbiamo sofferto anche noi”». Si tratta di un libro per certi versi anti-moderno, nel senso di un coraggioso opporsi ai tempi in cui «la morte e il buio vengono proclamati nuovi e disperati dèi, poiché pochi sembrano avere il coraggio i riscoprire nella polvere delle vecchie, abbandonata chiese, la pace di Dio».
Ci si è accorti con sorpresa, osserva Testi, che i testi dei cantautori e di gruppi musicali negli anni Sessanta e Settanta erano orecchiamenti, citazioni, riprese, calchi di poesie appartenenti alla cultura “alta”: Dylan Thomas, Willima Shakespeare, Walt Whitman, Dante Alighieri. E ci si è accorti che Thomas Stearns Eliot è stato uno dei poeti più saccheggiati dalla canzone contemporanea. E «la sorpresa nella sorpresa» è costituita dal fatto che il suo libro più saccheggiato per alcune «impertinenti citazioni» non era quello che era stato considerato il suo capolavoro, La terra desolata, ma una precedente raccolta, Prufrock ed altre osservazioni, uscita in rivista nel 1915 e poi pubblicata in volume nel 1917. Raccolta che sarebbe stata amata dai giovani intellettuali degli anni a venire, fonte di ispirazione per testi di canzoni, opere, film. Venne usata per il testo di There will be time del gruppo degli Osanna, e citata nel film Zardoz con Sean Connery. Spicca, all’interno dell’opera, il Canto d’amore di Alfred Prufrock, che è insieme un invito a una passeggiata in un torpido pomeriggio e un centro focale di riflessioni sulla vita e sulla morte. «Ci sarà tempo — recitano alcuni versi — per uccidere e per creare, e tempo per tutte le opere e i giorni delle mani che sollevano e lasciano cadere una domanda sul tuo piatto; tempo per te e per me, e tempo anche per cento indecisioni, e per cento visioni e revisioni, prima di prendere un tè col pane abbrustolito».
«Quello di Prufrock — osserva Testi — è forse il canto della sazietà, di quell’aspetto della borghesia europea scavato a fondo da alcuni scrittori, da Ezra Pound a Virginia Woolf, da Thomas Mann a James Joyce». Ma è anche la poesia del dubbio, dove la tranquillità di “una stanza sicura” nasconde gli incubi del Perché e del Quando, l’assillo di senso. Un assillo che non è comunicabile e così le parole «subiscono la rovina delle cose e degli oggetti in uso, perché non arrivano nell’oscurità dell’essere». Scrive Eliot: «Non è per niente questo che volevo dire / Non è questo, per niente».
Testi si cimenta poi nell’analisi de La pietra lunare di Tommaso Landolfi, scrittore particolare, per usare un eufemismo, sicuramente ostico nella sua grandezza. L’autore definisce il lungo racconto (1939) «il più affascinante quadro della vita rurale, e dei suoi misteri, del nostro Novecento». Non si tratta di un quadro realista o, all’opposto, esoterico, dell’esistenza marginale del borgo appenninico, ma rappresenta lo spirito dei luoghi familiari della nascita e della famiglia. «Una natura non antropizzata è lo sfondo del capolavoro di Landolfi, una sorta di romanzo di iniziazione» scrive Testi. Una sorta di romanzo di iniziazione. È la storia di un ragazzo, Giovancarlo, che torna nel paese per le vacanze, e si trova alle prese con una strana fanciulla, Gurù, bellissima ma con le gambe che finiscono con piedi di capra. Una deformità che solo il ragazzo coglie: i paesani non se ne avvedono proprio. Fondamentale, sottolinea Testi, è lo spirito del luogo, che abita dovunque, anche nelle cose animate: il castello del paese con il palazzotto di antichi tiranni di un tempo, ad esempio. «Landolfi — evidenzia Testi —, senza tradirne l’avita topografia, anima i luoghi attraverso presenze ancestrali, resti forse dell’energia psichica in essi rappresa, tracce di una memoria più antica di quella umana».
Pagine ricche di acute valutazioni sono quelle dedicate al romanzo Uno, nessuno e centomila (1925-1926) di Luigi Pirandello, un’opera dietro la quale «c’è un pensiero che superava e demoliva le certezze del positivismo e del determinismo di fine diciannovesimo secolo». Il capolavoro pirandelliano si configura quale romanzo terminale delle certezze d’Occidente, del pessimismo di fondo travestito da sguardo impassibile e neutrale, che «mostrava crepe profonde nel panorama non solo culturale tra fine Ottocento e primo trentennio del Novecento». E parimenti rispondeva ai dubbi e alle incertezze del nuovo pensiero “debole”, quello della Woolf, di Svevo, di Musil, di Kafka, di Joyce che talvolta “girava su sé stesso e si immobilizzava nella inazione e nella noia. Afferma Vitangelo, protagonista del romanzo: «A me era sempre bastato averlo dentro, a mio modo, il sentimento di Dio; un Dio che soffre con chi e in chi cerca disperatamente la verità e anche quando viene strumentalizzato per il denaro e il potere, un dio che sì era sentito ferito in me». Pirandello, rileva Testi, contrappone dunque un “Dio-di-dentro” a un “Dio-di-fuori”, che è quello dell’assuefazione, dell’abitudine e del formalismo. Vitangelo è un uomo ricco che sente come un peso insostenibile la ricchezza, perché essa gli ha messo addosso una maschera, e vuole che egli sia sempre quella maschera. Vuole che lui sia ciò che gli altri hanno stabilito. Vitangelo deciderà di liberarsi di tale maschera: si spoglierà di tutto e sceglierà una vita da povero mendicante, come il ricco signore della Leggende del Santo bevitore di Joseph Roth, che va a vivere sotto i ponti della Senna. La spoliazione del vecchio sé non è ovviamente indolore. In fondo la vita di prima avrebbe potuto significare il mantenimento di una decorosa famiglia. Ma l’eroe senza qualità sceglie invece il rifiuto della apparente salvezza familiare, «il copernicano viaggio in senso contrario per tornare attraverso il movimento circolare di ogni cosa nell’universo al punto di partenza, che nel frattempo si sarà spostato e modificato in un movimento che si chiama vita».
Ma l’avventura di Vitangelo non si esaurisce nella semplice quanto recisa negazione della realtà. Al contrario la sua esperienza si traduce nella ricerca delle profondità nascoste sottese a tale realtà. Tale ricerca, afferma Testi, richiede “un tributo” in termini di abitudine a un’identità che si rivela sempre più insufficiente non solo a spiegare, ma a vivere quella realtà. È questo il lascito di Uno, nessuno e centomila, che va oltre i luoghi comuni di decadentismo, pessimismo, relativismo, e «si inserisce invece nella ricerca di autenticità mai davvero assente nella storia dell’uomo».
di Gabriele Nicolò