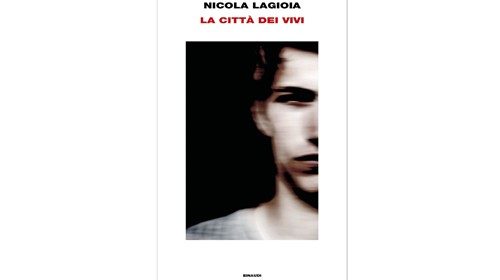
«La città dei vivi» di Nicola Lagioia
«È sempre: ti prego, fa’ che non succeda a me. E mai: ti prego, fa’ che non sia io a farlo». Sta qui il senso profondo dell’ultimo libro di Nicola Lagioia, La città dei vivi (Torino, Einaudi 2020, pagine 472, euro 22).
Sta nello sforzo di mettersi dall’altra parte, nel coraggio di sentirsi chiamati personalmente in causa e non tanto come potenziali vittime; sta nello scegliere di ricostruire una storia mostruosa incamminandosi lungo la sponda del fiume che non vorremmo mai sentire come potenzialmente nostra. Ma andiamo con ordine.
Nel marzo 2016 due ragazzi di buona famiglia seviziano per ore in un appartamento a Roma un giovane, fino a ucciderlo in modo lento e atroce. La cronaca dell’omicidio di Luca Varani lascia attonita l’opinione pubblica che per mesi si interroga su Manuel Foffo e Marco Prato, i due assassini. Depravati? Mostri? Pazzi? Cocainomani? Disperati? Posseduti?
Nicola Lagioia segue da subito la vicenda, si sente chiamato. Intervista i protagonisti, incontra i familiari, parla con gli investigatori, raccoglie testimonianze, divora documenti, intrattiene un carteggio con uno degli assassini. Ci sono molte, troppe domande a cui deve rispondere. Anche a se stesso.
Quel che emerge dalla lunga ricerca è un torbido contesto di aspettative malriposte, dipendenze di molti tipi, vuoti di identità e di senso, confusione sessuale, difficoltà a diventare adulti, smarrimento totale, incapacità di affrontare le complessità, violenze, diseguaglianze e «la propria personale caccia al debole». Quella sera, in quell’appartamento al decimo piano di via Igino Giordani, «sembrava — scrive Lagioia — che tutta la disperazione, il livore, l’arroganza, la brutalità, il senso di fallimento di cui era piena la città si fossero concentrati in un unico punto». C’è il male, ad attraversare le strade della città. Il male che non è «un concetto astratto» o «un’entità definita una volta per tutte», ma è qualcosa di palpabile, come sostiene uno degli investigatori, «mobile, multiforme, e soprattutto contagioso». Indaga nella vita degli assassini, Nicola Lagioia («Così come Manuel rivendicava per sé il diritto allo smarrimento, Marco ostentava consapevolezza, strascicava le persone come esibisse un tormento pretendendo che nessuno lo mettesse in discussione»). «È più facile contrastare un illecito quando è chiaro da cosa è spinto chi lo compie — gli dice un altro carabiniere che indaga sull’omicidio —. Ma il motivo per cui dei ragazzi assolutamente normali, a cui non mancava niente sul piano materiale, sembravano vivere come autentici disperati — per le droghe che prendevano, per come non riuscivano a mettere a fuoco la loro stessa identità, per la preoccupazione parossistica che avevano del giudizio altrui, per l’uso irrispettoso che facevano dei propri corpi, per il rapporto che intrattenevano con il denaro, per come sembravano incuranti di sprecare interi periodi delle loro vite — lo lasciava in uno stato di assoluta perplessità».
Nicola Lagioia va anche alla ricerca della storia, dell’identità della giovane vittima. Ha senso farlo? Ne ha diritto? Qual è lo scopo? Lo scrittore sa bene che «l’omicidio getta su vittima e carnefice la sua luce, ed è sempre una luce parziale, una luce perversa, l’omicidio è il male e il male è il narratore della storia».
Tentando di ricostruire i fatti, Lagioia non smette un attimo di interrogare se stesso: «Se il narratore, vale a dire la trama dell’omicidio, aspira a distorcere il nostro sguardo (portandoci da una parte a non provare amore per la vittima, dall’altra a illuderci che ciò che disprezziamo nel carnefice ci sia estraneo) il movimento per liberarsi da questa trappola dovrebbe essere duplice. Bisognerebbe amare la vittima senza bisogno di sapere nulla di lei. Bisognerebbe sapere molto del carnefice per capire che la distanza che ci separa da lui è minore di quanto crediamo».
Giudicare sarebbe più comodo e indolore. Giudicare darebbe conforto. Ma Lagioia non cade nel manicheismo, non prova un’empatia precostituita, ed è bravo ad accompagnare — con rispetto e decisione — il lettore. Allo scrittore non interessa segnare il confine, quanto attraversarlo. Non gli interessa sentirsi migliore, quanto interrogarsi sui paletti di questa differenza.
È un libro sulla natura umana, sulla colpa, sull’istinto di sopraffazione e di sopravvivenza, sulla responsabilità individuale e sul libero arbitrio («in cosa ci saremmo trasformati, o dileguati, se ci fossimo liberati di questi due fondamentali pesi?»). Soprattutto è un libro che illumina il passaggio dalla riflessione su chi siamo a quello che potremmo diventare.
Sullo sfondo c’è dunque Roma, una città buia, invivibile, allagata da temporali, droghe, topi e corruzione, ma al tempo stesso talmente meravigliosa e ricca di vita da non poter essere abbandonabile.
E poi c’è lei, la strada dell’appartamento al decimo piano. Via Igino Giordani. E ogni volta che leggo «l’omicidio di via Igino Giordani», «i fatti di via Igino Giordani», «l’orrore di via Igino Giordani», non posso non pensare a chi Igino Giordani (1894-1980) fosse. Non riesco a non pensare allo scrittore, al giornalista, al politico, figlio di padre muratore e madre analfabeta (che «non coltivava poesia ma lavava cenci», come scrive Giordani nelle sue memorie), educato ai principi evangelici contadini; non riesco a non pensare alla sua infanzia poverissima, alla sua formazione tra fervore religioso popolare, sapienza contadina, testi sacri e teologia; all’uomo di alti ideali e profonda fede che ha fatto la Grande guerra senza mai sparare un colpo, all’antifascista, al politico eletto alla Costituente; a lui che si è opposto con tutte le forze a fascismi, ingiustizie e sopraffazioni; primo firmatario di una legge sull’obiezione di coscienza, uomo che aspirava a un mondo di pace, che lavorò con convinzione per l’Europa unita e, più volte, intervenne in Parlamento contro gli armamenti e per cercare una via di dialogo. Penso alla via che la città di Roma gli ha dedicato, convinta come sono, da sempre, che la toponomastica abbia un significato profondo — e Deirdre Mask con il suo Le vie che orientano (Torino, Bollati Boringhieri 2020, pagine 400, euro 25), lo conferma meravigliosamente —. Penso a lui che guarda consumarsi in uno dei “suoi” palazzi un delitto così efferato, mostruoso, cattivo. A lui convinto che «lo sfruttamento sociale comincia quando non si ama più l’uomo: quando non si rispetta più la sua dignità, perché se ne vedono i muscoli, e non se ne vede lo spirito». E arrivo addirittura a pensarlo, Igino Giordani, che cammina per Roma accanto a Nicola Lagioia, così diverso da lui in tutto, ma così vicino nell’anelito a restituire dignità. E nel mantenere un equilibrio retto.
Perché è proprio equilibrio un termine adeguato al libro di Lagioia. La città dei vivi è equilibrio tra cronaca e riflessione, tra fatti e partecipazione, tra coinvolgimento e giudizio. Tra giornalismo e letteratura.
di Giulia Galeotti
Osservatore Romano